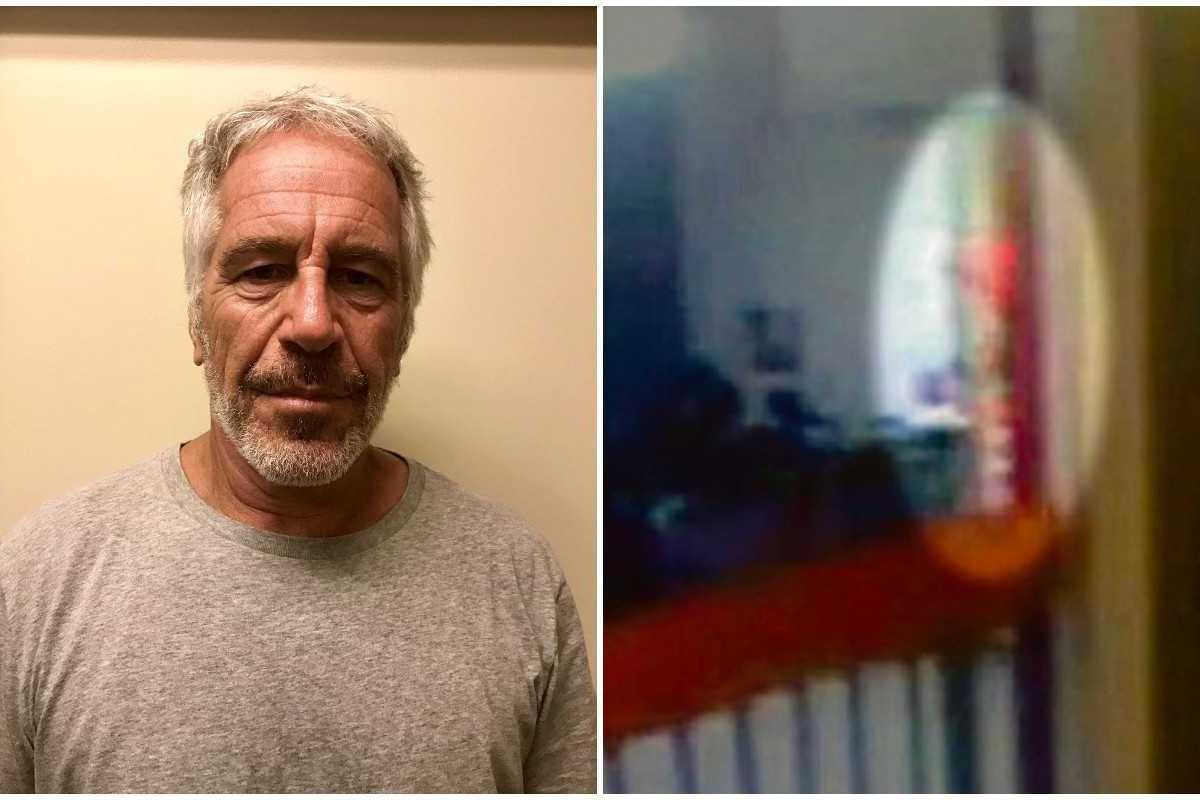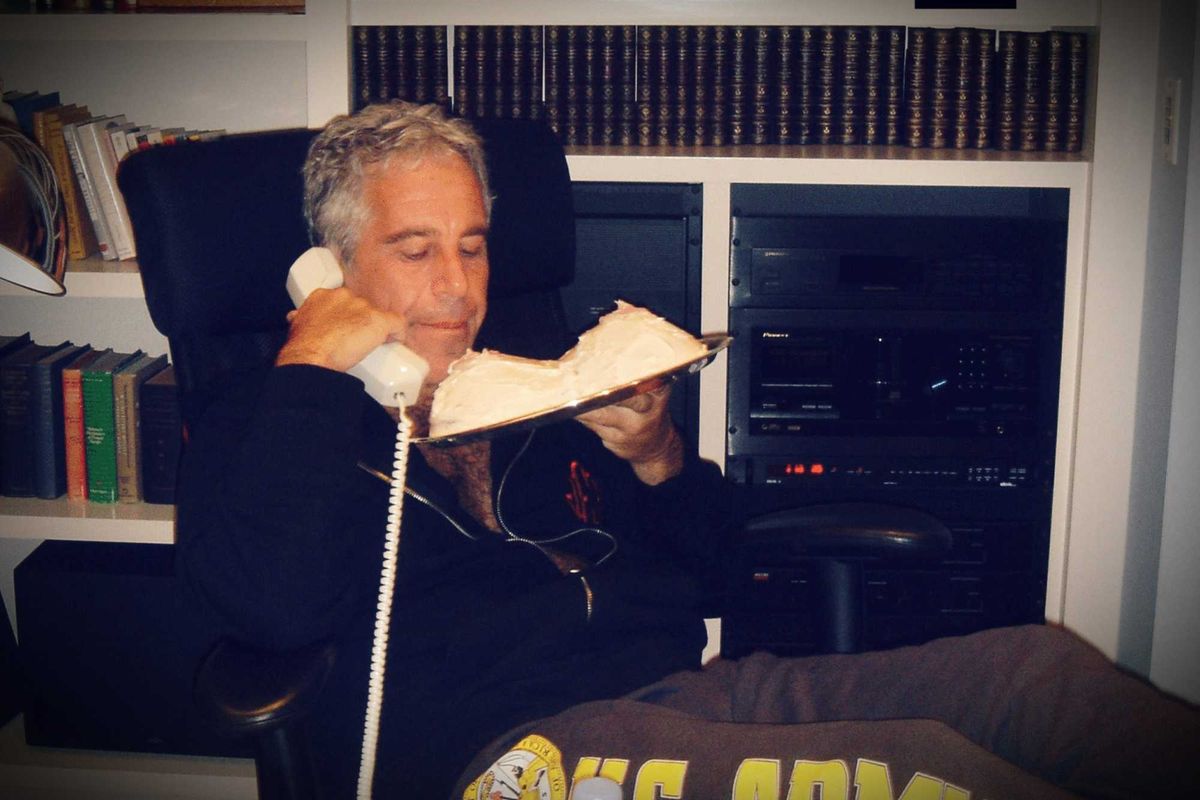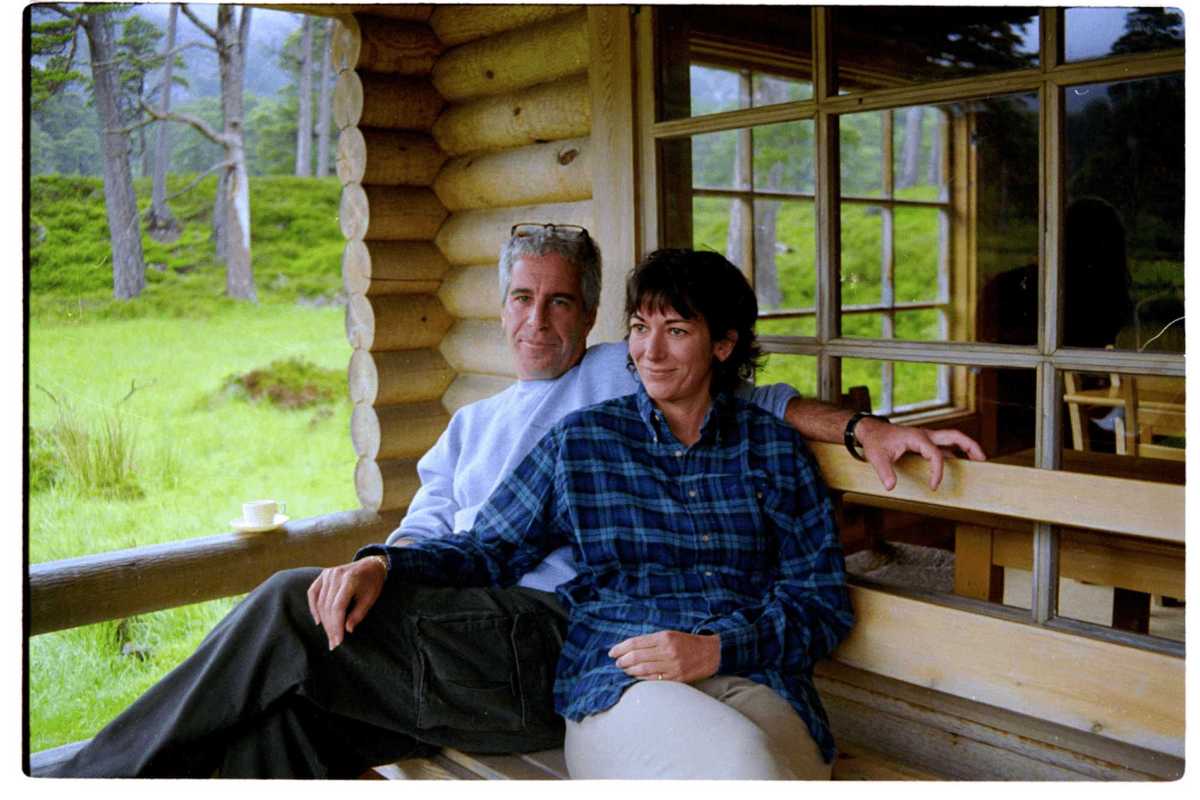La Libia, passateci il termine, esporta due prodotti. Il primo si chiama principalmente gas. Il secondo copre il mondo del traffico di clandestini. Entrambe puntano all’Italia e all’Europa. La stabilità, i conflitti e la capacità di triangolare le varie tribù sono un elemento essenziale per trovare un equilibrio tra i due diversi flussi. Più i governi della Libia traballano più è facile che il primo flusso energetico diminuisca e aumenti il secondo. In questi anni il lavoro dell’Italia è stato intenso. A dirlo sono i numeri. L’export energetico è cresciuto pur in una complessiva stabilità. Il numero degli sbarchi ha visto un importante calo. Nei primi sei mesi del 2023 il numero complessivo è stato di 75.500 unità. Nel semestre dello scorso anno di circa 30.000 unità e nello stesso periodo di quest’anno di circa 32.000.
Nel primo semestre del 2023 dalla Tripolitania verso l’Italia sono partiti 13.513 tra profughi e clandestini. Dalla Cirenaica circa 15.500. Per un totale di 29.000 circa. Nel 2024 il numero è sceso a 17.000 unità e nel primo semestre di quest’anno si è tornati a circa 29.000 unità complessive. Al tempo stesso, il numero di partenze bloccate a monte, cioè in Libia, è fortemente diminuito. Così come è sceso quello delle partenze dalla Tunisia, correlate alla situazione di Tripoli. Si è passati da oltre 90.000 persone nel 2023 a oltre 100.000 lo scorso anno a poco più di 38.000 nel 2025. Non ci vuole molto a capire che, nonostante le continue fibrillazioni in Libia, lo schema messo in piedi da chi si occupa di sicurezza e dal titolare del Viminale funziona. Certo, ci sono alti e bassi oltre a enormi difficoltà. Il caso del rimpatrio forzato da Bengasi del Commissario Ue e del gruppo di ministri europei, compreso Matteo Piantedosi, dimostra al di là dei dati di cronaca che a far incrinare il sistema è stato il modello multilaterale sotto il cappello Ue. La presenza del Commissario e il blitz del governo di Khalifa Haftar ha portato quest’ultimo a tentare la foto opportunity per spingere Bruxelles a riconoscere l’esecutivo della Cirenaica. Il blitz non è riuscito e l’aereo ha girato il muso ed è ripartito. Un fallimento? No. Si è trattato solo di un segnale di adattamento. Da ambo i lati. Ribadiamo: i numeri dicono che il sistema funziona. Ora bisogna vedere se reggerà a future esplosioni. A nuove exploit bellici. Non è un esercizio di retorica, ma stando anche agli alert americani una eventualità vicinissima nel tempo. Washington ha lanciato l’allarme per lasciare la Libia: lo scontro armato tra il governo di Dbeibah e la milizia Rada, divenuta famosa attraverso il nome di Osam Almarsi, appare imminente. Due giorni fa il Dipartimento di Stato Usa ha alzato il livello di alert al grado 4, il più severo. Sono stati invitati i cittadini a stelle e strisce a lasciare il Paese. E stavolta non è una formalità.
«Il premier non ha più accesso sicuro nemmeno all’aeroporto di Mitiga, segnale evidente della perdita di controllo sulla capitale, su cui vuole recuperare e in fretta», spiega alla Verità Daniele Ruvinetti, esperto di Libia e advisor di Med-Or. «Il Gnu (governo riconosciuto, ndr) prova a rassicurare gli alleati, sostenendo che si tratterà di un’operazione rapida, ma la realtà è ben più instabile: Misurata è divisa, con solo una parte disposta a combattere per Tripoli, mentre il premier Dbeibah spera in un sostegno perché sa che Rada ha ottime capacità militari», aggiunge Ruvinetti. Senza dimenticare che il rischio che Haftar colga l’occasione per avanzare verso la capitale è concreto. «Alcune milizie tripoline», prosegue l’esperto, «potrebbero addirittura non ostacolarlo in questo caso, in uno scenario che ricorda il 2019, quando l’offensiva fu almeno in parte tollerata dagli Stati Uniti». Oggi, la mossa potrebbe godere anche di un tacito via libera da Ankara (con cui la famiglia Haftar sta stringendo i collegamenti), e molto probabilmente di una spinta russa. «In questo contesto, Unsmil (la missione Onu, ndr) appare sotto pressione e tenta un’accelerazione del processo politico, con una nuova iniziativa prevista già per il 5 agosto», conclude. In fondo, il governo di Tripoli nasce per portare il Paese alle elezioni. Che sarebbero dovute avvenire nel 2019. Sono passati sei anni e non è successo nulla. Motivo in più per immaginare l’esecutivo tripolino al momento più basso della curva. Le prossime settimane vedranno nuovi scontri militari, ma anche il riposizionamento delle pedine e l’onda lunga del Patto di Abramo. Gli accordi tra casa Bianca, Gerusalemme e Riad hanno cambiato l’equilibrio non solo a Gaza, in Libano, in Iran, ma in tutto il Medio Oriente. Hanno coinvolto Mosca per gestire il nucleare di Teheran, ma hanno anche schiacciato le mire di Ankara nell’area. Non è un caso che i fiammiferi si riaccendano in Libia. A dargli fuoco è anche Recep Tayyip Erdogan che, stretto nell’entroterra, punta di nuovo al Mediterraneo. Per noi non sarà facile.