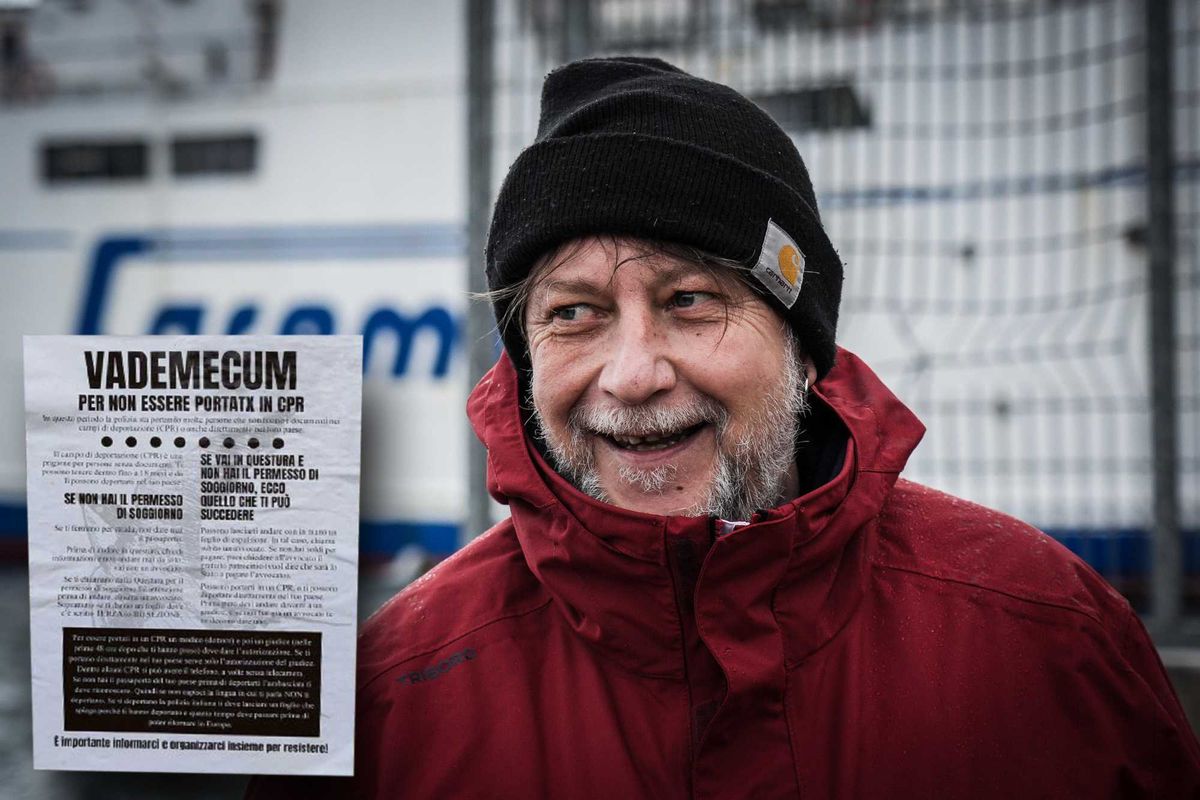Si scrive con una o due «p»? Sopressa o soppressa? Prima di dare la parola agli esperti della lingua, lusinghiamo il palato dei golosi mettendo in guardia, allo stesso tempo, vegetariani e vegani: ogni virgola di questo articolo emana l’intenso profumo della regina dei salumi veneti. Ai primi stimolerà l’acquolina, ai secondi provocherà fastidio. Chi ha buon olfatto, inoltre, sempre che la sopressa sia fatta secondo gli antichi usi della civiltà contadina, come piace a noi che di quella cultura ci riteniamo debitori, percepirà un sentore di aglio tutt’altro che sgradevole, anzi, piacevole. Questi nostri tempi che vivono con la puzzetta sotto il naso hanno, purtroppo, bandito la spezia che veniva calibrata con giudizio dal norcino nell’impasto suino e che serviva a conservare, stagionare e condire i salumi, ma che aveva anche proprietà terapeutiche, magiche - l’odore, si pensava, teneva lontani gli spiriti maligni - ed energizzanti. Alessandro Magno dava la carica ai suoi soldati con l’esempio e con l’aglio: «Mangiate spicchi in quantità, troverete maggior vigore nel combattere». Il condottiero macedone, in pratica, conquistò il mondo con la forza della spada e… dell’alito.
Ma torniamo alla questione iniziale: «p» o «pp»? Nell’Enciclopedia dei prodotti tipici d’Italia, Davide Paolini scrive la voce «soppressa» con due «p», ma il gastronauta riporta anche il sinonimo «sopressa» e la «soppressata», insaccato parente stretto della nostra, puntualizzando che nel Triveneto il salume è chiamato con i primi due nomi mentre in altre Regioni italiane - Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana - è denominato soppressata o con voci dialettali attinenti: soperzata, suppressada, supprissato. Entrambi i termini, sopressa e soppressata, indicano la pressione usata per introdurre a forza l’impasto del maiale nel budello. In certi casi la parola soppressata fa riferimento a una particolare tecnica di lavorazione che prevede lo schiacciamento della salsiccia tra due tavolette di legno o posta sotto un peso.
La soppressata sale agli onori della letteratura nel 1517 con Teofilo Folengo, alias Merlin Cocai, scrittore maccheronico nato a Mantova alla fine del Quattrocento. Nel Baldus Folengo narra le avventure di un rodomonte campagnolo in una terra, quella dei contadini padani, fatta di miseria, di fame e di sogni, di paesi di cuccagna dove chi meno lavora più magna cibi rari e preziosi, tra questi i «persuttos» d’Abruzzo, le «supressadas» di Napoli e altre leccornìe.
«In quanto alla sopressa», dice Gian Domenico Mazzocato, scrittore trevigiano, laureato in storia con una tesi proprio sul Folengo, «il problema non esiste per noi veneti che le doppie le mangiamo come se fossero fette di salame. Il veneto spappola le doppie, le mastica e la sopressa porta un nome “masticato”, più legato alla tavola, alla gastronomia, al cibo tipico fatto ancora con procedimenti artigianali, che al vocabolario. La soppressata, invece, guarda all’etimologia richiamando la tecnica di lavorazione, il salume pressato, posto sotto un peso, come avviene nella soppressata calabrese». Mazzocato, come il Folengo, è l’autore di un poemetto, Sopresseide, che racconta nella lingua di San Marco, vita e miracoli del paradisiaco salume che tanta bontà ha regalato e continua a regalare al popolo dei campi: una sorta di «Narrami diva» dove la dea è questo grosso insaccato di forma cilindrica, leggermente arcuato, di peso tra gli 800 grammi e i sei chili (!) con la fetta di un bel rosa rinascimentale al taglio. L’epopea dell’insaccato è contenuta nel libro Sopressa, salama regina nel quale oltre alle note storiche e poetiche dello scrittore trevigiano c’è una serie di ricette a base di sopressa del concittadino macellaio Bruno Bassetto.
Da Treviso a Vicenza il passo è breve. La città di Andrea Palladio rivendica per il suo territorio il primato e la primogenitura della sopressa mettendo in campo l’autorità di Bruxelles: l’Europa ha dato la Dop, la denominazione di origine protetta, alla nostra sopressa e guai a chi ce la tocca. E per non sgarrare dai principi del disciplinare di produzione (la sopressa dev’essere rigorosamente prodotta con le parti magre di maiali nati, allevati e macellati nell’area compresa tra le Piccole Dolomiti, i Colli Berici e l’Altopiano di Asiago) è stato posto un picchetto di guardia, il Consorzio di tutela della sopressa vicentina Dop. A parte, poi, le feste e le sagre che il territorio vicentino dedica al salume osannato come un santo patrono - a Valli del Pasubio, paesone ai piedi dell’omonimo monte, si celebra la festa dell’insaccato da 55 anni - c’è una straordinaria opera d’arte rinascimentale che, sempre secondo i berici, testimonia il primato di Vicenza, il cui nome, a quanto pare, deriva dal participio latino vincens, vincente, sulla sopressa. È la tela dipinta nel 1577 da Jacopo e Francesco Da Ponte, chiamati i Bassano perché nati a Bassano del Grappa, in terra vicentina ai piedi del monte sacro alla patria per i fatti legati alla guerra del 1915-18. L’opera, intitolata Cristo in casa di Marta, Maria e Lazzaro, mostra Gesù che entra in un ambiente signorile dopo il miracolo della resurrezione di Lazzaro, accolto dalle sorelle del redivivo. Il locale è una cucina del Cinquecento dove tra rami, piatti di peltro, vetri preziosi c’è ogni bendidio da cuocere per ben accogliere a mensa il Maestro: pesci (simbolici), anatre già spellate, pollame vario. Una serva sta attizzando il fuoco nel camino rinascimentale mentre seduto a tavola, la guarda un personaggio importante con una papalina rossa in testa (Lazzaro?) che sta inequivocabilmente affettando un salume. A Vicenza non hanno dubbi: quella è la nostra sopressa, la regina degli insaccati.
Verona risponde alle sopressa vicentina con la soppressa scaligera, raddoppiando le «p» dell’importante salume. In più, nell’Est scaligero, terra di vigneti e di colli armoniosi, la soppressa (d’ora in poi con due «p») è abbinata a un vino che le si addice, che le porta in dote l’armonia: il Soave. Sui Lessini, nelle valli d’Illasi e d’Alpone, tra borghi turriti, in un mare di viti, si inerpica la Strada del vino di Soave che diventa anche la strada della soppressa veronese. «Tra i compiti della Strada del vino Soave», spiega Stefano Alberti, il presidente, «c’è la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, tra cui la soppressa. È un insaccato che da moltissimi anni viene preparato non solo da contadini e produttori ma anche da privati appassionati del salume». La Strada del Soave s’inerpica fino ad arrivare a un piccolo borgo sul monte Calvarina, al confine con Vicenza, a 500 metri d’altezza: Brenton. Qui le «p» non contano più, una, due non fa differenza. Potrebbero essere anche tre o quattro tanta è la bontà delle grosse corne arcuate che pendono dai soffitti delle camere di stagionatura.
Mario Soldati in una memorabile pagina di Vino al vino la scrive con la doppia «p» e l’accompagna con un vino cavernoso che lui definisce «volpino», il clinto, vino che vanta ancora oggi un seguito di appassionati anche se è proibito dalla legge per l’alta concentrazione di metanolo. Cosa che ai tempi di Soldati non si sapeva o non si vedeva come problema: «Non darei la colazione al clinto per un pranzo da Chez Maxim», esclama il baffuto scrittore elencando i piatti della «colazione»: salami, soppresse, formaggi di varie età, polenta e boccali di clinto e clintòn.
L’ultima fetta di sopressa (così la scrive) la lasciamo ai dolci versi di Pier Antonio Quarantotti Gambini nato a Pisino, in Istria, nel 1910 quand’era ancora terra austriaca, ma scrittore, giornalista e poeta di forti sentimenti italiani. In una sua delicata poesia d’amore ha questo ricordo: «Pane, sopressa e vino / Tra un boccone e l’altro sorridevi».