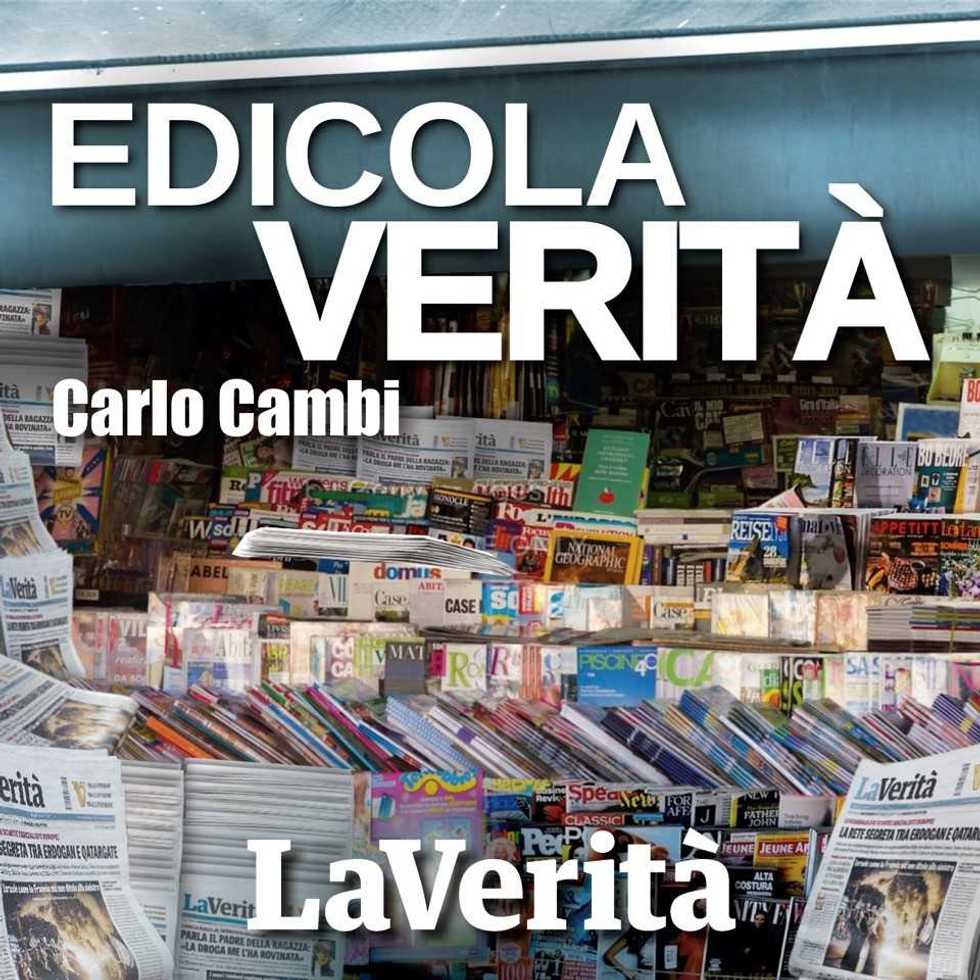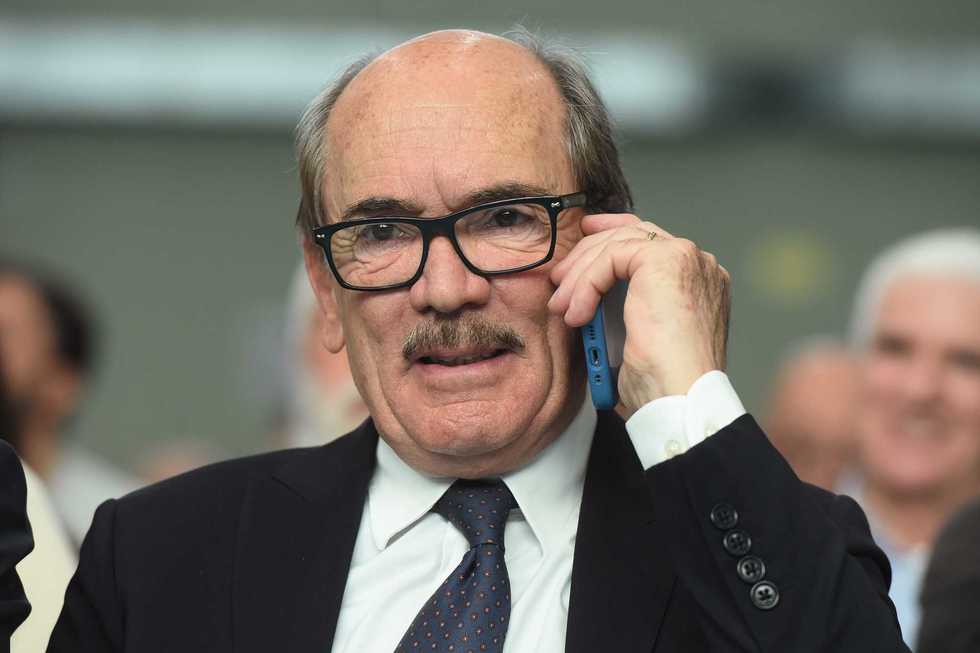Putin non c’entra, problemi di energia pure per la Francia: fermo un reattore nucleare su due

In Francia un reattore nucleare su due è fermo
Nonostante non dipenda dalle forniture russe come la Germania e l’Italia, anche la Francia deve fare i conti con problemi di sicurezza energetica, seppur di diversa natura, che contribuiscono a spingere verso l’alto i prezzi dell’elettricità.
Lunedì scorso 29 dei 56 reattori nucleari presenti nel Paese erano fermi per controlli. In parte si trattava di chiusure programmate da tempo per la manutenzione ordinaria, soprattutto quella necessaria a prolungare la vita dei reattori oltre i quarant’anni. In dodici casi invece lo stop faceva seguito al riscontro di fenomeni di corrosione alle tubature, che hanno colpito soprattutto i reattori più recenti e più potenti, e le cui cause non sono ancora ben chiare.
STOP ALL'EXPORT
«Il trattamento di queste anomalie richiederà diversi anni», ha detto martedì in un’audizione al Senato francese il presidente dell’Autorità per la sicurezza nucleare Bernard Doroszczuk. Difficile per Électricité de France (Edf), il colosso che gestisce le 19 centrali nucleari d’Oltralpe, far fronte al problema evitando ricadute sulla produzione nazionale di elettricità.
Una produzione che, del resto, è in calo da anni e che la Francia ormai non esporta quasi più all’estero. Se nel 2005 le centrali nucleari fornivano il 78 per cento dell’elettricità del Paese, nel 2020 la percentuale era scesa al 67 per cento, il livello più basso dal 1985. E se negli ultimi anni la produzione annua è rimasta sotto i 400 terawattora (una soglia piuttosto bassa), Edf prevede per quest’anno di scendere sotto i 300.
Come si diceva, i motivi del blocco di più della metà dei reattori nucleari francesi sono di due tipi, uno ordinario e uno straordinario (a questi si aggiunge l’effetto Covid: le manutenzioni programmate nel 2020 non sono state possibili, a causa dei confinamenti, e quindi Edf si è vista costretta a recuperarle in seguito, affollando il calendario dei lavori).
COLPA DI CHI?
Il motivo ordinario sono i lavori di manutenzione, che per i 32 reattori che hanno o si avvicinano ai quarant’anni d’età hanno tempi particolarmente lunghi. Per dire, una unità della centrale del Bugey, nel dipartimento dell’Ain, ha iniziato ad essere ispezionata il 31 luglio dell’anno scorso e non è ancora tornata in servizio.
«Chiudiamo i reattori per sei mesi in modo che possano funzionare per altri dieci anni, il che rappresenta il miglior investimento possibile», ha spiegato a Le Monde Valérie Faudon, della Société française d’énergie nucléaire.
Il fattore non ordinario, invece, è la corrosione dei tubi attraverso i quali deve passare l’acqua destinata a raffreddare il nocciolo del reattore nucleare in caso d’incidente. Secondo l’Autorità per la sicurezza nucleare all’origine di questo problema potrebbe esserci un difetto di progettazione dei modelli, da attribuire alla società americana Westinghouse, ma si tratta soltanto di ipotesi.
Quel che ora preoccupa il governo è che, per esaminare i reattori, le tecniche a ultrasuoni non sono sufficienti: è necessario intervenire pesantemente tagliando le tubature e questo ovviamente comporta un lungo stop alla produzione.
IMPIANTI TROPPO VECCHI
Nonostante questi problemi in Francia le voci contrarie al nucleare non sono molte. La richiesta di chiudere i reattori più vecchi è ben lontana dall’essere presa in considerazione, tanto che lo scorso febbraio in piena campagna elettorale il presidente Emmanuel Macron aveva confermato la proroga dell’uso degli impianti «al di là dei 50 anni di vita», insieme con la costruzione di sei nuovi reattori, un progetto del valore di 50 miliardi di euro (e altri otto reattori «sono allo studio», aveva aggiunto).
L’obiettivo è portare la capacità complessiva degli impianti a 100 gigawatt (GW) entro il 2050. Ad oggi è di 61,4 GW, ma la disponibilità effettiva è stata in media di 48 GW a gennaio ed è scesa sotto i 30 GW da fine aprile, 10-15 GW in meno rispetto agli anni scorsi nello stesso periodo. Ma secondo l’Autorità per la sicurezza nucleare la possibilità di estendere la vita dei reattori oltre il mezzo secolo è quantomeno dubbia: «In questa fase, le informazioni fornite da Edf non ci permettono di prevederlo», ha sottolineato Bernard Doroszczuk nella sua audizione davanti ai senatori.
La chiamano «resilienza democratica», perché «polizia del pensiero» sembrava brutto. Ieri, nel giorno del quarto anniversario della guerra in Ucraina, l’Ue ha lanciato il suo Centro che dovrebbe occuparsi di combattere le fake news. Ma chi pensa che si tratti solo dell’ennesimo capitolo della crociata antirussa si sbaglia. Le ambizioni sono ben più alte. «Non ci concentreremo esclusivamente sulla manipolazione delle informazioni straniere, sull’interferenza e sulla disinformazione», ha garantito Michael McGrath, che è commissario alla Democrazia, allo Stato di diritto e pure alla Giustizia.
«Ci saranno altri filoni di lavoro in cui cercheremo di investire nella resilienza democratica». Possiamo immaginare quali saranno: profilare i cittadini sui social e reprimere le opinioni scomode sull’immigrazione, su Bruxelles, sui conflitti in corso e su tutto quello che minaccia di disturbare il manovratore. È malafede? A osservare cosa già sta succedendo in diversi Paesi, c’è più di un motivo per essere diffidenti.
In Germania, ad esempio, è appena finito sotto indagine un pensionato di Heilbronn che, su Facebook, aveva osato definire «Pinocchio» Friedrich Merz. Lo scorso ottobre, l’uomo, evidentemente (e legittimamente!) adirato per il deterioramento della situazione dell’ordine pubblico in patria, aveva comunicato la propria esasperazione con un commento sotto a un post della polizia locale, diffuso in occasione di una visita del cancelliere nella città del Baden-Württemberg. L’articolo 188 del Codice penale tedesco prevede pene severe - fino a cinque anni di carcere - per le offese all’onore di politici e funzionari, se esse complicano lo svolgimento della loro attività. «Pinocchio arriva a Heilbronn»: ci credereste che un signore potrebbe finire in cella per questa frase? Nell’Europa che spaccia la sorveglianza psicopolitica per difesa della democrazia, basta poco per ritrovarsi nei guai.
Ne sanno qualcosa nel Regno Unito. La distopia laburista ha prodotto una tale quantità di pazzie, che ci si potrebbe scrivere un’enciclopedia. C’è stato il caso di Lucy Connolly, moglie di un esponente conservatore, sbattuta in galera perché su X, dopo un attentato all’arma bianca, aveva invocato l’«espulsione di massa» dei clandestini, precisando che se ne sarebbe infischiata se qualcuno l’avesse considerata razzista. Troppo ardire, per la terra che 800 anni fa promulgò la Magna charta libertatum. Keir Starmer non è stato capace di proteggere i confini dagli irregolari, però li ha interdetti all’attivista olandese Eva Vlaardingerbroek: a gennaio, è stata bandita dalla Gran Bretagna in quanto la sua presenza «non è da considerarsi favorevole al bene pubblico». Devono esserle costati cari i suoi legami con Tommy Robinson, il capofila della destra movimentista che si oppone all’invasione. D’altra parte, nella Francia di Emmanuel Macron, di recente sono stati arrestati proprio due inglesi che avrebbero incitato all’odio contro gli stranieri. Meraviglie di Internet: doveva essere il paradiso della democrazia, è diventata il mezzo per perseguire i reati d’opinione.
L’episodio surreale accaduto in Germania, intanto, ha riacceso lo scontro con gli Usa, che almeno dal discorso di JD Vance a Monaco, a febbraio 2025, strapazzano l’Europa per la sua smania censoria. Secondo il sottosegretario di Stato per la diplomazia, Sarah Rogers, l’inchiesta sull’affaire Pinocchio «somiglia a un caso di lesa maestà. La maggior parte dei tedeschi con cui ho parlato non vuole che le leggi siano applicate in questa maniera. Ma vaghe e ampie restrizioni della libertà d’espressione generano sempre casi al limite dell’abuso ed effetti raggelanti».
La Rogers è la stessa che, stando a quanto riferito alcuni giorni fa da Reuters, si sta occupando dello sviluppo di un portale online, sul quale verrebbero resi visibili i contenuti che sono stati fatti rimuovere dai governi nel Vecchio continente, o in altre parti del mondo. Il lancio del sito, che dovrebbe appartenere al dominio freedom.gov, era atteso all’ultima Conferenza di Monaco, ma per ora è stato rimandato. Sullo sfondo, c’è il serrato confronto tra Washington e Bruxelles sulle regole del Digital services act, che la Casa Bianca concepisce come una deriva oscurantista, oltre che come un tentativo di danneggiare il giro d’affari delle Big tech. Ragion per cui, negli attriti, rientra pure la partita sui dazi. Donald Trump mal sopporta anche l’analogo regolamento di Londra, l’Online safety act. E a quanto pare, non ha tutti i torti. Certo: non c’è da fidarsi ciecamente di Mark Zuckerberg e compagnia. Ma voi comprereste mai un’auto usata da chi - per il vostro bene, eh - prova a rifilarvi la «resilienza democratica»?
- Dall’esplosione di Internet al monopolio dei social assistiamo a un immobilismo istituzionale che scambia il mercato selvaggio per un fatto inevitabile. Servono regole certe per impedire che il progresso tecnologico si trasformi in una desertificazione spirituale.
- Un report ipotizza lo scenario nel 2028, dove l’eccesso di efficienza causata dall'Ia fa crollare i consumi.
Lo speciale contiene due articoli
Intorno agli anni Duemila ci fu l’esplosione di Internet. Grandi profezie, grandi preoccupazioni, soprattutto a livello di concentrazione di potere, e poi in quattro o cinque si sono spartiti il mondo e non è successo una mazza. Seconda apocalisse intorno agli anni Dieci con l’esplosione dei social. Anche lì grandi preoccupazioni economiche nel frattempo che gli stessi si spartivano anche quelli, ripartendo il monopolio in pochi (si chiamerebbe oligopolio).
Ci si pose anche il problema della dipendenza digitale e, col passare del tempo, tale problema è diventato enorme fino a contare, in Italia, intorno a 400.000 malati. Anche in questo caso sembrava, appunto, di essere davanti a un’apocalisse, sembrava che dovessero essere adottati interventi importanti, soprattutto per la fascia di età che va dalla preadolescenza alla giovinezza (non considerando che spesso i social sono diventati i veri babysitter dei bambini), ma anche qui tanto fumo e quasi nulla arrosto. Intorno al 2020, sembrano le piaghe d’Egitto ma a scadenza decennale è arrivato il momento dell’Intelligenza artificiale e anche qui, anche ultimamente, in questi giorni, sono stati pubblicati rapporti di vario genere, in particolare sul rapporto tra Intelligenza artificiale e perdita di posti di lavoro.
Ma anche in questo caso si assiste, quasi inerti, in tutto il mondo, a queste apocalissi della porta accanto di fronte alle quali si profetizzano tempi nefasti, si preannunciano catastrofi ma poi sulla politica prevale la forza economica di chi possiede e gestisce queste realtà e, alla fine, la politica urla ma lo fa da ferma, senza adottare le misure urgenti che potrebbero attenuare, se non risolvere, gli effetti negativi dell’introduzione dell’Intelligenza artificiale nei cicli produttivi. Non ci sarebbe neanche più quella che Marx chiamò l’alienazione del lavoro e cioè quella della classe operaia che, non possedendo i mezzi di produzione, si trova alienata di fronte al proprio lavoro. Ci sarebbe l’alienazione dal lavoro, cioè l’esclusione dell’uomo dai cicli di produzione fatti dalle macchine e guidati da un’intelligenza non umana ma artificiale.
Quello che sconcerta è che sembra che in questi atteggiamenti, denotati da un’alta percentuale di immobilismo politico e istituzionale - di dimensioni mondiali -, ci sia una specie di acquiescenza, come se ci si trovasse di fronte all’ineluttabile. Andrà così e non ci possiamo fare niente. Questo è totalmente falso ed è anche menzognero, cioè tende a velare di menzogne l’incapacità della politica a dettare norme al mercato. Questo è di una gravità assoluta perché anche uno, come il sottoscritto, che crede in un’impostazione liberale dei rapporti tra Stato e mercato, sa bene che, sia per motivi di storia che di teoria economica, non esiste un mercato senza regole e se esiste, prima o poi, fa danni e collassa.
La questione dell’Intelligenza artificiale, come nel caso di Internet e come in quello dei social, ma in modo più problematico, non rappresenta solo un problema di potenziale violazione delle leggi della concorrenza, considerati i pochi attori in campo e spesso costituenti un cartello (cioè un accordo economico per mettersi d’accordo sui prezzi e falsificare la competizione economica), ma comporta anche un enorme problema educativo e di formazione intellettuale e coscienziale delle persone. Bastino due esempi per capire quali sono i rischi.
Il primo esempio ci è fornito dalla formazione, e cioè da quel processo lungo e difficile che deve sviluppare nel soggetto una capacità autonoma di comprensione e di giudizio sulla realtà, la coscienza critica. Essa è il cardine dello sviluppo di una persona, perché essa è il cuore stesso della persona. Conoscenza e volontà sono alla base del comportamento consapevole: non sceglie bene chi non conosce le varie alternative della scelta; non conosce bene chi, di fronte a una scelta, più che alla propria volontà, si affida a quello che il filosofo tedesco Martin Heidegger chiamava il «si dice». Voleva indicare con esso la passività del soggetto di fronte all’opinione comune e la riduzione della coscienza a tale opinione. Quando i giovani di oggi si affidano all’Intelligenza artificiale, magari inconsciamente, vivono una sorta di alienazione dalla propria coscienza, dalla propria interiorità, dalla propria mente e dal proprio io. Non occorre che spieghi alle lettrici e ai lettori gli effetti devastanti che può avere, nei tragitti descritti dalla psicologia evolutiva, questo tipo di appalto dall’intelligenza naturale a quella artificiale.
Il secondo esempio viene da recenti parole di papa Leone XIV che, rivolgendosi ai sacerdoti di una zona di Roma, ha esplicitamente chiesto di non affidarsi all’Intelligenza artificiale nella scrittura delle proprie omelie o prediche, che dir si voglia. E qui siamo nell’assurdo di soggetti che dovrebbero essere guidati dallo Spirito e si affidano a uno spirito inesistente che mai esisterà, perché mai l’Intelligenza artificiale ne sarà dotata. In questo caso ci sarebbe da fare una lunga riflessione teologica e anche spirituale, ma non abbiamo lo spazio sufficiente per farlo. Lo faremo in un’altra occasione. Basti dire che se il Papa è arrivato a richiamare i sacerdoti su questo punto vuol dire che ha cognizione che ciò stia già avvenendo. Francamente ci è incomprensibile come chi dovrebbe essere la voce dello Spirito non riesca a comprendere l’oltraggio nei confronti dei fedeli di ridire in modo pappagallesco ciò che i Padri della Chiesa sostenevano che dovesse procedere attraverso lo stesso procedimento che per gli animali si chiama ruminatio, cioè un processo di assimilazione lenta, profonda, ma soprattutto spirituale, del Verbo di Dio. Se non lo capiscono loro, cosa possiamo aspettarci da chi pensa solo a questioni di profitto?
L’Intelligenza artificiale fa tremare: disoccupati al 10% e Borsa giù del 40%
Un vecchio film di Alberto Sordi (Io e Caterina) immagina un robot che lava e stira sostituendo la domestica e, soprattutto, la moglie. Citrini Research, alza il tiro, trasformando la commedia in tragedia.
Nel fine settimana la semisconosciuta società di ricerche ha pubblicato un rapporto che sembra un film di fantascienza in formato «noir». È ambientato nel giugno 2028, quando l’Intelligenza artificiale avrà rivoluzionato l’economia mondiale, lasciando dietro di sé disoccupazione in crescita al 10%, azioni in caduta del 40% e consumatori paralizzati dal panico. Tra i settori più vulnerabili, Citrini indica i servizi di consegna di cibo a domicilio e le società di carte di credito. Il rapporto non lascia spazio a dubbi: in soli due anni, il predominio di app come DoorDash e Uber Eats sarà sostituito da alternative «vibe-coded»: strumenti digitali capaci di vendere uno stile di vita prima ancora di consegnare una pizza o un sushi.
Per gli investitori, un’immagine da incubo: immaginate un algoritmo che vi promette felicità, avocado toast e yoga virtuale, mentre il vostro algoritmo preferito per le consegne a domicilio finisce nella soffitta digitale. Non meno colpiti, secondo Citrini, sarebbero i colossi dei pagamenti come Mastercard e Visa. Gli algoritmi di Ia potrebbero eliminare del tutto le commissioni, facendo risparmiare i consumatori ma lasciando a secco i gestori di carte di credito. In pratica: il robot salva il consumatore ma fa piangere l’investitore. E non importa se molto spesso sono la stessa persona.
Non si salvano nemmeno i mattoni. Nel settore immobiliare, dove gli acquirenti avevano tollerato commissioni del 5-6% per decenni, l’Ia ha dimostrato che la conoscenza umana può essere replicata in un battito di byte. Citrini indica che già ora la commissione mediana sul lato acquisto nelle principali aree metropolitane si è compressa dal 2,5-3% a meno dell’1%. Nel frattempo la quota crescente di transazioni ha chiuso senza intervento umano. Insomma: gli algoritmi hanno trasformato l’agente immobiliare in una semplice comparsa digitale.
Secondo Citrini, il boom dell’Ia superintelligente farà strage di colletti bianchi, porterà un calo della spesa per consumi e insolvenze sui mutui che diventerà difficile rimborsare. Le azioni dei settori più esposti hanno subito un tracollo immediato. Lunedì l’Etf che raggruppa le società di software ha ceduto fino al 5%, DoorDash ha perso oltre il 6%, American Express oltre il 7%. Mastercard e Visa tra il 4 e il 5% Uber oltre il 4%.
E se qualcuno pensava che la tecnologia fosse gentile con i dinosauri digitali, Ibm ha dato una lezione memorabile: il titolo ha registrato il peggior crollo giornaliero degli ultimi 25 anni: meno 13%, dopo l’annuncio della startup Anthropic secondo cui il suo sistema Claude Code può modernizzare Cobol, il linguaggio di programmazione vintage ancora in uso sui sistemi Ibm. Un promemoria per dire che nemmeno i giganti più solidi sono immuni quando l’Intelligenza artificiale decide di fare il salto di qualità.
«Per tutta la storia economica moderna, l’intelligenza umana è stata il fattore produttivo più scarso. Ora quel vantaggio declina», scrive Citrini con ironia tagliente. Ed è qui che entra in gioco il vero paradosso umano: se l’Ia elimina le inefficienze, riduce i costi e ottimizza ogni singola transazione, chi continuerà a lavorare? E soprattutto, chi consumerà?
Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, spiega: «L’economia mondiale si basa su inefficienze “umane” che l’Ia sta azzerando, togliendo lavoro ai colletti bianchi e a tutti coloro che di queste inefficienze campano. Le difficoltà dei vari settori ricadono su chi li ha finanziati. Ma se nessuno ha un lavoro e nessuno può consumare perché produrre ancor?». Forse il quadro disegnato da Citrini è fin troppo apocalittico.
- Ursula von der Leyen chiede che venga riparato l’oleodotto Druzhba, distrutto dai russi. Impossibile per Kiev a livello di costi e vite.
- Torna in mare la Sumud Flotilla e con lei parte pure Open Arms.
Lo speciale contiene due articoli
Quattro anni di guerra e quella avvilente sensazione di stallo totale: la Russia, seppure lentamente, avanza, l’Ucraina resiste grazie agli aiuti occidentali ma il recupero dei territori persi è un’utopia, gli Usa si sono praticamente disimpegnati e il cerino in mano è rimasto all’Europa, manco a dirlo divisa al suo interno, anche perché Ucraina e Slovacchia non vogliono (e non possono) rinunciare al petrolio russo. «La guerra in Ucraina», ha scritto ieri su X il presidente francese Emmanuel Macron, «è un triplice fallimento per la Russia: militare, economico e strategico. Mentre il Cremlino aveva promesso di conquistare l’Ucraina in pochi giorni, solo l’1% del territorio ucraino è stato conquistato, e Kiev ha persino riconquistato un po’ di terreno. A quale costo per i russi? Oltre 1,2 milioni di soldati russi sono stati feriti o uccisi: il numero più alto di vittime russe in combattimento dalla Seconda guerra mondiale. La guerra della Russia», ha aggiunto Macron, «ha rafforzato la Nato, di cui cercava di impedire l’espansione, ha unito gli europei che mirava a indebolire e ha messo a nudo la fragilità di un imperialismo obsoleto». Unito gli europei, ma mica tanto: di fronte ai proclami di Ursula von der Leyen e dei governi schierati sulla linea della resistenza, Mosca fa la voce grossa: «Gli obiettivi dell’operazione militare speciale», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, «non sono stati ancora pienamente raggiunti, quindi l’operazione continua. La Russia rimane aperta a raggiungere i suoi obiettivi con mezzi politici e diplomatici.
Il lavoro in questo campo continua, gli interessi della Russia saranno garantiti in ogni caso». In sostanza, il Donbass sarà nostro, con le buone o con le cattive, fa sapere Vladimir Putin. Dicevamo delle divisioni interne alla Ue: ieri la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha firmato il prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di euro a nome del Parlamento europeo per «per sostenere i servizi pubblici essenziali in funzione, per mantenere forte la difesa dell’Ucraina, per salvaguardare la nostra sicurezza e libertà condivise, per conseguire una pace reale e duratura e per ancorare il futuro dell’Ucraina in Europa». Ma il prestito è bloccato dal veto del premier ungherese Viktor Orbán, che nonostante il suo via libera al Consiglio europeo di dicembre, un semaforo verde arrivato attraverso una assenza «tecnica», assieme a Repubblica Ceca e Slovacchia, ora vuole bloccare tutto. Pietra del dissidio tra Ungheria e Slovacchia da una parte e il resto dei 27 dall’altra, l’oleodotto Druzhba, che porta il petrolio a Budapest e Bratislava e che è stato seriamente danneggiato durante la guerra, con diversi attacchi soprattutto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
Niente petrolio, niente prestito: ieri, attraverso una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che lo aveva sollecitato a rispettare le decisioni della Ue, sottolineando che «qualsiasi violazione di tale impegno costituisce una violazione del principio di leale cooperazione», Orbán ha risposto a muso duro: «I fatti sono fatti», ha sottolineato il leader ungherese, «non ci sono ostacoli tecnici alla ripresa dei trasferimenti di petrolio all’Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba. Richiede solo una decisione politica dall’Ucraina. Come sai, sono uno dei più disciplinati e fattuali membri del Consiglio europeo», ha aggiunto Orbán rivolgendosi a Costa, come scrive Public Policy, «comprendo pienamente le tue preoccupazioni. Ma di certo vedrai anche l’assurdità della situazione: noi prendiamo una decisione finanziaria a favore dell’Ucraina che io personalmente disapprovo, poi l’Ucraina crea una emergenza energetica in Ungheria e tu mi chiedi di fare finta che non sia successo nulla. Gli ucraini sanno esattamente cosa fanno e perché lo fanno. Lo fanno per rovesciare il nostro governo e sostituirlo con uno favorevole a Kiev. Non sosterremo il blocco petrolifero ucraino, lo romperemo. Di questo possono essere certi sia a Bruxelles sia a Kiev».
Sulla stessa linea dura la Slovacchia, che lunedì scorso ha sospeso l’assistenza elettrica d’emergenza all’Ucraina, in attesa della ripresa delle forniture di petrolio. Confusa e infelice, come di consueto, Ursula von der Leyen: la presidente della Commissione ieri ha detto che l’Ucraina dovrebbe «accelerare» la riparazione dell’oleodotto Druzhba, e pochi secondi dopo lo stesso Volodymyr Zelensky, accanto a lei in conferenza stampa, l’ha gelata: Riparare l’oleodotto Druzhba, che è stato «distrutto dai russi», ha detto il presidente ucraino a quanto riporta l’Adnkronos, «costerebbe all’Ucraina in termini di persone, un prezzo molto alto da pagare. Sta a Viktor Orbán parlare con Vladimir Putin: non può essere che la Russia distrugge, l’Ucraina ripara e poi la Russia attacca ancora, mentre stiamo riparando le infrastrutture. Nel caso dell’oleodotto Druzhba», ha aggiunto Zelensky, «è già successo una volta, e ci sono stati feriti tra il personale inviato a rimediare ai danni causati dai russi. Quindi dovremmo riparare per cosa? Per perdere gente? E’ un prezzo molto alto». Si brancola nel buio, dunque, mentre anche dalla Conferenza episcopale dei vescovi arriva l’invito a perseguire le strada dei negoziati: «Quattro anni», ha detto ieri il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, «di enormi sofferenze. Quindi, speriamo che finiscano presto. Dobbiamo spingere tutti quanti e speriamo che anche l’Europa scelga di aiutare più che può la composizione, il dialogo per mettere fine a questa tragedia, che ogni giorno che passa vuol dire persone che non tornano a casa e sofferenze che durano tutta quanta la vita. L’impegno è questo e speriamo anche che l’Europa scelga diciamo una presenza ancora più forte». Fino ad ora l’Europa ha spinto più per continuare la guerra che per cercare la pace. A quattro anni dall’inizio del conflitto, questo è un dato di fatto incontrovertibile.
La coalizione per portare aiuti (durante la prima missione davvero pochi) a Gaza
Open Arms sta annunciando ai quattro venti che il 12 aprile salperà da Barcellona per Gaza. Assieme a movimenti globali come Maghreb Sumud Flotilla, Global Movement to Gaza, Sumud Nusantara, People's Flotilla Movement e sostenuta da organizzazioni locali e internazionali, prenderà parte alla missione primaverile della Global Sumud Flotilla.
Coalizione «nata come risposta diretta alle richieste dei palestinesi di Gaza», e che attraverso un tam-tam mediatico compiacente rimette in mare piccole (costose) imbarcazioni «per rompere l’assedio illegale imposto dall’occupazione israeliana a Gaza» e portare aiuti umanitari. La scorsa estate si era visto il flop della prima spedizione proprio nel portare viveri e medicinali.
Trasportavano «una quantità irrisoria» di beni, «inferiore a quella contenuta in un singolo camion», denunciò a ottobre l’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled. Quella di Flotilla era poco più che una provocazione politica, come lo sarà anche la crociera d’aprile al di là degli accorati appelli ad aiutare in concreto la popolazione di Gaza. L’ha dichiarato la stessa portavoce, Maria Elena Delia, spiegando la portata della nuova missione «la più ampia mai realizzata in questo contesto: oltre cento imbarcazioni, più di tremila partecipanti provenienti da oltre cento Paesi, almeno mille operatori sanitari insieme a ingegneri, educatori, osservatori dei diritti umani e giornalisti».
Al quotidiano online Faro di Roma ha però precisato «Ripartiamo perché riteniamo che il silenzio e la normalizzazione siano ormai parte del problema. La nostra missione vuole interrompere questa dinamica: riportare l’attenzione sulla realtà, riaffermare la centralità dei diritti umani e impedire che la crisi di Gaza venga trasformata in una condizione permanente accettata dal mondo».
L’aveva osservato uno come Simone Perotti, fondatore di Progetto Mediterranea e sempre pronto a partire, scrivendo lo scorso agosto sul Fatto Quotidiano che non si sarebbe unito alla flotta. Per diversi motivi: «Nemmeno un pacco di farina verrà recapitato ai palestinesi, ne possiamo essere certi. E poi non condivido la logistica, che sembra più imposta dall’esigenza di spettacolarizzazione che dal senso economico e organizzativo di ogni impresa». Perché partire da porti così lontani da Gaza come Barcellona, scriveva, perché «sperperare centinaia di migliaia di euro in materiali, gasolio, pezzi di ricambio».
Con il protagonismo di chi salpa, aggiungiamo noi, in una missione sicuramente molto lontana dalle esigenze dei palestinesi. Eppure, Open Arms sostiene di muoversi perché «l’invasione, il genocidio continuano», così come attacca la politica migratoria europea per le morti nel Mediterraneo «conseguenza di decisioni politiche convenienti, codarde e disumane». Assieme a World Central Kitchen, organizzazione fondata dallo chef José Andrés, ha già realizzato due missioni verso Gaza.
La Ong, fondata e diretta dall’attivista catalano Òscar Camps, riceve sempre il sostegno, anche finanziario, dell’attore Richard Gere che assieme alla moglie Alejandra era in prima linea ai festeggiamenti dello scorso settembre per i dieci anni di Open Arms. Gere appoggia Flotilla, così come nel 2019 era salito sull’imbarcazione per «portare solidarietà» ai migranti che la Ong voleva a tutti costi far sbarcare a Lampedusa e non portare in Spagna, come invece doveva fare secondo quanto stabilito dal Tribunale di Palermo che ha assolto il vicepremier Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno.