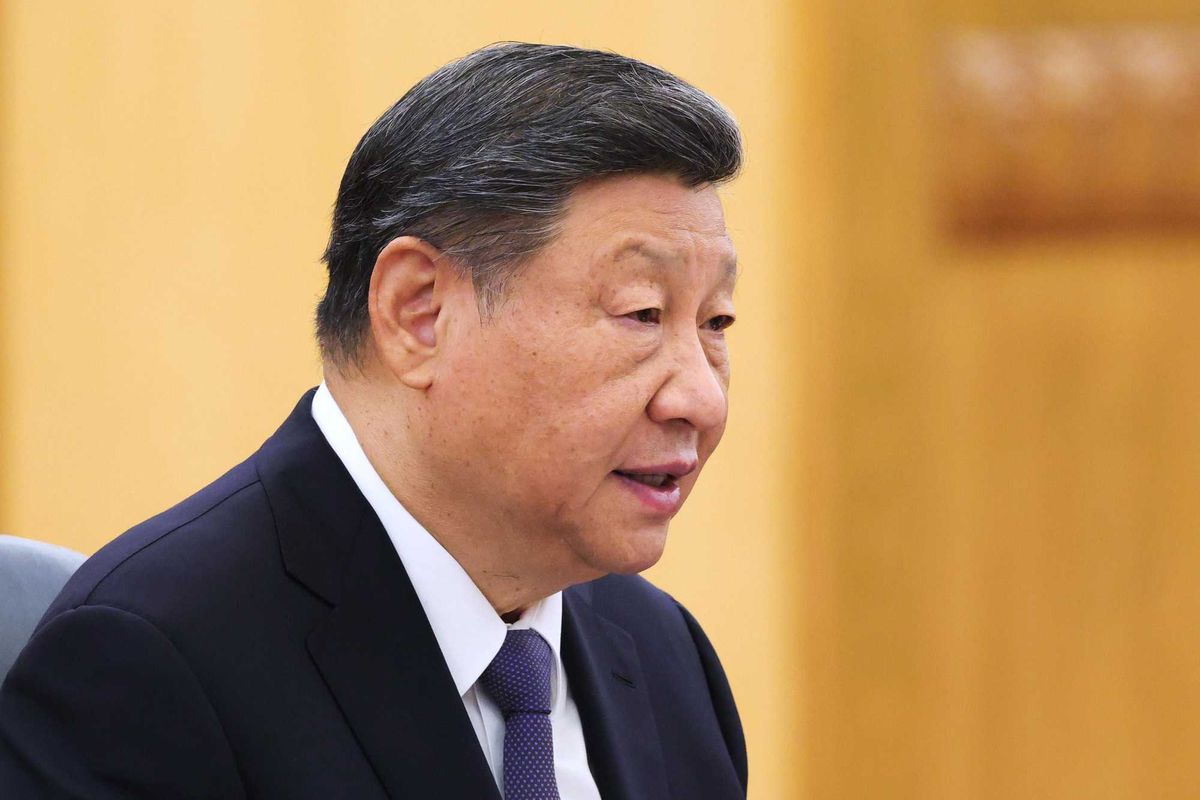- Lo smart working rivaluta i luoghi alternativi agli spazi urbani dove trovare prezzi bassi, migliori rapporti sociali, aria pulita, natura a portata di mano. Secondo uno studio Usa ne guadagna anche la condizione fisica perché ci si ammala meno, soprattutto le donne.
- Giovanna Visintini insegna diritto civile a Genova tenendo salde le radici nel casale di famiglia sul Garda «Ho scritto un libro di ricette adatte solo alle cucine grandi come quelle di una volta».
Lo speciale contiene due articoli
Il disegnatore satirico Stefano Disegni ha scritto e interpretato con il gruppo Ultracorpi un’ilare canzone che risolveva il dilemma del cittadino stressato tra vita in campagna o in città, dopo l’esperienza campagnola, a favore della città. «E sto ancora qua in mezzo alla campagna, / riarrostisco una castagna, / riannuso i rosmarini, riascolto gli uccellini, / m’illumino d’immenso e vabbè, sì, ma dopo che c’è?! / E ariosservo l’airone reale, / e arifaccio la foto al cinghiale, / e ariascolto il respiro del vento, / ogni giorno un po’ meno contento perché… / ammazza che lagna la vita qua in campagna» era l’introduzione all’urlo «Voglio un televisore, / voglio un videoregistratore» e la successiva esaltazione di attività urbane come rimorchiare (corteggiare) le commesse e imbottirsi di compresse. Dopo quel caustico ripudio della vita agreste (la canzone è degli anni Novanta), in campagna sono arrivati i videoregistratori e anche il più attuale wifi. Tantissimi, con la pandemia e l’avvento dello smart working, hanno rivalutato la campagna come luogo alternativo alla vita e al lavoro in città.
il tasso di felicità
Il dilemma esisteva anche prima. Un’indagine canadese del 2018 ripresa anche dal Daily Mail ha esaminato il tasso di felicità degli abitanti metropolitani e di piccole cittadine nel verde. Chi vive nelle grandi città ha stipendi più alti, maggiore livello di istruzione e minor tasso di disoccupazione, ma anche meno rapporti sociali ed è 8 volte meno felice rispetto all’abitante di provincia. Inoltre, comprare una casa di città è molto più costoso che in campagna, dove anche tutti gli altri aspetti della vita costano meno. La questione non riguarda solo il dare/avere del portafogli: anche quello della salute. Il desiderio di tornare a vivere in campagna si radica sempre più e la soluzione del dilemma oggi è opposta a quella del divertissement di Disegni: in campagna si vive meglio che in città.
Ma siccome non tutti possono trasferirsi in campagna, si cerca di trasferire il buono della campagna in città. Il libro Outdoor. Vita e cucina all’aperto, Slow Food editore, è un vademecum di suggerimenti per inserire nella propria routine quotidiana urbana momenti o intere giornate outdoor. Vacanze? In campeggio, «avventure a passo lento» come i cammini e, in generale, viaggiare slow, con lentezza. Cibo? Incentivare il mangiare e il ricevere all’aperto, organizzare grigliate (si possono fare anche in alcuni parchi) e picnic nelle aree verdi della città. E poi foraging, la raccolta di erbe spontanee, e benessere all’aria aperta (fare sport in un’area verde è diverso che farlo chiusi in palestra). Poi gli orti urbani, piccoli appezzamenti di terra comunale da concedere in locazione a privati che vogliano sperimentare l’agricoltura in prima persona: «Prendersi cura di un orto non è solo un piacevole passatempo all’aria aperta ma un’attività dai numerosi benefici», spiega il libro, come ritrovare il contatto con la natura, tenersi in movimento, allontanare lo stress, produrre endorfine, educarsi all’attesa e alla pazienza.
Non si starà esagerando con l’esaltazione della campagna? Pare di no. Uno studio della Harvard T.H. Chan school of public health su 100.000 donne statunitensi ha mostrato che le residenti in campagna vivono di più e meglio, presentando un tasso di mortalità per cancro inferiore del 13% e per malattie respiratorie inferiore del 34% rispetto alle donne di città. La minore esposizione all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento acustico e la maggiore opportunità di socializzazione nella mini comunità diminuiscono anche del 30% la possibilità di ammalarsi di depressione. Il sospetto fondamentale nei confronti della città è che non sia un habitat adeguato non solo per gli animali, ma nemmeno per l’uomo. Il rumore urbano è frastuono, quello di campagna, dai cinguettii degli uccellini allo sciabordio dei corsi d’acqua, è suono.
al bando il rumore
Su Youtube spopolano video rilassanti con questi suoni, non con quelli del fracasso del martello pneumatico di un cantiere stradale accompagnato da clacson e improperi di automobilisti inferociti per il rallentamento. Anche i film, persino quelli più semplici come le commedie americane, da un po’ raccontano come il cittadino trasportato in campagna ritrovi sé stesso: in Che fine hanno fatto i Morgan?, del 2009, un avvocato (Hugh Grant) e la moglie agente immobiliare (Sarah Jessica Parker) di gran successo a Manhattan ritrovano la propria armonia grazie al trasferimento coatto - testimoni oculari di un omicidio, entrano nel programma protezione testimoni dell’Fbi - a Ray nel Wyoming, micropaese assai country nel quale oltre a spaccare legna, tirare al bersaglio e imparare a evitare di restare secchi incontrando un orso non c’è altro da fare. In Scappo dalla città - La vita, l’amore e le vacche del 1991, un gruppo di amici, in particolare un affermato dirigente radio in crisi (Billy Cristal), trovano lo scopo della vita conoscendo un cowboy e la sua mandria.
«Lo studio e il lavoro sono più produttivi se siamo seduti davanti a un bel paesaggio»
Pubblicato dal pisano Pacini editore, I menu per un weekend in campagna di Giovanna Visintini è un piccolo libro che illustra quanta differenza ci sia tra ordinare la cena tramite una app del cellulare tramortiti dalla stanchezza e cucinare in campagna. La Visintini è docente di Diritto civile all’Università di Genova. La sua famiglia di origine è lombarda, con originaria residenza a Toscolano, sulla sponda bresciana del lago di Garda. La casa di famiglia è il complesso della Religione, convento dei canonici di San Salvatore di Brescia, detti anche Agostiniani, trasformato in insediamento abitativo e poi acquistato dalla famiglia Visintini nel 1815. Per la professoressa, la grande cucina della casa di campagna permette convivialità e preparazioni che la piccola cucina cittadina - in cui si cucina o riscalda il precotto del supermercato - nega.
Si tratta di un’eredità: «I miei genitori aprivano le porte a tutti anche se visitatori improvvisati. Mia madre era sempre in grado di trattenere gli ospiti a pranzo o a cena anche senza preavviso. Mio padre Fabio Visintini, noto neurologo e psichiatra, spesso sbalordiva i suoi colleghi invitandoli a uno spiedo accompagnato da polenta e aule fritte, divertendosi a presentare vini francesi raccontandone la storia o paragonando l’amarone delle nostre parti al barolo piemontese. Oltre a questo radunava amici e parenti a pesca di gamberi lungo il torrente Toscolano, tutti muniti del Bertabel (una reticella) e di una pertica cui venivano appesi i lombrichi, gita che terminava con una deliziosa insalata di code di gamberi, una specie in Italia in via di estinzione. Sulle orme paterne ho cercato di dare ospitalità a colleghi e amici fondando un Centro Studi nei pressi della casa di famiglia». Tutto, nel libro della Visintini, esalta ciò che spesso la città dimentica: «Se non si hanno a disposizione addobbi floreali», dice, «una buona idea è quella di inserire in una alzata o fruttiera tutto quello che si ha in casa, dai peperoni gialli e rossi, cascate di pomodori piccadilly o ciliegini, mele, banane, melograno, uva e altra frutta, possibilmente di stagione. I colori sono essenziali per attrarre sorrisi prima di apprezzare i sapori del cibo». La Visintini valorizza il rapporto con la natura garantito dalla campagna, anche quando si tratta della caccia. «La caccia come sport costituisce un prelievo controllato della selvaggina che salvaguarda equilibri naturali», sostiene. «Ben venga la caccia quando riguarda specie che possono espandersi eccessivamente come corvi, cornacchie, piccioni e cinghiali».
A tal proposito, è interessante approfondire ciò che la professoressa scrive riguardo lo spiedo: ci sono molti modi di preparalo, dice, ma quello bresciano è lo spiedo per eccellenza perché appartiene a una terra con forte tradizione venatoria. Spiega anche che dal 2014 è vietato al cacciatore vendere al ristoratore uccelli vivi o morti allo stato selvatico, eccezion fatta per fagiano, pernice e colombaccio e quindi questo tipico piatto - tradizionalmente ricco di tordi che insaporiscono pollo, faraona e maiale coi profumi del bosco - si può mangiare solo in casa.
Professoressa, questa sembra un’assurdità.
«Sì, sono d’accordo sull’assurdità. Personalmente preferisco rispettare la tradizione dello spiedo con i tordi sempre che mi riesca di averli in regalo da qualche cacciatore bresciano, quanto mai frustrato per le limitazioni che imperversano sulla caccia. Però so bene, come padrona di casa, che può capitare alla mia tavola un commensale che si blocca a vedere nel suo piatto un uccello piccolo. Ricordo che una volta sono stata bersagliata da cartoline che raffiguravano splendidi uccelli con la domanda: metteresti allo spiedo anche questi? Si trattava di aironi (c’è una bella differenza con i tordi!) e il mittente era il mio collega Victor Uckmar, contrario alla caccia. Quindi bisogna rispettare le opinioni contrarie e raccomandare lo spiedo anche senza tordi».
Nella ricetta dello spiedo bresciano, lei spiega che lo spiedo deve cuocere sulle «braci che si ottengono dopo un buon fuoco realizzato con legna aromatica di faggio, frassino e ginepro (vietato il legno di castagno)». Perché è vietato il legno di castagno?
«Il legno di castagno non va utilizzato perché non fa le braci (fa solo la fiamma) e del pari va escluso l’alloro perché darebbe allo spiedo un profumo di amaro».
Molti giovani lasciano la campagna per lavorare in città come se una escludesse l’altra. Lei può vantare un’importante carriera universitaria eppure questo non ha conflitto col grande amore che esprime per le «montagne verdi» delle sue origini familiari, lombarde.
«Sono convinta che lo studio e in genere l’attività lavorativa debbano combinarsi con qualche contatto con la natura e con la vista di un paesaggio fantastico come ce ne sono tanti in Italia. Provare ad avere un orto, ad esempio, penso che sia importante per capire la distanza tra un frutto o una verdura appena colta con quelle del supermercato».
Nel libro si sofferma sul Thanksgiving americano. Spiega che è una festa per tutti, ricchi e poveri, quindi gli ingredienti non possono essere ricercati e costosi: tacchino, pane vecchio, sedano, cipolla. E poi contorni semplici come piselli, carote, patate in purè e patate dolci. Per poter mangiare la carne bianca, spesso asciutta e stopposa, si ricorre al Cranberry sauce, la salsa di mirtilli rossi. Questo genere di cucina semplice e genuina, però, oggi sembra stia diventando così introvabile da essere quasi un nuovo lusso.
«Sì. È certamente vero che certi cibi genuini una volta erano meno costosi e oggi sono di lusso. Ne è una riprova il cappon magro che descrivo nel libro».
Parlando di gattò napoletano e torta pasqualina lei dice che si prestano ad essere utilizzati anche in un picnic di Pasquetta. Il picnic al parco può essere considerato un modo per vivere almeno un po' di natura in città?
«Non mi pare sia il caso di incoraggiare picnic nei parchi di città. Bisogna andare in collina o in montagna per farli, naturalmente con tutti gli accorgimenti per non lasciare scorie».
Lei consiglia di «non buttarsi voracemente sui cibi senza averne appreso prima l’origine, la composizione e la storia». Oggi siamo ossessionati dall’aspetto salutistico del cibo, mentre langue la conoscenza storica. Perché, invece, è importante?
«La storia è importantissima non solo per capire da dove veniamo ma per comprendere il presente. A tavola si crea un’atmosfera molto propizia alla convivialità se il padrone di casa sa raccontare storie e incuriosire gli ospiti sulle origini del piatto o del vino che lo accompagna».
Cucinare secondo tradizione, in particolare secondo tradizione campagnola, vuol dire anche cucinare con e per tante persone?
«A mia esperienza se si vuole apparecchiare una tavola in modo suggestivo e invitante è bene non superare un certo numero di persone (10, 16 o 20). Questo per favorire la conversazione. Con tante persone è meglio un buffet all’aperto con tanti tavoli cui appoggiarsi e magari con musica sullo sfondo. Il mio richiamo alla campagna nel titolo del libro non sta a indicare una preferenza per una cucina campagnola, ma serve a dire che occorre una cucina molto spaziosa, tipica delle case di campagna (anche quelle dei contadini) per affrontare menu così impegnativi del tipo di quelli descritti nel libro».