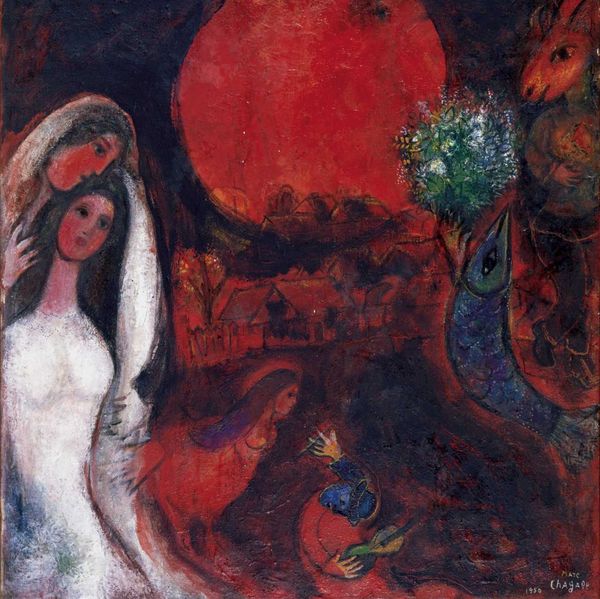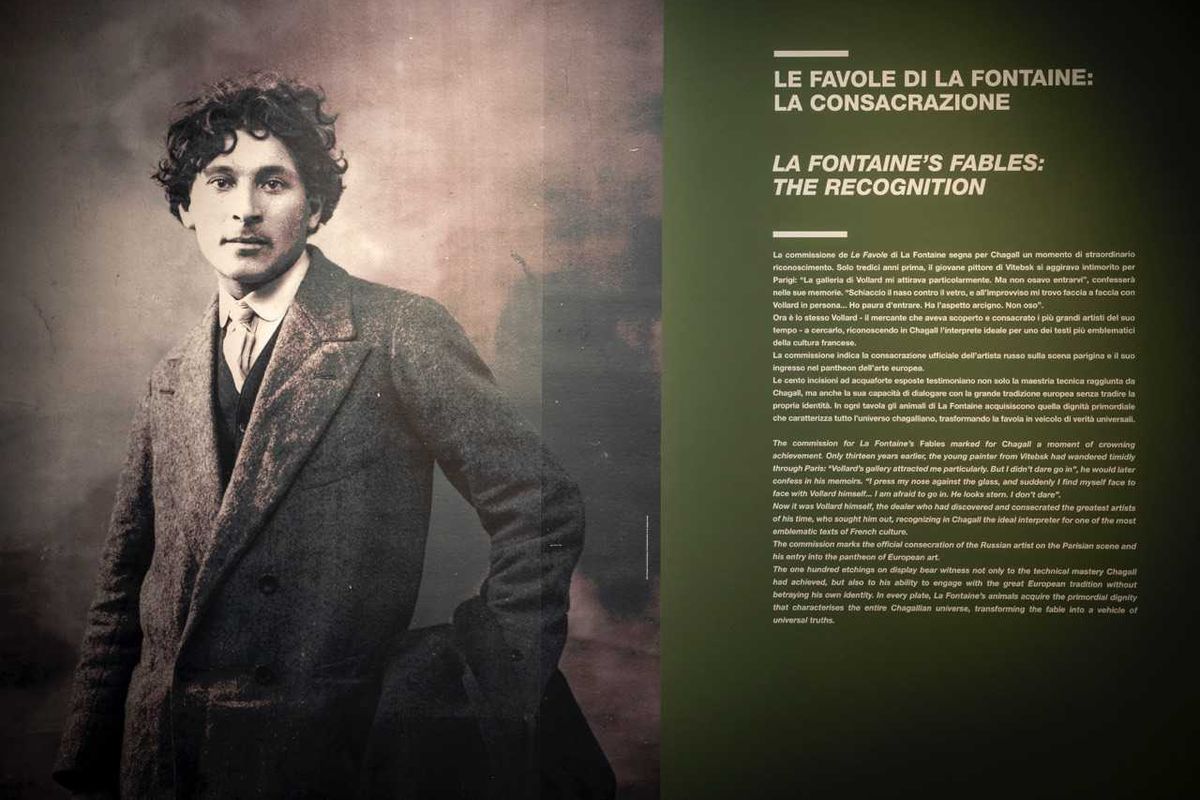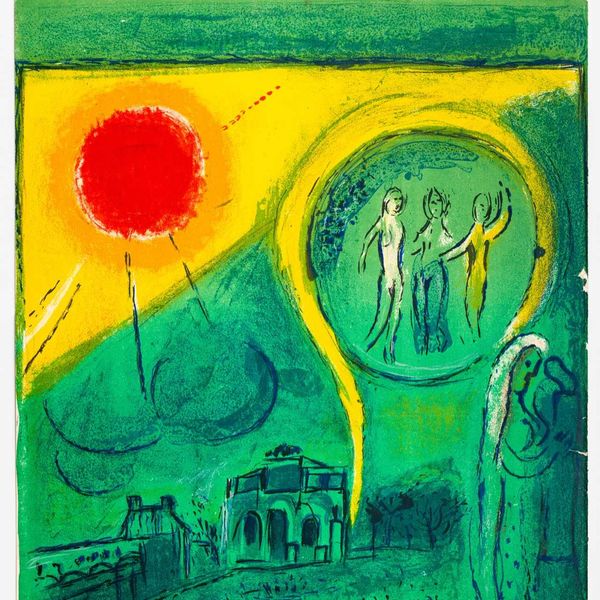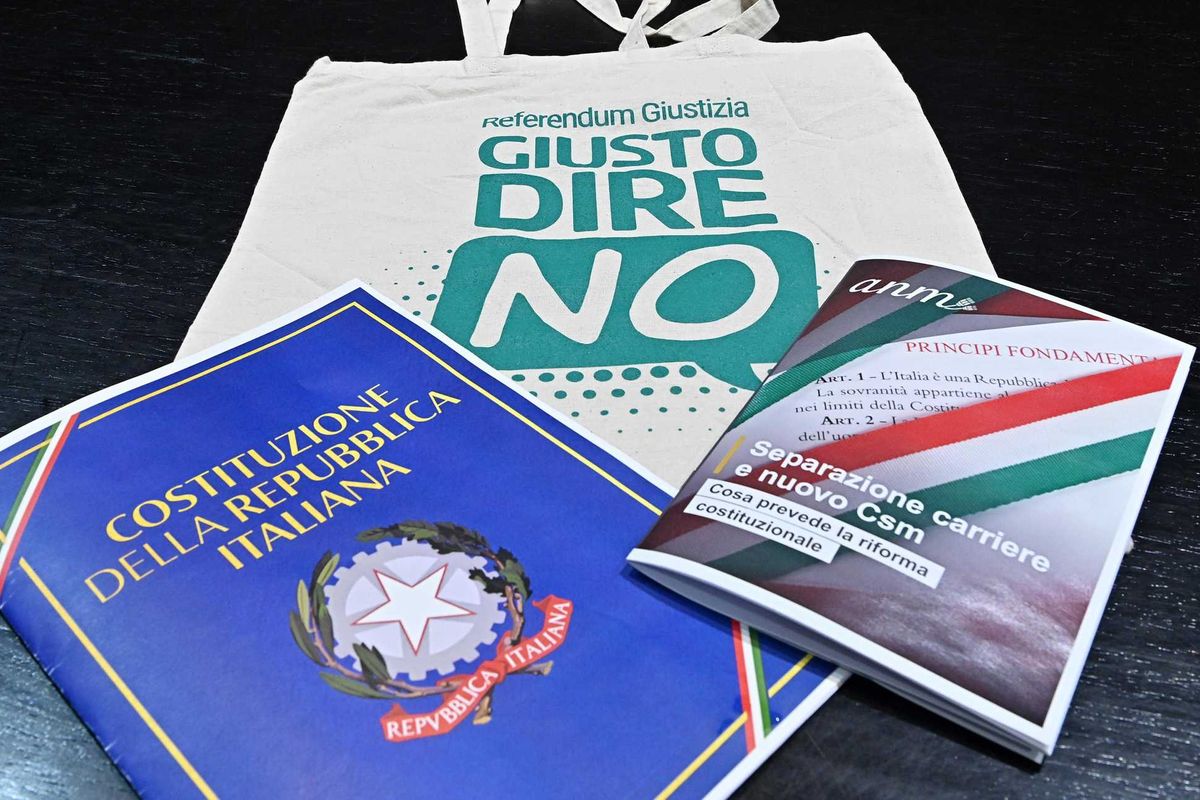Vi piace lo strapotere del Quirinale? Allora scegliamoci il suo inquilino

È un dato di fatto indiscutibile quello che, nel corso degli ultimi decenni, la figura del presidente della Repubblica è venuta ad assumere, rispetto agli altri organi dello Stato e, segnatamente, del governo, un sempre maggiore rilievo.
Non è certo possibile illustrare qui, neppure per sintesi, quali siano o possano essere state le ragioni profonde di tale fenomeno. Può essere però interessante notare che questo si è potuto realizzare senza che venisse apportata alcuna modifica alle norme costituzionali sulla base delle quali il presidente della Repubblica esercita le proprie funzioni, ma semplicemente dando ad esse una diversa interpretazione.
Particolare rilievo, in questo processo, è da attribuirsi al fatto costituito dal rifiuto che talvolta è stato opposto dai presidenti della Repubblica all'emanazione di decreti legge predisposti dal governo. Ciò è avvenuto, per quanto è dato sapere, una prima volta allorché il presidente Oscar Luigi Scalfaro, nel 1993, respinse (dopo avere, in un primo tempo, mostrato di condividerlo) il decreto legge di depenalizzazione del reato di finanziamento illecito dei partiti politici; una seconda volta allorché, nel 2009, il presidente Giorgio Napolitano respinse (dopo avere, con una lettera riservata al presidente del Consiglio, formalmente anticipato tale sua decisione) il decreto legge con il quale il governo aveva inteso impedire l'interruzione, autorizzata dalla corte d'appello di Milano, dell'alimentazione artificiale che teneva in vita Eluana Englaro. Nell'uno e nell'altro caso le ragioni del rifiuto attenevano essenzialmente al merito dei decreti in questione ed erano, comunque, del tutto opinabili.
Ciò premesso, occorre ricordare che, secondo la più accreditata dottrina costituzionalista, il presidente della Repubblica può soltanto chiedere al governo, ufficialmente o in via informale, un riesame del decreto legge da esso adottato, prima di provvedere alla firma ed alla successiva emanazione, rimanendo comunque obbligato a tali adempimenti ove il governo confermi la propria decisione.
Non può, invece, rifiutarsi puramente e semplicemente di dare via libera al decreto legge, se non nel caso in cui questo sia privo di taluno dei suoi essenziali requisiti di forma ovvero abbia un contenuto talmente eversivo da far sì che lo stesso presidente, ove ne consenta l'entrata in vigore, possa incorrere in responsabilità penale per alto tradimento o attentato alla Costituzione, ai sensi dell'articolo 90 della stessa Costituzione. In mancanza di tali condizioni il rifiuto si tradurrebbe infatti in una palese violazione delle prerogative tanto del governo quanto del Parlamento, dal momento che, secondo l'articolo 77 della Costituzione, il decreto legge è adottato sotto la esclusiva responsabilità del governo e spetta solo al Parlamento la decisione se convertirlo o meno in legge.
Come è noto, però, in materia costituzionale il valore del precedente è tale da far sì che esso si trasformi pressoché automaticamente in una regola; il che può dirsi avvenuto anche a seguito dei casi anzidetti, per cui si tende a dare oggi quasi per scontato, anche tra gli «addetti ai lavori», che il presidente della Repubblica possa interloquire in modo vincolante nell'elaborazione di un decreto legge sotto la minaccia, in altri tempi impensabile, di rifiutarne l'emanazione ove esso non risulti, alla fine, conforme alle sue aspettative.
Significativa, al riguardo, appare quella sorta di «tira e molla» tra governo e presidenza della Repubblica che si è verificata, come ampiamente reso pubblico dalle notizie di stampa, specialmente in occasione dell'emanazione del secondo dei due cosiddetti decreti Sicurezza di cui si era reso promotore, nel periodo del primo governo Conte, l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini. Il fatto che il «tira e molla» non si sia risolto, in tale occasione, con il finale rifiuto del presidente di dar luogo all'emanazione del decreto significa soltanto, con ogni verisimiglianza, che egli ha ritenuto, per ragioni di ordine puramente politico, di non portare le cose all'estremo; salvo poi a rinnovare (come ha fatto) l'espressione delle sue riserve, all'atto della promulgazione della legge di conversione del decreto in questione, con un messaggio diretto ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei ministri. Il che ha realizzato, tuttavia, una ulteriore e diversa esondazione dai limiti imposti dal dettato costituzionale (analoga, peraltro, a quella già verificatasi in occasione della promulgazione della legge n. 36/2019, anch'essa fortemente patrocinata - guarda caso - da Salvini, che modificava le norme del codice penale in materia di legittima difesa).
L'articolo 74 della Costituzione, infatti, non attribuisce al presidente della Repubblica la facoltà di accompagnare l'atto di promulgazione di una legge con critiche, osservazioni o riserve di sorta, ma gli consente soltanto, qualora ritenga che la legge presenti criticità tali da sconsigliarne l'entrata in vigore, di restituirla con messaggio motivato al Parlamento per un nuovo esame; dopodiché, se il Parlamento approva nuovamente la legge, la promulgazione non può più essere rifiutata. Né, d'altra parte, pur considerando che il presidente della Repubblica può in ogni momento avvalersi della facoltà di inviare messaggi alle Camere, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, si riesce a vedere di quale utilità possa essere un messaggio contenente rilievi critici ad una legge che le stesse Camere hanno appena approvato e che il presidente, se avesse voluto, avrebbe potuto restituire per un nuovo esame. Salvo a pensare - facendo peccato ma forse indovinando - che si tratti, in realtà, di un messaggio destinato ad una futura, diversa e già prevista maggioranza parlamentare ovvero costituisca un anticipato (e alquanto irrituale) suggerimento per chi, chiamato ad applicare quella stessa legge, volesse proporre delle questioni di legittimità costituzionale.
Sulla scia, quindi, di una tale progressiva espansione, in linea di fatto, delle prerogative del presidente della Repubblica, appare tutt'altro che irrealistico prospettarsi, a questo punto, anche la probabilità che si arrivi ad una diversa lettura dell'articolo 87 della Costituzione, nella parte in cui esso attribuisce al capo dello Stato il potere di «autorizzare» la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Questa norma è stata finora interpretata ed applicata nel senso che il presidente della Repubblica deve soltanto verificare che i disegni di legge rispondano ai necessari requisiti formali, senza minimamente poter interferire in modo vincolante sul loro contenuto, salva, ovviamente, anche in questo caso, la possibilità di rifiutare l'autorizzazione quando essa potrebbe esporre lo stesso presidente al rischio di essere accusato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ma una volta ammesso (come si è visto) che il presidente della Repubblica possa «contrattare» con il governo il contenuto di un decreto legge ed anche rifiutarne l'emanazione quando quel contenuto non sia da lui condiviso, nulla impedirebbe, a stretto rigor di logica, che analoghi poteri egli possa rivendicare anche con riguardo alla richiesta del governo di autorizzare la presentazione di un disegno di legge.
In tal modo, senza cambiare di una virgola il testo della Costituzione, la funzione di cosiddetto «indirizzo politico», istituzionalmente riservata in via esclusiva al governo e caratterizzata soprattutto dal potere di iniziativa legislativa, passerebbe in larga parte al presidente della Repubblica e quest'ultima si trasformerebbe quindi, da repubblica parlamentare in repubblica semipresidenziale. Il che non sarebbe necessariamente un male, se non fosse per il fatto che con una tale trasformazione si realizzerebbe il caso più unico che raro di una repubblica semipresidenziale nella quale la nomina del presidente non deriva da investitura popolare.
La conclusione, a questo punto, è perciò molto semplice: o si riesce (cosa che appare alquanto improbabile) a invertire la tendenza e a riportare quindi l'esercizio delle funzioni presidenziali entro i limiti che per lungo tempo erano stati, almeno formalmente, osservati, oppure, se non ci si vuole rassegnare ad un'anomalia come quella sopraindicata, occorre puntare all'unica soluzione possibile: l'elezione diretta del capo dello Stato.