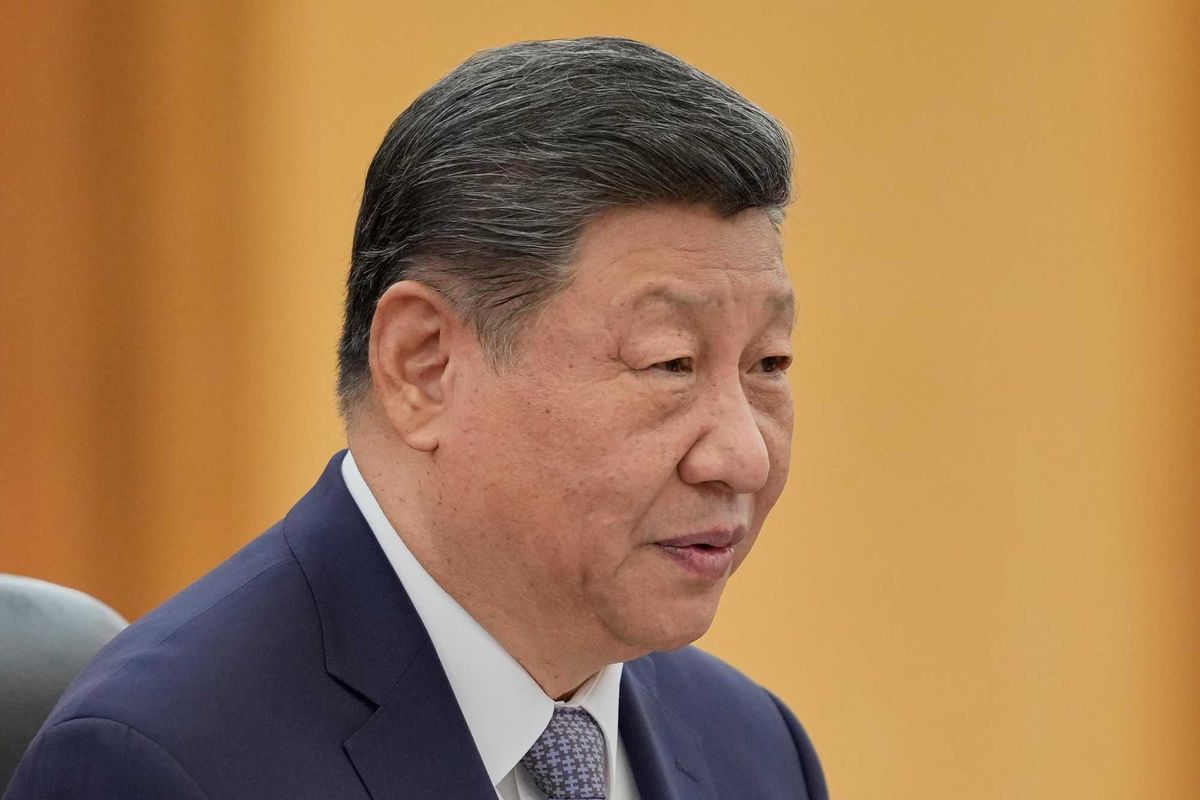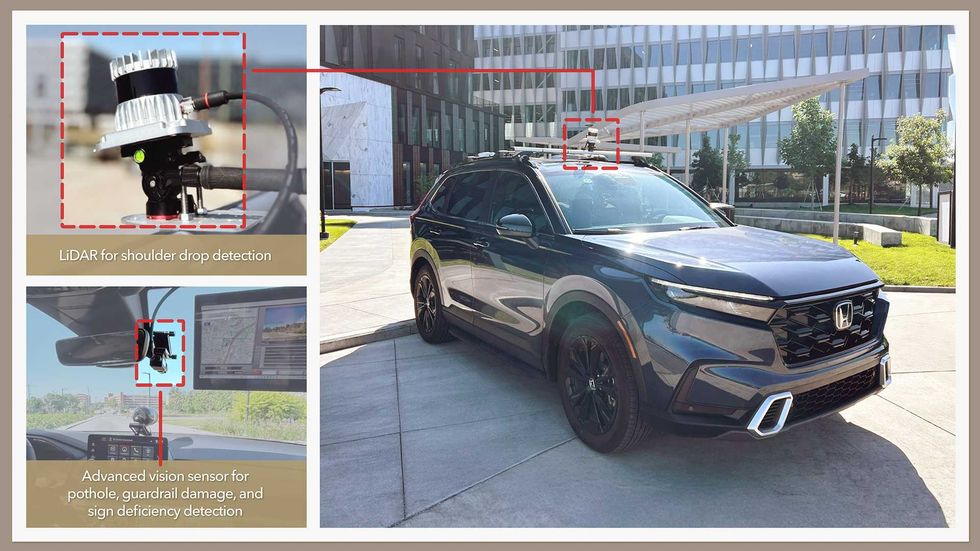La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (su richiesta del Tribunale di Roma competente in materia) relativa ai «Paesi sicuri» per i migranti da respingere ha destato reazioni contrastanti nel governo e nell’opposizione: una parte la contesta rivendicando la responsabilità della politica, l’altra la usa come legittimazione della critica alle scelte della maggioranza, specificamente sui centri detentivi in Albania. La Corte ha in effetti rivendicato il potere di decisione in ultima istanza dei giudici.
Non voglio entrare nella polemica. Mi limito a evidenziare che la sentenza della Corte Ue era prevedibile e personalmente lo avevo anche scritto l’anno scorso nella mia prefazione a un libro in materia di diritto europeo (Stefano D’Andrea, Serve meno Europa?, Roma 2024, pp. 11-52). Il punto è che se si vuole agire con uno sguardo attento alle conseguenze non si può dimenticare la storia dell’Unione, come nasce e come si costruisce nei decenni, in particolare dalla sentenza (della stessa Corte) Gend van Loos del 1963, definita all’epoca un vero e proprio «colpo di Stato» dei giudici europei. Da allora in poi le funzioni e i poteri della Corte si sono accresciuti, ma non in astratto o per prassi o convenzione, ma per diritto, nel senso che i poteri della Corte sono esplicitati nei Trattati stessi, compreso quello - farraginoso e retorico - di Lisbona (in realtà sono due trattati, uno sull’Unione europea e un altro sul «funzionamento» della stessa Ue).
Si legge per esempio all’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Ue in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte (sottolineo: pregiudiziale): «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte». Potrei citare altri articoli anche più direttamente influenti sulla funzione politico-costituzionale, se non addirittura costituente, della Corte del Lussemburgo, ma è sufficiente quello citato per porre il problema: si può continuare su questa china? I governi rivendicano le competenze politiche interne, ma non tutti sono in grado di passare dalle parole ai fatti. La Germania e anche la Francia hanno possibilità e canali (a partire dalla preponderanza dei funzionari tedeschi negli organi e organismi tecno-burocratici dell’Ue) che altri paesi non hanno.
Il problema non è risolvibile con attacchi alla magistratura interna ed europea, accusata di avere questo o quel colore. I giudici allo stato delle cose, almeno a livello europeo, sono legittimati a fare quello che fanno. È ora perciò di ripensare il rapporto degli Stati nazionali con l’Unione europea, organismo, posso persino dire, extraeuropeo, che con la sua «fame di competenze» (Dieter Grimm, già giudice costituzionale tedesco) succhia i poteri degli Stati e li traduce in atti spesso sconsiderati (si veda la politica del «green deal», ma anche quella dei «pacchetti» autolesionisti contro Putin o l’idea di riarmare con fuciletti ad acqua tutti gli Stati contro la Russia che sarebbe pronta ad invaderci) e privi di legittimazione.
Una fame di competenze legittimata dall’ideologia oltre-sovranista della morale universale che, ovviamente solo in Occidente, ha abrogato la sostanza storico-spirituale del diritto, la sua tradizione, per asservire le norme, non a caso continuamente consumabili, allo spettro della giustizia sovrastorica e astratta che tutto deve dominare.
La cosa politicamente peggiore è che proprio il potere politico dei giudici è quello legittimato dai trattati vigenti, che gli Stati si sono impegnati a rispettare. Per non parlare persino di atti amministrativi europei che prevalgono su disposizioni costituzionali interne agli Stati.
Sarebbe ora, perciò, che anche i governi nazionali se ne rendessero conto per agire non retoricamente, ma con decisionalità politica verso una riforma radicale dei trattati stessi. Serve meno Europa, anche perché quella che si è costruita non è l’Europa della storia europea.