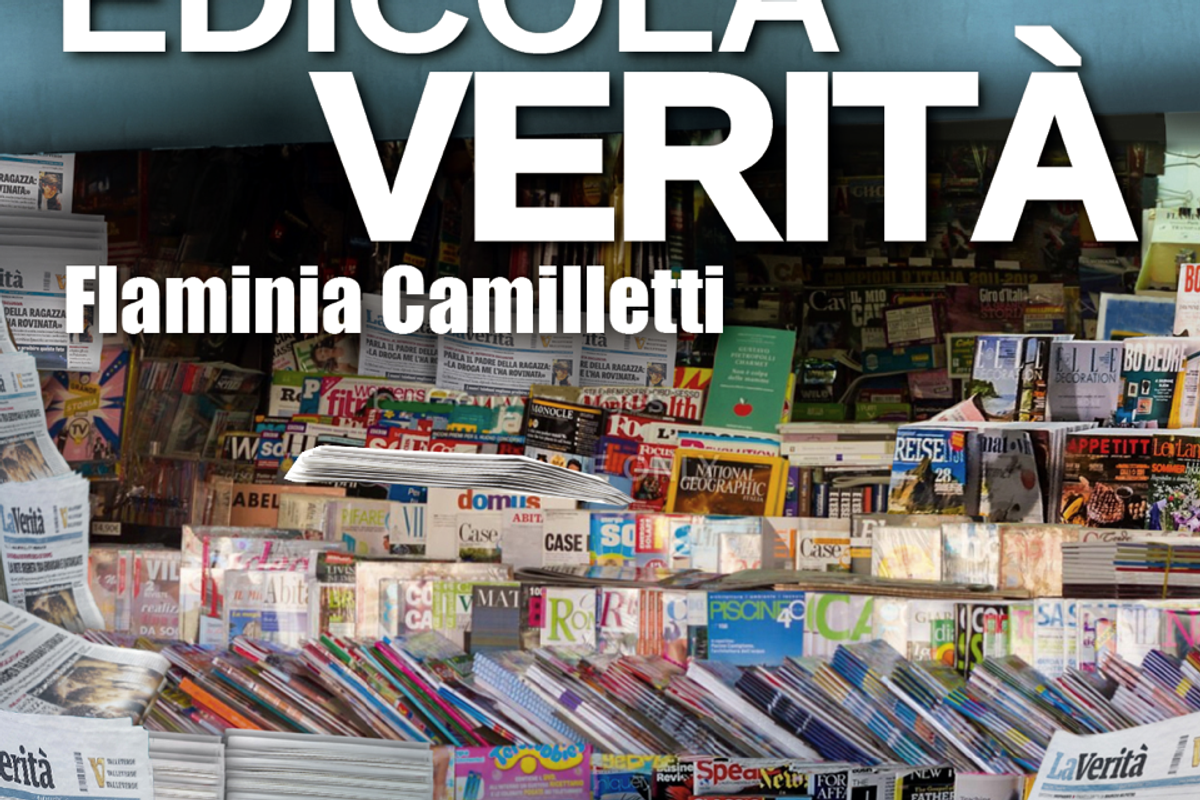Sapori antichi, nuove storie. La cucina che tramanda la memoria della Sardegna

Saboris antigus, realizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, è un ricettario che nasce dal desiderio di mettere nero su bianco le ricette del territorio della Trexenta e del Sarcidano. Realizzate da Chiara Cogotti, fotografate da Francesco Pruneddu, le ricette di questo ricettario coordinato da Giuseppina Scorrano, sono «un invito a immergersi nell’autenticità delle tradizioni culinarie dei territori sardi della Trexenta e del Sarcidano, dove il legame con la terra e con il passato si esprime anche attraverso i sapori di piatti tramandati di generazione in generazione». Rintracciare le ricette del territorio, quelle vere, è un lavoro che si deve appunto svolgere sul territorio: «La creazione di questo ricettario ha richiesto un lavoro di ricerca appassionato e meticoloso, attraverso l’incontro con esperti di cucina locale, depositari della memoria gastronomica del territorio, e il coinvolgimento di chi custodisce questi saperi nelle proprie case, rinnovando gesti di famiglia con una dedizione sincera».
Cosa significa preservare le ricette tradizionali? «Significa salvaguardare un patrimonio immateriale che va oltre il cibo: è memoria collettiva, identità culturale e narrazione di un territorio. Le ricette proposte nel libro rappresentano una sintesi di racconti e pratiche, ma non pretendono di essere definitive. Trasmessi oralmente e affinati dalla pratica quotidiana, questi piatti non conoscono una versione unica, bensì tante varianti quanti sono le cuoche e i cuochi che li preparano».
Sfogliando il ricettario si osserva una sobrietà che connota tutte le ricette. In un mondo del food contemporaneo spesso più attento alle pagliacciate che all’essenzialità, queste ricette sono ammirevoli anche perché ci ricordano che la cucina è prima territorio che show, soprattutto quando lo show è circense. Gli ingredienti sono essenziali e territoriali: pecora, coniglio, gallina, anguilla. Le paste sono locali, dalla semola fritta alla freguledda, passando per i pitzottis. I dolci sono anch’essi un trionfo di essenzialità ed eleganza: il grano cotto (Trigu cottu) ci ricorda che prima dei croissant dalle forme più disparate e dai topping e dalle farciture caleidoscopiche di oggi per fare un dolce bastava trasformare in dolce un alimento di solito mangiato salato, i Coccois de annu, i biscotti glassati, ci ricordano che un tempo chi cucinava in casa sapeva glassare con l’artisticità che oggi attribuiamo solo ai grandi chef.
Tradizione non vuol dire non dialogare con l’innovazione. Tradizione e innovazione possono coesistere e la presenza nel libro di tre chef professionisti lo testimonia: Davide Atzeni del ristorante Coxinendi, Riccardo Massaiu de I Sarti del Gusto e Marina Ravarotto di Chiaroscuro, «profondi conoscitori del territorio e delle sue materie prime».
A ciascuno di loro, si legge, «è stato chiesto di reinterpretare le ricette tradizionali o di elaborare nuove creazioni ispirate ai prodotti tipici locali con un duplice obiettivo: da un lato, valorizzare la qualità straordinaria delle produzioni del territorio; dall’altro, offrire una rappresentazione attuale e innovativa della cucina sarda. I piatti ideati dagli chef rappresentano uno sguardo contemporaneo alla tradizione e confermano che i sapori antichi possono continuare a essere una risorsa viva e attuale».
La Pecora in umido alla campidanese dello chef Davide Atzeni ci ricorda che anche la cipolla, oltre allo zafferano, è un ingrediente prezioso. Il Su succu di Santa Maria della chef Marina Ravarotto, un pasticcio di pasta realizzato con «sfoglie» di filindeu è superlativo e ci ricorda che laddove si allevano le pecore si prepara anche il brodo di pecora. L’Emulsione dolce all’olio extravergine di oliva dello chef Riccardo Massaiu ci ricorda che si può lavorare in chiave quasi futuristica con la forma ma che ciò può essere asservito all’esaltazione di ingredienti genuini, come il nostro prezioso nettare verde di olive.
Sosteneva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach che «l’uomo è ciò che mangia». Ed è vero. C’è innanzitutto un rapporto di causa ed effetto fisico, rapporto granitico e al contempo spicciolo, in questa affermazione: se «siamo» ciò che mangiamo, ebbene se mangiamo troppo e male ingrassiamo. Tanto che di solito questa massima è usata come monito per invitare le persone a mangiare bene: «Smettila di ingozzarti di cibo spazzatura, ricordati che siamo ciò che mangiamo...!».
C’è poi tutta una serie di costruzioni identitarie che si basano su questo assunto. «Ciascuno mangia solo ciò che si addice alla sua individualità o natura», affermò sempre Feuerbach. Per esempio, se siamo italiani, amiamo mangiare italiano più che, per dire, filippino. Ancora, se siamo ciò che mangiamo, allora possiamo «diventare» ciò che non siamo ma, attenzione, vogliamo diventare. Possiamo diventarlo mangiando oppure possiamo estendere ciò che siamo a ciò che mangiamo. Per esempio, sono un rapper o una cantante pop e vengo da una situazione economica familiare molto molto povera dove il problema era riempire il piatto, di cosa era indifferente, grazie al successo ho acquisito fama e ricchezza. Dal punto di vista reddituale, quella ricchezza mi assimila ai ricchi nobili o industriali che sono notoriamente anche raffinati. Io, che vengo dal ghetto, voglio acquisire anche quella raffinatezza dei ricchi veri e perciò comunico a me stesso e al mondo che sono ricco e raffinato perché mangiare fuori per me non vuol dire più andare al giropizza sulla tangenziale, ma pasteggiare spesso e volentieri con tanto di fotografie (social e non solo) al ristorante dello chef Carlo Cracco. Da ciò che mangio sarò «battezzato» ufficialmente per cosa sono, ora, e lo sapranno tutti. Il caso dell’estensione di ciò che siamo a ciò che mangiamo: sono un progressista, credo alla vulgata assai propagandistica che solo il progressismo si occupi di etica e che l’allevamento animale inquini senza se e senza ma e quindi divento vegetariano per dire a me stesso e al mondo che io appartengo all’«Italia migliore».
Siamo ciò che mangiamo, sì. Ma - anche - mangiamo ciò che siamo. Siamo sardi, mangiamo sardo. Mutando tutto quello che c’è da mutare, questa affermazione vale per tutte le appartenenze locali, dal piccolo paese alla grande metropoli, perché il luogo è sempre anche un luogo alimentare, con i suoi prodotti, le sue prassi, le sue ricette, le sue peculiarità. Il concetto di comfort food si basa molto più di quanto crediamo sulla familiarità del cibo in questione. Una minestrina calda è il mio comfort food non perché sia oggettivamente e in assoluto un cibo che dal punto di vista nutrizionale migliora il mio umore: può esserlo, certo, ma può anche essere di conforto al mio umore per altri motivi. Per esempio, mi fa stare bene perché mi è familiare, perché proprio quella minestrina me la preparava mia madre da piccolo e mangiare quella pietanza mi riconduce inconsciamente a quel tempo che nella mia memoria è un tempo felice. Chiamiamo cibo familiare quello consumato in famiglia, ma dovremmo iniziare a pensare a quanto sia importante il cibo familiare inteso come cibo «che ci è» familiare ossia noto e confidenziale esattamente come la nostra famiglia. Sia in presenza di famiglia, sia in assenza di famiglia.
Gli expat, per esempio, vanno a mangiare nei ristoranti di cucina tipica dei luoghi da cui provengono per relazionarsi con qualcosa di familiare. Quando applicato al cibo, il concetto di familiare si può riferire, dunque, anche semplicemente al territorio che ci è familiare. Proprio come è letteralmente per la nostra famiglia umana. Il nostro territorio è la nostra famiglia spaziale.
Che quanto è familiare per il nostro corpo vale più di ciò che non lo è viene indicato anche dallo svezzamento. Il primo alimento del bimbo è il latte materno. Poi il suo apparato digestivo diventa capace di digerire altro e il suo sviluppo psicofisico gli consente di masticare nuove e diverse consistenze. Ma è necessario un periodo di svezzamento ossia di introduzione progressiva di nuovi alimenti, perché il piccolo non ha «familiarità» col nuovo alimento, la deve costruire. Anche le reazioni di alcuni al cibo esotico ci dicono la stessa cosa. Molti nutrizionisti consigliano di mangiare la frutta esotica un po’ alla volta, perché siamo abituati alla frutta locale e possiamo avere problemi digestivi ingozzandoci di dieci chili di frutta esotica tutta insieme.
Riscopriamo ciò che siamo perché lo abbiamo sempre mangiato e siamone orgogliosi. Ci farà anche bene.