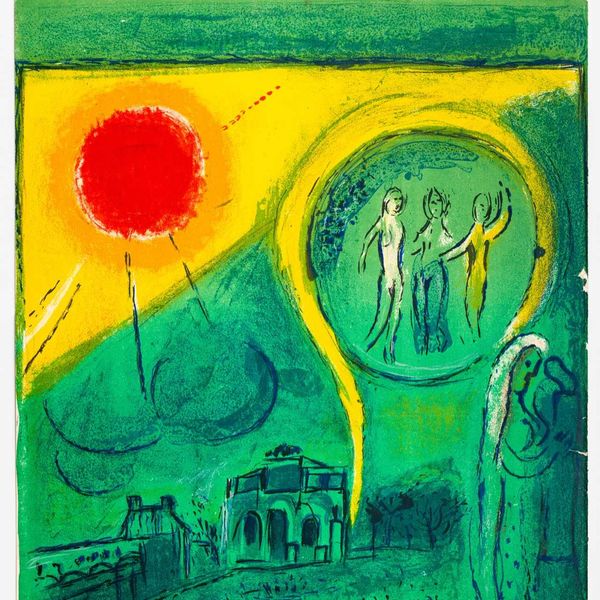Marc Chagall. Ricordo del Flauto magico,1976. Collezione privata © Marc Chagall, by SIAE 2025
A Palazzo dei Diamanti di Ferrara (sino all’8 febbraio 2026) una mostra-evento dedicata a Marc Chagall, fra i più noti e amati artisti del Novecento. In un’alternanza di opere pittoriche, disegni, incisioni e sale immersive, esposti oltre 200 capolavori, alcuni dei quali presentati per la prima volta in Italia.
Nato a Vitebsk nel 1887, ebreo russo che trascorse la maggior parte della sua vita in Francia (morì a Saint Paul de Vence nel 1985), Mar Chagall ( il cui nome ebraico era Moishe Segal e quello russo Mark Zacharovič Šagal), conservò sempre nel cuore la sua Patria («Non mi sono mai separato dalla mia terra, la mia arte non può vivere senza di essa» dichiarò nel 1922), le tradizioni e la religione ebraica, elementi che ricorrono costantemente nella sua vasta e poliedrica produzione artistica. Un attaccamento alle origini che era parte fondamentale del suo essere, di uomo e di artista, e che non lo abbandonò mai, nemmeno quando le leggi razziali lo costrinsero a lasciare l‘Europa per trasferirsi negli Stati Uniti: nel Vecchio Continente ci tornò a fine conflitto, nel 1946, già artista famoso e con la consacrazione del MOMA, che in quegli anni gli dedicò un’importante retrospettiva.
Animo sensibilissimo (dopo la morte dell’amatissima prima moglie Bella cadde in depressione e per un anno non riuscì più a dipingere…) e dalla spiritualità profonda, Chagall fece della sua arte la trasfigurazione poetica del suo nucleo emotivo: Chagall non rappresenta gli eventi, ma i ricordi , la memoria dell’infanzia che si fonde con la cronaca, la sua storia personale che si intreccia a quella universale. Il tutto in un mondo da fiaba, fluttuante, apparentemente senza logica, dove gli sposi sorvolano i campanili, le figure si sdoppiano, gli animali parlano, i violinisti suonano sui tetti, i profeti biblici stanno accanto a capre azzurre. Anche l’Olocausto, che la sua emotività non gli permise di dipingere in tutto il suo inenarrabile orrore, sotto il suo pennello si trasforma in fantasiosa allegoria: in un ebreo barbuto e malinconico con in mano la Torah (Solitudine, 1933) o in un Cristo crocifisso circondato dal caos (Crocifissione bianca, 1938). In Chagall il tempo non segue la linearità cronologica, ma quello dello spazio interiore, dove immagini lontane e vicine convivono nella stessa opera, senza gerarchie: il dolore con la bellezza, la perdita con la rinascita. Artista di inarrivabile poesia e delicatezza, dietro l’apparente semplicità delle sue opere si celano temi comuni a tutta l’umanità, speranze e contraddizioni, ma soprattutto la volontà di condurre lo spirito del Mondo verso una bellezza capace di trovare, anche negli orrori del tempo, angoli di pace e comprensione.
A condurci nel mondo delle sue colorate atmosfere incantate la splendida mostra-evento (già nei primi due giorni di apertura ha registrato oltre duemila visitatori…) allestita nelle sale di Palazzo dei Diamanti di Ferrara, che in un percorso espositivo particolarmente coinvolgente raccoglie oltre 200 opere e sale immersive di stupefacente bellezza.
Chagall testimone del suo tempo. La Mostra
Curato da Paul Schneiter e Francesca Villanti, il ricco percorso espositivo parte dagli esordi di Chagall nella natia Vitebsk, passa per l'esilio negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale e si conclude con le grandi composizioni della maturità. Diviso in dieci sezioni, fra opere di toccante bellezza e dense di significato come La sposa dai due volti (un dipinto che rappresenta la dualità dell'esistenza umana, fra i temi più cari all’artista), La nave dell'Esodo (un'opera che sovrappone due episodi: l'Esodo biblico dall'Egitto e la fuga degli ebrei europei dalle persecuzioni naziste) e La Pace ( una colomba bianca a cui Chagall affida il suo messaggio di speranza), davvero spettacolari le sale immersive che permettono al visitatore di ammirare due creazioni monumentali in una dimensione coinvolgente e grandiosa: il soffitto dell'Opéra di Parigi e le 12 vetrate per la sinagoga di Hadassah, esempio di come Chagall abbia saputo fondere arte e spiritualità.
Continua a leggereRiduci
Oltre ai soliti beni rifugio corrono i metalli strategici. La spinta, qui, non è solo finanziaria ma anche materiale: transizione e intelligenza artificiale richiedono grandi input. Lo stesso vale per alluminio, litio e palladio.
Mentre oro e argento dominano le cronache con i record, sotto la superficie dei listini sta correndo un’onda altrettanto decisiva: i metalli industriali e «strategici». La spinta non è solo finanziaria: è materiale. Transizione energetica e intelligenza artificiale richiedono reti elettriche, data center, componenti e riciclo: quantità crescenti di rame, platino e affini.
Il platino è il caso più evidente di riscoperta. Salvatore Gaziano (SoldiExpert Scf) nota che «dopo il boom dell’oro, molti investitori hanno riscoperto il platino, rimasto indietro nel rapporto storico di prezzo con il metallo giallo». La tesi poggia sulla doppia anima: bene prezioso per l’oreficeria (con domanda asiatica solida) e input industriale «insostituibile» per vetro e automotive. L’offerta, però, resta sotto pressione per i problemi estrattivi in Sudafrica: la scarsità fisica sostiene le quotazioni, con l’Etc WisdomTree Physical Platinum a +28,4% da inizio anno.
Se il platino è una scommessa sul valore, il rame è una scommessa sull’infrastruttura della civiltà digitale. Lo strategist di SoldiExpert Scf sintetizza: «L’Ia non è fatta solo di software, ma di chilometri di cavi e infrastrutture elettriche». E la scala è impressionante: «Un singolo data center richiede fino a 9.000 tonnellate di rame, e la rete elettrica per collegarlo ne richiede tre volte tanto». In Europa, poche storie offrono esposizione diretta: fra queste brilla Aurubis. «La sua forza sta nel riciclo»: dai rifiuti elettronici estrae rame per reti e mobilità verde, ma anche oro e argento; l’aumento dei prezzi dei metalli gonfia il valore delle scorte in bilancio e sostiene il titolo. Il termometro del settore è il consolidamento: la possibile fusione Rio Tinto-Glencore (260 miliardi di dollari) segnala che la «scala» è diventata requisito strategico per presidiare l’offerta globale. Sul lato investimenti, Gaziano ricorda che si può puntare sulle singole eccellenze o su panieri diversificati, tenendo conto della volatilità ciclica del comparto.
Stefano Gianti (Swissquote) sottolinea che «la maniera più semplice è probabilmente quella di acquistare un Etc», che replica l’andamento del metallo (al netto di costi contenuti).
Ma Gabriel Debach (eToro) invita a leggere il rame come un mercato logisticamente «inceppato»: a gennaio 2026 «il Lme è ancora prevalentemente in backwardation (una condizione di mercato in cui il prezzo attuale di una materia prima è superiore ai prezzi dei contratti futures con scadenza successiva, ndr)», mentre il Comex è in contango (il prezzo dei futures è superiore all’attuale, ndr) dopo l’accumulo di scorte Usa legato ai timori di dazi. Per questo, oltre alla direzione del ciclo, contano struttura a termine e flussi fisici. Quando il rame corre, l’alluminio entra nel gioco come sostituto: Goldman Sachs indica la coppia Long rame e Short alluminio fino a dicembre 2027. In parallelo, il platino torna centrale come catalizzatore per fuel cell e filiera dell’idrogeno. Palladio e litio sono osservati: la Cina punta a raddoppiare la capacità di ricarica Ev entro il 2027 a 180 Gw, mentre il litio oscilla tra domanda in crescita e ritorno dell’offerta».
Continua a leggereRiduci
(IStock)
Il documento finale del consiglio permanente della Cei chiede che nelle parrocchie sia presente una figura che possa aiutare le coppie omosex e chi ha fatto la transizione.
Don Camillo è sconsolato. Davanti a lui c’è don Francesco, detto don Chichì, il prete arrivato a rivoluzionare la parrocchia. Sono gli anni del Concilio Vaticano II e l’obiettivo è quello di «demistificare». Via il grande Crocifisso dell’altare maggiore, quindi. E via pure l’altare, al suo posto la «tavola calda». La Chiesa, però, a furia di novità, è sempre più vuota.
Don Chichì ha un’idea. «Tornare alle origini, a Cristo e ai suoi Apostoli che portavano alle genti sofferenti la parola consolatrice di Dio! Passare casa per casa, bussare a tutte le porte, interessarsi di tutti i problemi dei fedeli, intervenire attivamente dove è possibile. Trasformare il prete-burocrate in amico». Naturalmente l’idea di don Chichì, che poi è quella della Chiesa del post Concilio, fu un fiasco.
E rischia di esserlo ancora di più ora che la Cei - come si legge nel documento finale del suo consiglio permanente (quasi fosse la Cgil) - «ha demandato alla Presidenza la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio di linee orientative e indicazioni per la riconfigurazione territoriale delle comunità parrocchiali e l’affido della partecipazione alla cura pastorale di una comunità a un diacono o un’altra persona non insignita del carattere sacerdotale o a una comunità di persone, e anche per lo studio degli aspetti teologici, antropologici e pastorali relativi all’accoglienza di persone omoaffettive e transgender».
Proviamo a tradurre il burocratese della Conferenza episcopale: nel documento si chiede che ogni comunità parrocchiale abbia un fedele, sia esso diacono o laico, che si possa occupare dell’inclusione di persone omosessuali o trans. Bene. Anzi, male: perché la Chiesa oggi pare interessata a tutto fuorché a far arrivare il maggior numero di anime possibili al Padreterno. Per cui parla di tutto - del clima, dei trans, della disoccupazione e del fatto che non esistono più le mezze stagioni - ma mai (o quasi) della fede. Eppure quello dovrebbe essere il cuore di tutto.
Giovanni Maria Vianney, il curato d’Ars, faceva una cosa molto semplice. Si alzava la mattina e si chiudeva nel confessionale, dove rimaneva per ore e ore. I fedeli accorrevano da ogni dove per dirgli i peccati che avevano commesso, certamente, ma pure le loro difficoltà. E lui ascoltava tutti e li assolveva nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Promettevano di non peccare più, ma poi ci ricadevano lo stesso. E allora indietro dal curato d’Ars, che non si muoveva mai da quell’inginocchiatoio di legno. Era, lui, un prete-prete. Non il prete amico di don Chichì, prototipo di tanti preti-amici che oggi sono vescovi e cardinali. Che hanno perso il centro e che a furia di cercare chi era lontano hanno perso chi si trovava più vicino. Basta entrare in una chiesa per rendersene conto. Non c’è più nessuno che prega. A volte qualche vecchina, come una sentinella solitaria, che sgrana il rosario. A volte qualcuno che chiede un miracolo per sé o per qualche caro.
La primavera del Concilio, come ha detto Paolo VI, si è rivelata un gelido inverno. Che ha ghiacciato le anime. E ora, per provare a portare qualcuno in chiesa, si punta ad aprirsi ulteriormente, a colpi di psicologia e sociologia. Ma ciò che serve davvero è qualcuno che parli fede. Qualcuno che parli meno di questo mondo e più dell’altro. C’è bisogno del Cristo dell’altare maggiore, che indica la via, e di preti come don Camillo, che abbiano mani come badili per rimetterti in carreggiata. E che siano in grado di scaldare il nostro vecchio cuore di marziani, come direbbe Giovannino Guareschi.
Continua a leggereRiduci
(Ansa)
Confrontando gli articoli originali con le proposte di modifica si scopre la campagna di disinformazione messa in atto a sinistra.
I due più importanti privilegi della nostra esistenza sono vivere e poter scegliere. Una delle prossime scelte da fare è quella al referendum. Chi su esso ci mente, ci inibisce il secondo degli importanti privilegi detti. Permettetemi un suggerimento. Anziché farvi confondere dai logorroici dibattiti televisivi o dai commenti partigiani sulla carta stampata, leggete direttamente la riforma: è appena una pagina e mezza della Gazzetta ufficiale. Confrontate poi gli articoli originali e con quelli modificati. Infine, leggete le motivazioni del Comitato per il No: vi accorgerete da soli che sono menzognere, col che stanno inibendo la vostra libertà di scegliere, che si ha solo se vi vien detta la verità.
La riforma consta di otto articoli, sull’ultimo dei quali - «Disposizioni transitorie» - tornerò alla fine. Gli altri sette modificano gli articoli 87, 102, 104-107 e 110 della Costituzione. Sembrerebbe la modifica di sette articoli e infatti le lamentele del Comitato per il No esordiscono proprio così: «Questa legge modifica sette articoli della Costituzione». Il che, pur apparentemente vero, è sostanzialmente sonoramente falso e fuorviante. Il Comitato per il No esordisce manipolandovi col trasmettere il messaggio angoscioso che la riforma governativa stravolgerebbe la Costituzione. Una comunicazione levantina che da sola basterebbe a togliere ogni fiducia a chi invita a votare No.
La verità sostanziale è che si modificano solo due articoli, mentre gli altri sono solo adeguati per coerenza. Per esempio, visto che nei due veri articoli modificati si istituiscono due magistrature governate, ciascuna, dal proprio Consiglio superiore, l’articolo 87 - che attualmente recita: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm» - diventa: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm giudicante e il Csm requirente». Simili considerazioni valgono per gli articoli 102, 105, 106 e 110. Gli articoli veramente modificati sono il 104 e il 105. La riforma disciplina tre cose.
L’esordio dell’articolo 104 - «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» - diventa: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». È finalmente introdotta la separazione delle carriere: così come l’avvocato che vi difende non è collega del giudice che deve emettere sentenza, anche la pubblica accusa non lo sarà più. Ove l’articolo vecchio continua assegnando la presidenza dell’unico Csm al capo dello Stato, quello nuovo si adegua, istituisce due Csm e mantiene il capo dello Stato a presiederli entrambi. Ecco attuato il principio del giusto processo, in ottemperanza all’articolo 111 della Costituzione.
Secondo il vecchio articolo, gli altri componenti (attualmente 24) sono «eletti» per 2/3 dai magistrati e per 1/3 da una lista che il Parlamento compone tra professionisti di lungo corso del diritto. Nell’articolo modificato dalla riforma, la parola «eletti» è sostituita con le parole «estratti a sorte».
L’articolo 105 attuale recita: «Spettano al Csm le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Il nuovo articolo 105 è molto più lungo, col primo comma quasi coincidente con l’intero articolo vecchio: «Spettano a ciascuno dei due Csm le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati». Come si nota, le parole «le promozioni» sono sostituite con le parole «le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni»; e sono state soppresse le parole «provvedimenti disciplinari» del vecchio articolo. Cosa significa? Significa, intanto, che ove la vecchia legge parla solo di «promozioni», la nuova parla di «valutazioni di professionalità». Ora, non voglio qui rivangare la brillante carriera dei giudici che hanno distrutto la vita di Enzo Tortora, solo perché non voglio dare l’impressione che quella del caso Tortora sia l’eccezione che conferma una regola: temo che sia invece la regola. Ancora: a leggere l’attuale articolo 105, suona quanto mai bizzarro che eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di un magistrato siano affidati a coloro che quel medesimo magistrato ha eletto. E, infatti, come osservavo a mo’ di esempio, quelli coinvolti nel caso Tortora, lungi dal subire provvedimenti disciplinari, fecero invece brillante carriera. Nel resto del nuovo art. 105, la riforma istituisce allora un’Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici professionalmente qualificati: «Tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica» e gli altri 12 sono, di nuovo, tutti estratti a sorte: sei sono della magistratura giudicante, tre della magistratura inquirente e tre da un elenco di professionisti di lungo corso del diritto nominati dal Parlamento. I membri dell’Alta Corte non possono essere membri di nessun Parlamento (regionale, nazionale o europeo) né possono esercitare professione di avvocato. Infine, chi è soggetto a provvedimenti dell’Alta Corte può impugnarli solo dinanzi alla medesima Corte e, in questo caso, essa giudica in assenza dei componenti che hanno concorso alla decisione impugnata.
La prima lamentela del Comitato per il No è che la riforma assoggetterebbe il Csm al governo e/o al Parlamento. Ora, ditemi voi, come possa mai accadere che, passando da un meccanismo elettivo a una estrazione a sorte, chicchessia possa meglio influenzare sull’esito finale. Anzi, l’estrazione a sorte tra i titolati a far parte dei due Csm o dell’Alta Corte è l’unica cosa che garantisce che la scelta dei componenti sia avvenuta senza alcuna influenza esterna. Allora, chi vi dice che la riforma introduce, rispetto alla vecchia legge, maggiore controllo del potere politico, vi sta manipolando, vi sta mentendo, e vi sta togliendo il potere di scegliere. Né è vero che gli scelti per votazione sono i più «bravi»: sono solo quelli che hanno avuto più voti.
Le «Disposizioni transitorie», poi, prevedono che le leggi sul Csm, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate entro un anno alla nuova norma costituzionale. Allora, non solo con la nuova legge l’ingerenza della politica sulla magistratura è ridotta, ma codesta presunta ingerenza non è di alcun beneficio all’attuale esecutivo, che sarà a scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della riforma.
Continua a leggereRiduci