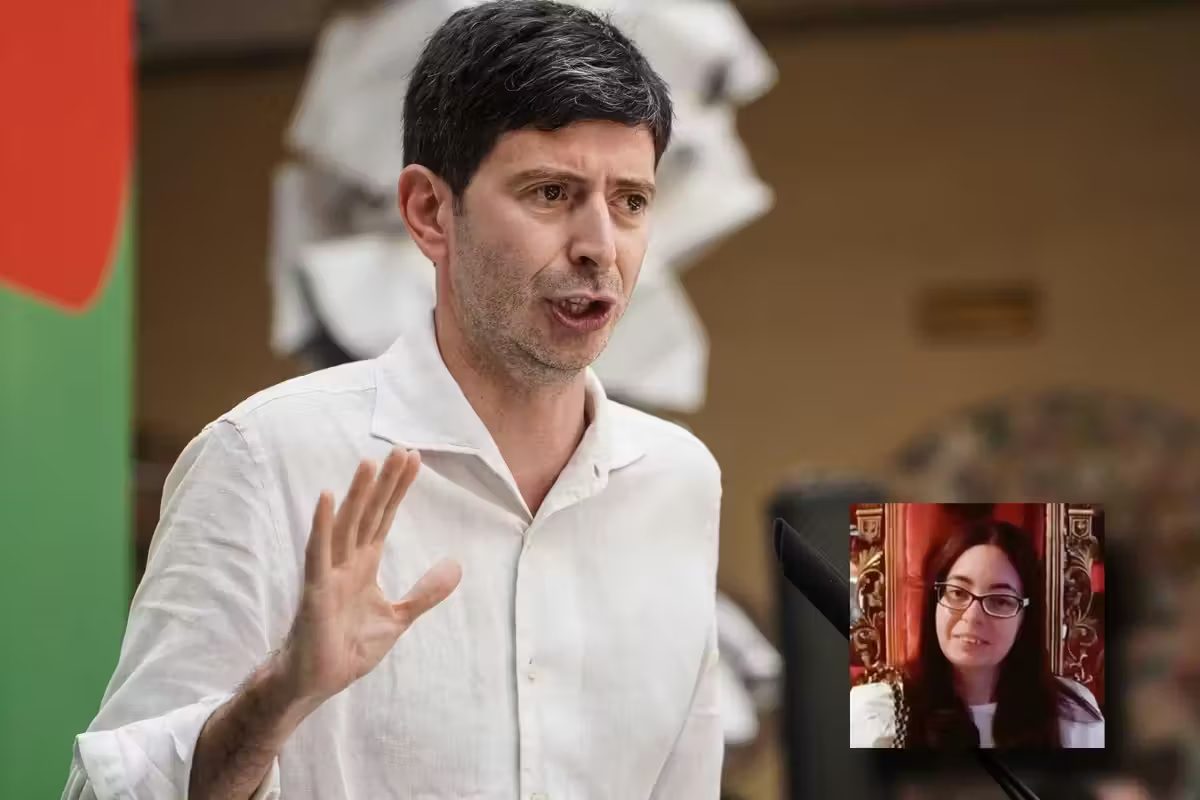Ci sono imprinting nella memoria del gusto che possono riemergere, inaspettati, con diverse sorprese. Per la generazione degli anni Cinquanta, magari cresciuta con i nonni in casa, sentire parlare di orzo rimanda immediatamente a quella scatolina di carta gialla che si trovava nella dispensa, il leoncino goloso ambasciatore di una polverina marron che faceva le veci del caffè, quello degli adulti. L’orzo un succedaneo, privo della eccitante caffeina, e quindi adatto anche a chi, cartella in resta, con il caffelatte conseguente, si avviava verso i banchi delle elementari. Per quelli nati qualche anno dopo, con il carosello a colori, ecco l’Orzobimbo, accompagnato da un claim «bim, bum, bam» che ha fatto l’epoca. Ti dava energia e così sia. Più chiaro di così.
Ma è tempo di riavvolgere la pellicola e risalire nel tempo. L’orzo è stata una delle prime coltivazioni dell’uomo una volta uscito dalle caverne. Tracce archeologiche fanno risalire le sue prime coltivazioni al 10.000 a.C. in un’area compresa nell’attuale Medio Oriente. Pianta resistente, di buona resa, senza richiedere troppo tempo o trattamenti particolari. Si diffuse - a macchia d’orzo - verso aree del pianeta dove la coltivazione di altri cereali non era sempre così facile, ad esempio gli altipiani etiopici, come alle falde del Tibet e su su fino al limite dei ghiacci polari. Cresceva quindi un po’ a tutte le latitudini, si conservava a lungo ed era facilmente trasportabile. All’epoca di etruschi e romani era la specie più coltivata assieme al frumento. Ricco di principi attivi tanto che l’intuizione dell’epoca lo ribattezzò tisana di Ippocrate, i suoi infusi efficaci per vari malanni di stagione. È probabile fosse lui al centro del miracolo che vide la moltiplicazione del pane e dei pesci citata nel vangelo di Giovanni. Laicamente sempre disponibile quale cibo dei naviganti, sottoforma di gallette di pane azzimo che venivano fatte rivivere una volta immerse nelle acque del Mediterraeno.
Plinio il vecchio lo descrive come il cibo prediletto dei gladiatori, le sue gallette davano forza ed erano di facile conservazione, tanto che questi guerrieri senza paura venivano goliardicamente chiamati «hordeari», cioè mangiatori d’orzo. Apicio, il Veronelli dell’epoca, lo proponeva in zuppa, ecletticamente abbinato ad erbe e aromi, ingentilito dal maiale, palestrato al gusto da un cocktail per palati forti: miele, aceto e l’immancabile garum. Le prime specie spontanee avevano il fusto fragile, come le radici, per cui con il vento si «allettavano», cioè si piegavano anche sino a terra dopo aver diffuso i semi nell’aria, penalizzando il raccolto. Vennero così selezionate nel tempo le varietali a maggior radicamento terreno.
Due le famiglie di base, l’orzo distico e quello polistico. Il primo con un numero più elevato di cariossidi, cioè chicchi, per spiga e rese più elevate. Le altre con meno chicchi, ma di maggiori dimensioni. La tecnica colturale perfezionata dai romani rimase praticamente immutata sino al XIX secolo, ogni famiglia custode dei suoi piccoli segreti e le relative varietali. Una antologia a tutta penisola con un’anagrafica curiosa. Troviamo così nella soleggiata Puglia l’orzo di Siberia, il cui vicino di campo poteva recitare canterino, mentre l’orgoglioso orzo maschio era toscano e nelle campagne del bolognese regnava l’orz de caval. Due semine. Autunnale, la più redditizia, e primaverile, ad integrare i granai, posto che l’uso alimentare era stato progressivamente ridotto a favore del mangime per le stalle. A fine Ottocento un importante innovazione da parte di Nazzareno Strampelli, un agronomo e genetista che rivoluzionò l’abitudinario mondo contadino. Sviluppò varietali più produttive e resistenti, un nome per tutte la leonessa.
Dall’epoca romana l’orzo era stato ridimensionato anche se ancora Dante Alighieri lo citò in una sua opera incompiuta, Il Convivio, laddove narra di «quello pane azzimo del quale si satolleranno a migliaia». Dal medioevo in poi era diventato alimento per le classi meno abbienti, con alcune zone di resistenza alimentare a prova del tempo.
Nella Puglia salentina le friselle sono una tradizione ben radicata. Ciambelline dorate che non erano solo cibo dei marinai, ma diffuse anche nelle campagne. Con la riforma fondiaria di fine Ottocento molte famiglie contadine presero pieno possesso di terreni poi da riscattare. Vivevano lunghi mesi all’interno dei furnieddhi, sorta di rustici trulli a monolocale. Cotte in forno con rami d’ulivo, venivano poi conservate entro le capase, grandi orci dal collo largo. Quando gli uomini tornavano esausti dal lavoro dei campi, le trovavano ammorbidite con l’acqua e golosamente condite con pomodorini freschi, sale e origano. Più a nord, invece, nel Bellunese, l’orzo aveva mantenuto le posizioni, considerato il clima di montagna. I villaggi disponevano dei mulini ad acqua, ognuno con il suo pistin, ovvero la macina a due ruote per la lavorazione delle sementi. La sera, a tavola, ci si godeva la panicia, ovvero una zuppa d’orzo con patate, latte e i ritagli di scarto della lavorazione del maiale quali orecchie, zampe, naso. In Sardegna si può ancora trovare su oriattu, il pane d’orzo locale. Dal gusto delicato ideale abbinamento a compagni di merenda dai sapori forti, come ad esempio formaggi (su tutti il casu marzu) o salumi. In Trentino ecco l’orzotto, sostituto del riso, declinato a seconda di quanto offriva la dispensa, da porri e patate a verze e barbabietole, ora con più ricchi speck o porcini.
A conferma che il tempo è galantuomo, anche l’orzo, gregario per necessità, è risorto a nuova vita sui ricettari domestici come della buona ristorazione. Vi hanno contribuito certamente i miglioramenti dell’ordeicoltura (la coltivazione specifica), ma anche una maggiore attenzione alle sue molte proprietà.
Se Nazzareno Strampelli è stato per certi versi ambasciatore della sua rinascita a livello nazionale, l’orzo ha avuto un altro testimonial in Yoshihide Hagiwara, un giapponese medico e farmacista che ha valorizzato le sue foglioline verdi trasformandole in green magma, un preparato disidratato da far rivivere poi come bevanda. Una bomba energetica. Concentrazioni di vitamina C sette volte superiori alle arance, di ferro cinque volte più degli spinaci e via elencando. Con queste premesse all’orzo, cereale di resistenza storica, si sono aperte nuove vie, anche a tavola, come ad esempio l’orzo alla genovese, con basilico e pinoli.
Ecumenico il tristellato Massimiliano Alajmo nel proporre orzo e caffè maritati assieme con i fagioli. Coccola estiva l’orzo in insalata con gamberi e pomodori. Non poteva mancare la sfida al dessert, con un originale tiramisù con orzo e zabaione.
E pensare che, fino al secondo dopoguerra, l’orzo veniva utilizzato come succedaneo del caffè, considerate le sanzioni imposte al Belpaese. Orzo da sempre protagonista della lavorazione della birra, che nella versione artigianale ha coinvolto anche da noi molti piccoli produttori. Commercialmente lo si può trovare in tre versioni. La più impegnativa quella integrale, che ha tutte le proprietà nutrizionali, ma richiede una giornata di ammollo prima di arrivare ai fornelli. Il decorticato, una notte a bagno, ideale tra lavorazione e conservazione dei principi attivi e il più commercialmente fruibile perlato, che non necessita di ammollo, anche se privo di gran parte delle proprietà elencate.