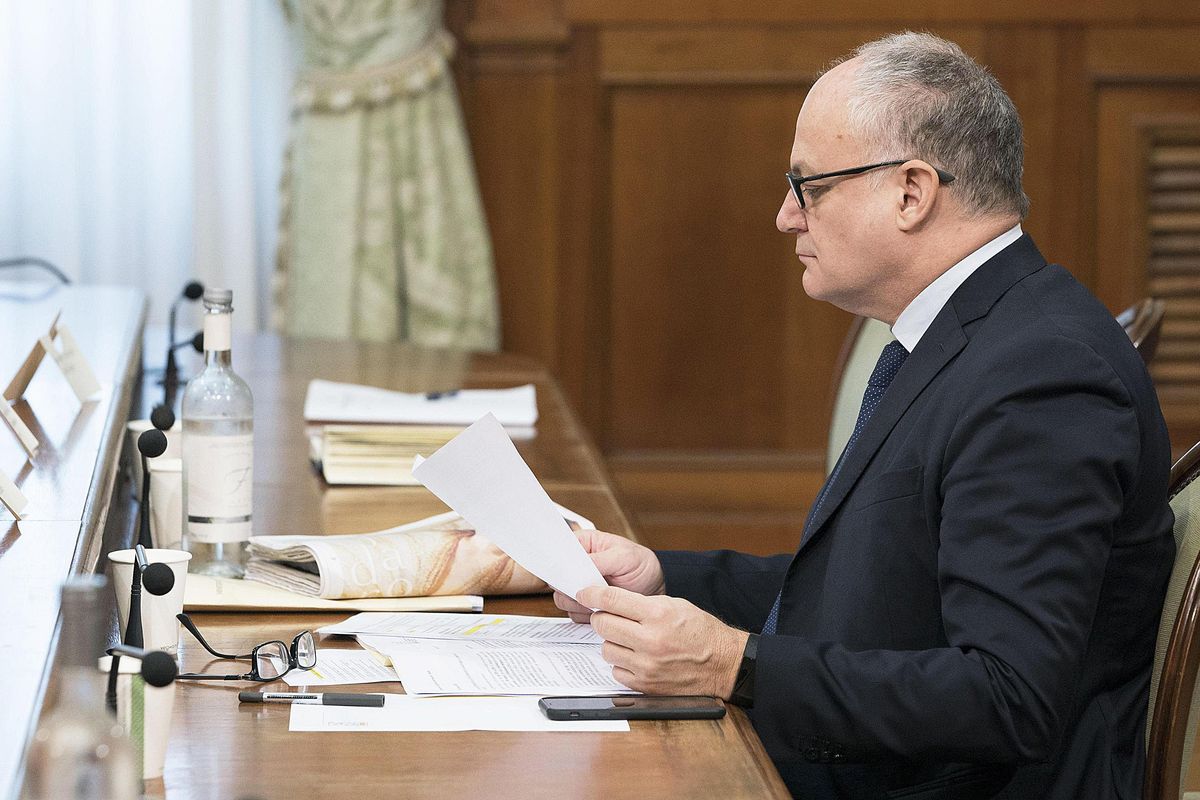True
2020-05-21
Il Bpt Italia è la prova che il debito si può piazzare. Ma Gualtieri non ha voluto
Roberto Gualtieri (Ansa)
Quattordici miliardi. Teniamo a mente questa cifra. È la somma incassata negli ultimi 3 giorni dallo Stato per il collocamento del Btp Italia a 5 anni tra i piccoli risparmiatori. E oggi tocca agli investitori istituzionali. La dimensione del successo è data dal confronto con la precedente emissione dell'ottobre 2019, quando fu raccolta la somma complessiva di 6,7 miliardi.
Ora confrontiamola con le emissioni lorde del Tesoro dell'intero mese di marzo, con parte del Paese già in quarantena: 32 miliardi, addirittura 1 in meno rispetto ai 33 miliardi del marzo 2019. Peccato che a marzo 2020 le emissioni nette siano state negative per circa 25 miliardi. Sì, avete letto bene, è tutto nero su bianco in un rapporto pubblicato da Bankitalia. Mentre cadevano le bombe sul Paese, a marzo il Tesoro ha pensato bene di emettere meno titoli di quanti ne doveva rimborsare e la differenza è pari a 25 miliardi. E, per far fronte alle uscite crescenti e alle entrate decrescenti, ha dovuto indebitarsi a breve e far massiccio ricorso alle disponibilità liquide presso la Banca d'Italia che si sono ridotte a marzo per 43 miliardi (da 73 a 30). Il livello più basso da fine 2011, i mesi bui della speculazione dei mercati contro i titoli di Stato italiani.
Il Paese era in fiamme dal 23 febbraio, e il 5 marzo al ministero del Tesoro erano ancora a contare gli spiccioli nel salvadanaio, anziché mettere mano al libretto degli assegni. Al punto che il 5 marzo il governo chiedeva al Parlamento l'autorizzazione ad un maggior deficit di soli 6,4 miliardi, portato poi a 20 miliardi l'11 marzo. Nel frattempo, dal 12 al 18 marzo, sull'onda del «non siamo qua per chiudere gli spread» di Christine Lagarde, lo spread da 200 punti saliva a sfiorare i 300 punti, prima che il consiglio straordinario della Bce del 18 lanciasse il nuovo piano di acquisti Pepp, che comunque non ha ancora riportato lo spread al livello (140) su cui stazionava prima della crisi da Covid-19.
Ecco, ora uniamo i puntini e proviamo a spiegare l'incredibile tentennare del governo in quelle settimane, il cui episodio simbolo è stata l'incertezza per i pagamenti fiscali e contributivi di lunedì 16 marzo, slittati poi al 20. Il Tesoro non poteva aprire i cordoni della borsa semplicemente perché non c'erano più soldi e non ha ritenuto opportuno andare sul mercato a chiederne altri? I numeri avvalorano tale tesi. C'è anche un'altra data da incrociare. Lunedì 16 marzo ci fu il primo Eurogruppo in cui emerse che il Mes era l'unico strumento di pronto impiego e su queste colonne raccogliemmo le indiscrezioni apparse sulla stampa estera che parlavano di funzionari del Mef al lavoro su un'ipotesi di suo utilizzo. Il Tesoro pensava quindi ad altre fonti di finanziamento del deficit (come il Mes), diverse dall'emissione di titoli sui mercati, e i suoi piani sono naufragati per la forte opposizione politica verso uno strumento altamente tossico? Eravamo nuovamente sotto il ricatto dello spread? Perché la Lagarde il 12 marzo si era limitata al pannicello caldo di soli 120 miliardi di acquisti aggiuntivi di titoli pubblici dell'eurozona, salvo fare un precipitoso aumento il 18 marzo, di fronte a segnali di difficoltà di qualche banca d'oltralpe e su sollecitazione di un angosciato Emmanuel Macron? Quale genere di timori hanno attanagliato il ministro Roberto Gualtieri nell'allargare i cordoni della borsa?
Sono numerosi i segnali che avvalorano i peggiori sospetti. Ma ci è finita di mezzo l'Italia. Misureremo nei prossimi mesi i danni che il ritardo nell'inondare di liquidità le attività produttive bloccate dalla quarantena, ha provocato al tessuto produttivo del Paese.
Ai primi di aprile il decreto «liquidità», quello della «poderosa potenza di fuoco mai vista», aveva uno stanziamento disponibile di circa 1 miliardo. Erano di nuovo finiti i soldi. Solo il 24 aprile scorso, il governo ha presentato al Parlamento la relazione per essere autorizzato ad un maggior deficit di 55 miliardi (maggior fabbisogno di 155 miliardi) e avantieri è arrivato in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 34 che ne disciplina l'utilizzo.
Ma un altro segnale che i piani fossero altri è arrivato dal dibattito parlamentare del 29 e 30 aprile per approvare la suddetta relazione ed il Def.
Ci risulta da fonti parlamentari, ed è confermato dai resoconti stenografici dell'aula, che in quell'occasione ci fu una forte pressione da parte del Pd ed Iv, affinché fosse concessa via libera al governo e quindi al ministro Gualtieri, nella scelta degli strumenti di finanziamento, segnatamente il Mes, e solo una lotta all'ultima virgola sul testo della risoluzione di maggioranza, abbia evitato di farne esplicita menzione. In particolare, la risoluzione di maggioranza che ha approvato il Def ha impegnato il governo «…a perseguire una politica di attenta ed efficace transizione tra la fase di emergenza e la fase di ripresa dello sviluppo anche utilizzando gli strumenti appropriati tra quelli resi disponibili dalle istituzioni europee…». Iv ha premuto fino all'ultimo affinché si scrivesse «tutti gli strumenti europei compreso il Mes», così come dichiarato da Davide Faraone al Senato.
Allora sorge un legittimo dubbio. Il ministro Gualtieri ha voluto con quella frase esaurire il passaggio parlamentare auspicabile nel caso di accesso al Mes e ritenersi quindi già autorizzato dal Parlamento a mettere la sua firma sotto quella richiesta capestro che abbiamo pubblicato qualche giorno fa?
Ma quali denari a fondo perduto. L’Ue pretende rimborsi e riforme
Non è debito comune, non sono soldi regalati, e allora che cos'è? Più che alle morbide caramelle della famosa canzoncina che impazzava sul finire degli anni Ottanta, il recovery fund proposto da Emmanuel Macron e Angela Merkel ha semmai il gusto di un boccone amaro. E man mano che affiorano alla luce i dettagli del piano franco-tedesco da 500 miliardi illustrato lunedì, le gambe della narrazione messa in piedi dal premier Conte, e sostenuta a gran voce dalla quasi totalità della stampa nostrana, si fanno sempre più corte.
Sono davvero «soldi a fondo perduto» che «non andranno mai ripagati»? Il primo altolà agli euroentusiasti giunge proprio dalla Germania, uno dei due Paesi che, insieme alla Francia, di quel progetto si è fatto promotore davanti all'intera Unione europea. Nel corso della conferenza stampa giornaliera, il portavoce dell'esecutivo tedesco Steffen Seibert ha messo qualche puntino sulle «i»: «La proposta non ha nulla a che fare né con l'emissione di prestiti comuni, né di debito comune». Già, ma allora - per tornare alla domanda iniziale - in cosa consiste l'idea franco-tedesca? Una cosa è certa, spiega Seiffert, e cioè che esiste un «piano vincolante di rimborso».
Esistono almeno tre motivi che spingono Berlino a negare la mutualizzazione del debito. Due li spiega bene Bloomberg in una lunga e dettagliata analisi dedicata alle criticità del recovery fund targato Merkel e Macron e pubblicata per l'appunto ieri. Primo: le emissioni di debito comune non convengono al governo tedesco né dal punto di vista economico (la Germania si troverebbe a dover contribuire più di qualunque altro Paese al fondo, senza peraltro trovarsi a doverne mai usufruire), né tanto meno da quello politico (il danno in termini elettorale per la cancelliera sarebbe incalcolabile). Secondo: l'articolo 125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, base del diritto continentale, vieta espressamente che gli Stati membri si facciano carico dei debiti altrui. Il terzo lo aggiungiamo noi: ammettere pubblicamente un cambio di rotta verso qualunque strumento che possa assomigliare, anche solo lontanamente, agli eurobond causerebbe l'immediata rottura del negoziato. Ricordiamo che il recovery fund è legato all'esito della trattativa sul budget Ue 2021-2027, la cui approvazione richiede l'unanimità in Consiglio.
Ma il maldestro tentativo di ieri da parte di Seiffert di gettare acqua sul fuoco dell'ostilità manifesta dei Paesi del Nord sembra essere servito a ben poco. Non per niente, i quattro Stati contrari al piano franco-tedesco ieri hanno prontamente rincarato la dose: Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sono infatti determinate a difendere con le unghie e con i denti la linea Maginot tracciata intorno agli aiuti per la pandemia. «Vogliamo essere solidali con gli Stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi», ha dichiarato ieri il premier austriaco Sebastian Kurz nel corso di un'intervista al quotidiano Oberösterreichischen Nachrichten, «riteniamo però che la strada giusta sia quella dei prestiti e non dei contributi». E il ministro austriaco degli Affari europei, Karoline Edtstadler, si è spinto ancora più avanti, individuando quelli che a suo dire sarebbero i destinatari del fondo: «Una cosa è comunque certa: i soldi che ora vanno a Italia, Spagna oppure Francia vanno usati per superare la crisi e vanno restituiti».
Nel pomeriggio di ieri, poi, si è aggiunto il premier olandese Mark Rutte a dare manforte al collega austriaco. Confermando, casomai ce ne fosse bisogno, che la proposta dei «quattro frugali» non prevede aiuti a fondo perduto, ma solo prestiti da restituire. «Se si richiede un aiuto», ha spiegato il premier olandese, «è necessario attuare riforme di vasta portata in modo da poter essere autosufficienti la prossima volta». Senza risparmiare una stoccata ai Paesi (a suo dire) spreconi: «Noi spendiamo 13 miliardi di soldi nostri perché abbiamo spazio fiscale, bisogna avere il coraggio di chiedersi perché alcuni abbiano fatto le riforme, e altri invece abbiano fallito».
Nemmeno Bruxelles crede alla storiella del pasto gratis. Nel recovery instrument «ci sarà un chiaro legame con le riforme», parola del vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. «Finanzieremo pacchetti di riforme e investimenti degli Stati membri, e il Semestre europeo (cioè il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio da parte della Commissione, ndr) e le raccomandazioni faranno da guida nel preparare i piani di ripresa». Tutto, dunque, si svolgerà sotto l'attenta sorveglianza degli euroburocrati. Nel frattempo, ha ricordato ieri Dombrovskis, «il Patto di stabilità non è sospeso, una volta che la ripresa sarà in corso, il focus sarà sul raggiungimento di posizioni fiscali e di debito sostenibile, mentre si stimolano gli investimenti e gli Stati dovranno tornare ai loro obiettivi di bilancio di medio termine». A conti fatti, nonostante i fiumi di inchiostro sparsi dai nostri retroscenisti, sotto il sole non c'è proprio nulla di nuovo.
Continua a leggereRiduci
Altra giornata record, raccolti 14 miliardi. Eppure il Tesoro non ha ampliato le aste malgrado l'emergenza. Anzi, il ministro ha accentrato le scelte: è il preludio al Mes?Ma quali denari a fondo perduto. L'Ue pretende rimborsi e riforme. Ogni giorno escono dettagli che svelano la realtà sul «bazooka» di Angela Merkel ed Emmanuel Macron osannato dai media Berlino frena sulla condivisione del debito, mentre Valdis Dombrovskis parla delle contropartite politiche agli aiuti.Lo speciale comprende due articoli. Quattordici miliardi. Teniamo a mente questa cifra. È la somma incassata negli ultimi 3 giorni dallo Stato per il collocamento del Btp Italia a 5 anni tra i piccoli risparmiatori. E oggi tocca agli investitori istituzionali. La dimensione del successo è data dal confronto con la precedente emissione dell'ottobre 2019, quando fu raccolta la somma complessiva di 6,7 miliardi. Ora confrontiamola con le emissioni lorde del Tesoro dell'intero mese di marzo, con parte del Paese già in quarantena: 32 miliardi, addirittura 1 in meno rispetto ai 33 miliardi del marzo 2019. Peccato che a marzo 2020 le emissioni nette siano state negative per circa 25 miliardi. Sì, avete letto bene, è tutto nero su bianco in un rapporto pubblicato da Bankitalia. Mentre cadevano le bombe sul Paese, a marzo il Tesoro ha pensato bene di emettere meno titoli di quanti ne doveva rimborsare e la differenza è pari a 25 miliardi. E, per far fronte alle uscite crescenti e alle entrate decrescenti, ha dovuto indebitarsi a breve e far massiccio ricorso alle disponibilità liquide presso la Banca d'Italia che si sono ridotte a marzo per 43 miliardi (da 73 a 30). Il livello più basso da fine 2011, i mesi bui della speculazione dei mercati contro i titoli di Stato italiani. Il Paese era in fiamme dal 23 febbraio, e il 5 marzo al ministero del Tesoro erano ancora a contare gli spiccioli nel salvadanaio, anziché mettere mano al libretto degli assegni. Al punto che il 5 marzo il governo chiedeva al Parlamento l'autorizzazione ad un maggior deficit di soli 6,4 miliardi, portato poi a 20 miliardi l'11 marzo. Nel frattempo, dal 12 al 18 marzo, sull'onda del «non siamo qua per chiudere gli spread» di Christine Lagarde, lo spread da 200 punti saliva a sfiorare i 300 punti, prima che il consiglio straordinario della Bce del 18 lanciasse il nuovo piano di acquisti Pepp, che comunque non ha ancora riportato lo spread al livello (140) su cui stazionava prima della crisi da Covid-19. Ecco, ora uniamo i puntini e proviamo a spiegare l'incredibile tentennare del governo in quelle settimane, il cui episodio simbolo è stata l'incertezza per i pagamenti fiscali e contributivi di lunedì 16 marzo, slittati poi al 20. Il Tesoro non poteva aprire i cordoni della borsa semplicemente perché non c'erano più soldi e non ha ritenuto opportuno andare sul mercato a chiederne altri? I numeri avvalorano tale tesi. C'è anche un'altra data da incrociare. Lunedì 16 marzo ci fu il primo Eurogruppo in cui emerse che il Mes era l'unico strumento di pronto impiego e su queste colonne raccogliemmo le indiscrezioni apparse sulla stampa estera che parlavano di funzionari del Mef al lavoro su un'ipotesi di suo utilizzo. Il Tesoro pensava quindi ad altre fonti di finanziamento del deficit (come il Mes), diverse dall'emissione di titoli sui mercati, e i suoi piani sono naufragati per la forte opposizione politica verso uno strumento altamente tossico? Eravamo nuovamente sotto il ricatto dello spread? Perché la Lagarde il 12 marzo si era limitata al pannicello caldo di soli 120 miliardi di acquisti aggiuntivi di titoli pubblici dell'eurozona, salvo fare un precipitoso aumento il 18 marzo, di fronte a segnali di difficoltà di qualche banca d'oltralpe e su sollecitazione di un angosciato Emmanuel Macron? Quale genere di timori hanno attanagliato il ministro Roberto Gualtieri nell'allargare i cordoni della borsa?Sono numerosi i segnali che avvalorano i peggiori sospetti. Ma ci è finita di mezzo l'Italia. Misureremo nei prossimi mesi i danni che il ritardo nell'inondare di liquidità le attività produttive bloccate dalla quarantena, ha provocato al tessuto produttivo del Paese.Ai primi di aprile il decreto «liquidità», quello della «poderosa potenza di fuoco mai vista», aveva uno stanziamento disponibile di circa 1 miliardo. Erano di nuovo finiti i soldi. Solo il 24 aprile scorso, il governo ha presentato al Parlamento la relazione per essere autorizzato ad un maggior deficit di 55 miliardi (maggior fabbisogno di 155 miliardi) e avantieri è arrivato in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 34 che ne disciplina l'utilizzo.Ma un altro segnale che i piani fossero altri è arrivato dal dibattito parlamentare del 29 e 30 aprile per approvare la suddetta relazione ed il Def.Ci risulta da fonti parlamentari, ed è confermato dai resoconti stenografici dell'aula, che in quell'occasione ci fu una forte pressione da parte del Pd ed Iv, affinché fosse concessa via libera al governo e quindi al ministro Gualtieri, nella scelta degli strumenti di finanziamento, segnatamente il Mes, e solo una lotta all'ultima virgola sul testo della risoluzione di maggioranza, abbia evitato di farne esplicita menzione. In particolare, la risoluzione di maggioranza che ha approvato il Def ha impegnato il governo «…a perseguire una politica di attenta ed efficace transizione tra la fase di emergenza e la fase di ripresa dello sviluppo anche utilizzando gli strumenti appropriati tra quelli resi disponibili dalle istituzioni europee…». Iv ha premuto fino all'ultimo affinché si scrivesse «tutti gli strumenti europei compreso il Mes», così come dichiarato da Davide Faraone al Senato.Allora sorge un legittimo dubbio. Il ministro Gualtieri ha voluto con quella frase esaurire il passaggio parlamentare auspicabile nel caso di accesso al Mes e ritenersi quindi già autorizzato dal Parlamento a mettere la sua firma sotto quella richiesta capestro che abbiamo pubblicato qualche giorno fa?<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/il-bpt-italia-e-la-prova-che-il-debito-si-puo-piazzare-ma-gualtieri-non-ha-voluto-2646048039.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="ma-quali-denari-a-fondo-perduto-lue-pretende-rimborsi-e-riforme" data-post-id="2646048039" data-published-at="1590014897" data-use-pagination="False"> Ma quali denari a fondo perduto. L’Ue pretende rimborsi e riforme Non è debito comune, non sono soldi regalati, e allora che cos'è? Più che alle morbide caramelle della famosa canzoncina che impazzava sul finire degli anni Ottanta, il recovery fund proposto da Emmanuel Macron e Angela Merkel ha semmai il gusto di un boccone amaro. E man mano che affiorano alla luce i dettagli del piano franco-tedesco da 500 miliardi illustrato lunedì, le gambe della narrazione messa in piedi dal premier Conte, e sostenuta a gran voce dalla quasi totalità della stampa nostrana, si fanno sempre più corte. Sono davvero «soldi a fondo perduto» che «non andranno mai ripagati»? Il primo altolà agli euroentusiasti giunge proprio dalla Germania, uno dei due Paesi che, insieme alla Francia, di quel progetto si è fatto promotore davanti all'intera Unione europea. Nel corso della conferenza stampa giornaliera, il portavoce dell'esecutivo tedesco Steffen Seibert ha messo qualche puntino sulle «i»: «La proposta non ha nulla a che fare né con l'emissione di prestiti comuni, né di debito comune». Già, ma allora - per tornare alla domanda iniziale - in cosa consiste l'idea franco-tedesca? Una cosa è certa, spiega Seiffert, e cioè che esiste un «piano vincolante di rimborso». Esistono almeno tre motivi che spingono Berlino a negare la mutualizzazione del debito. Due li spiega bene Bloomberg in una lunga e dettagliata analisi dedicata alle criticità del recovery fund targato Merkel e Macron e pubblicata per l'appunto ieri. Primo: le emissioni di debito comune non convengono al governo tedesco né dal punto di vista economico (la Germania si troverebbe a dover contribuire più di qualunque altro Paese al fondo, senza peraltro trovarsi a doverne mai usufruire), né tanto meno da quello politico (il danno in termini elettorale per la cancelliera sarebbe incalcolabile). Secondo: l'articolo 125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, base del diritto continentale, vieta espressamente che gli Stati membri si facciano carico dei debiti altrui. Il terzo lo aggiungiamo noi: ammettere pubblicamente un cambio di rotta verso qualunque strumento che possa assomigliare, anche solo lontanamente, agli eurobond causerebbe l'immediata rottura del negoziato. Ricordiamo che il recovery fund è legato all'esito della trattativa sul budget Ue 2021-2027, la cui approvazione richiede l'unanimità in Consiglio. Ma il maldestro tentativo di ieri da parte di Seiffert di gettare acqua sul fuoco dell'ostilità manifesta dei Paesi del Nord sembra essere servito a ben poco. Non per niente, i quattro Stati contrari al piano franco-tedesco ieri hanno prontamente rincarato la dose: Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sono infatti determinate a difendere con le unghie e con i denti la linea Maginot tracciata intorno agli aiuti per la pandemia. «Vogliamo essere solidali con gli Stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi», ha dichiarato ieri il premier austriaco Sebastian Kurz nel corso di un'intervista al quotidiano Oberösterreichischen Nachrichten, «riteniamo però che la strada giusta sia quella dei prestiti e non dei contributi». E il ministro austriaco degli Affari europei, Karoline Edtstadler, si è spinto ancora più avanti, individuando quelli che a suo dire sarebbero i destinatari del fondo: «Una cosa è comunque certa: i soldi che ora vanno a Italia, Spagna oppure Francia vanno usati per superare la crisi e vanno restituiti». Nel pomeriggio di ieri, poi, si è aggiunto il premier olandese Mark Rutte a dare manforte al collega austriaco. Confermando, casomai ce ne fosse bisogno, che la proposta dei «quattro frugali» non prevede aiuti a fondo perduto, ma solo prestiti da restituire. «Se si richiede un aiuto», ha spiegato il premier olandese, «è necessario attuare riforme di vasta portata in modo da poter essere autosufficienti la prossima volta». Senza risparmiare una stoccata ai Paesi (a suo dire) spreconi: «Noi spendiamo 13 miliardi di soldi nostri perché abbiamo spazio fiscale, bisogna avere il coraggio di chiedersi perché alcuni abbiano fatto le riforme, e altri invece abbiano fallito». Nemmeno Bruxelles crede alla storiella del pasto gratis. Nel recovery instrument «ci sarà un chiaro legame con le riforme», parola del vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. «Finanzieremo pacchetti di riforme e investimenti degli Stati membri, e il Semestre europeo (cioè il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio da parte della Commissione, ndr) e le raccomandazioni faranno da guida nel preparare i piani di ripresa». Tutto, dunque, si svolgerà sotto l'attenta sorveglianza degli euroburocrati. Nel frattempo, ha ricordato ieri Dombrovskis, «il Patto di stabilità non è sospeso, una volta che la ripresa sarà in corso, il focus sarà sul raggiungimento di posizioni fiscali e di debito sostenibile, mentre si stimolano gli investimenti e gli Stati dovranno tornare ai loro obiettivi di bilancio di medio termine». A conti fatti, nonostante i fiumi di inchiostro sparsi dai nostri retroscenisti, sotto il sole non c'è proprio nulla di nuovo.
(IStock)
È quanto stabilisce l’ordinanza (n. 33227/2025) emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria depositata in cancelleria il 19 dicembre, come riportato da Italia Oggi.
Il problema è che per il Fisco, finché c’è una proprietà «formale», chi detiene il terreno deve comunque pagare l’Imu. È vero che il Comune ha il bene in mano ma il proprietario è ancora giuridicamente il possessore fino all’esproprio. Quindi deve pagare, non c’è scampo, anche alla luce del fatto che subisce un danno. Il Comune diventa contemporaneamente occupante ed esattore. Questo è il paradosso considerato però normale dalla giurisdizione.
L’obbligo del versamento dell’Imu finisce solo quando subentra l’ablazione del bene, ovvero c’è il trasferimento della proprietà tramite il decreto di esproprio, perché solo in quel momento cessa la soggettività passiva del proprietario.
Il punto di partenza dell’ordinanza è la richiesta da parte del Comune di Salerno a un contribuente di una imposta Imu relativa al 2012 su alcune aree edificabili occupate d’urgenza dall’amministrazione per la realizzazione di opere di interesse pubblico. La Suprema Corte ha quindi chiarito che l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della pubblica amministrazione non priva il proprietario del possesso del bene sino a quando non intervenga l’ablazione del fondo. Questo vuol dire, precisa la Cassazione, che il proprietario resta soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante e che la realizzazione di un’opera pubblica su un fondo soggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell’acquisto ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà del fondo in favore della pubblica amministrazione. Questa resta mera detentrice del fondo occupato e trasformato, fermo tuttavia il possesso del proprietario.
Cioè il Comune occupa un terreno, ci fa ciò che vuole e il proprietario non solo deve sottostare a questa decisione, ma anche continuare a pagare l’Imu come se potesse disporre liberamente ancora del proprio bene.
Già nel 2016 la Cassazione si era occupata dei provvedimenti ablatori, cioè degli espropri. Aveva chiarito che l’occupazione temporanea di urgenza, così come la requisizione, non privano il proprietario del possesso del bene, fino a quando non intervenga l’ablazione del bene stesso. Il proprietario così rimane soggetto passivo dell’imposta, cioè deve continuare a pagare l’Imu, anche se l’immobile è detenuto dall’occupante.
Tutto questo discorso però non vale se il Comune ha preso il terreno e magari lo ha recintato e ci sta costruendo sopra e impedisce al proprietario di entrarci. Quindi in questo caso non c’è più il possesso e se la trasformazione del bene è palese, l’Imu non è più dovuta. Nell’ordinanza si fa riferimento al tema della «conservazione del possesso o della detenzione solo animo» che in diritto significa possedere una cosa anche se non viene toccata ogni secondo, non ci si è fisicamente dentro ma si sa che ci si può andare quando si vuole, come può essere la casa al mare. Se questa possibilità è preclusa perché il Comune ha iniziato i lavori, ha transennato l’area impedendo fisicamente l’accesso al proprietario, e l’opera pubblica viene realizzata per cui c’è una trasformazione irreversibile del bene (se ad esempio viene colata una gettata di cemento), allora il legame tra il proprietario e il bene decade. Di conseguenza non essendoci il possesso, non c’è l’obbligo di pagare l’Imu anche se l’esproprio formale non è ancora stato completato. In questo modo l’ordinanza protegge il contribuente contro le pretese di alcuni Comuni che vorrebbero i soldi dell’Imu fino all’ultimo timbro dell’esproprio.
Continua a leggereRiduci
(IStock)
Questo punto va chiarito. Infatti, la direttiva richiede che vi sia una legge nazionale che sancisce questo divieto di nuovi incentivi alle caldaie a gas, e secondo la Commissione l’Italia non ha promulgato tale legge. In pratica, nel nostro Paese gli incentivi sono stati effettivamente già eliminati dalla legge di bilancio 2025, che ha stralciato le caldaie dagli elementi soggetti alle detrazioni fiscali come ecobonus o bonus ristrutturazione. Ma secondo Bruxelles l’Italia non ha «pienamente attuato né spiegato in modo esauriente» la trasposizione formale di quell’obbligo previsto dalla direttiva, consentendo ad esempio gli incentivi del Conto termico 2.0 per la Pubblica amministrazione. In altre parole, Bruxelles dice che i testi legislativi italiani non hanno chiarito e disciplinato in modo completo l’eliminazione graduale degli incentivi per i generatori autonomi a combustibili fossili (tra cui le caldaie a gas), secondo i criteri e la scadenza previsti dalla Epbd. Questioni di lana caprina, insomma.
La seconda scadenza saltata, invece, ben più importante, è quella del 31 dicembre 2025, data entro cui doveva essere inviata a Bruxelles la bozza del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (Nbrp - National building renovation plans). La bozza dovrebbe poi essere seguita dalla versione finale entro il 31 dicembre 2026. L’Italia non ha inviato il Piano né è chiaro quando questo verrà inviato. Anche altri grandi Paesi come Francia e Germania temporeggiano.
Nel luglio scorso, la legge di delegazione europea approvata dal Consiglio dei ministri non ha incluso la direttiva Epbd tra i testi da recepire, e a novembre il Parlamento ha respinto alcuni emendamenti che avrebbero inserito il recepimento nel disegno di legge.
Questa legge è il veicolo parlamentare solitamente utilizzato per delegare il governo a recepire le direttive. Lo stralcio esplicito della direttiva «Case green» significa che per il suo recepimento sarà necessario un disegno di legge ad hoc, cosa che può prolungare i tempi anche di molto. Ma del resto la ragione è piuttosto chiara. La direttiva tocca argomenti delicatissimi come la proprietà privata delle abitazioni, un tema molto sensibile nel nostro Paese.
Il recepimento della direttiva potrebbe essere anche frazionato in diverse norme parziali, a questo punto, con ulteriore allungamento dei tempi. Ma anche in Germania la direttiva viene recepita attraverso norme parziali e non con una legge ad hoc.
Può darsi che sia proprio questa la strategia del governo, cioè prendere tempo in attesa di capire come soffia il vento politico a Bruxelles, dove la maggioranza Ursula scricchiola, o annacquare le disposizioni.
Il recepimento della direttiva Epbd è affidato al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, guidato da Gilberto Pichetto Fratin. La direttiva impone agli Stati una serie di obiettivi di miglioramento delle prestazioni energetiche scandite fino al 2050, con l’obbligo di intervenire prioritariamente sugli edifici oggi più inefficienti (quelli nelle classi energetiche più basse). Le stime sui costi di una ristrutturazione, secondo i criteri richiesti dalla direttiva, vanno dai 35.000 a 60.000 euro per unità immobiliare, con un impatto cumulato per i proprietari italiani di circa 267 miliardi di euro nei prossimi 20 anni.
A questo si aggiunge l’inasprimento di requisiti tecnici, con la revisione degli attestati di prestazione energetica, standard più severi per nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti e l’introduzione progressiva degli edifici a emissioni zero. Una cornice che restringe ulteriormente la libertà progettuale e tecnologica, imponendo obblighi come l’integrazione del fotovoltaico anche in contesti in cui la fattibilità e la reale utilità sono come minimo discutibili.
Infine, la direttiva rafforza il monitoraggio dei consumi energetici e introduce nuova burocrazia come i cosiddetti «passaporti di ristrutturazione», presentati come supporto alla pianificazione. Nella sostanza, si tratta di un ulteriore livello di adempimenti, controllo e burocrazia che rischia di trasformare la gestione degli immobili in un inferno. Il solito groviglio made in Bruxelles dal quale c’è solo da sperare di restare immuni.
Continua a leggereRiduci
La Commissione europea lancia la nuova Strategia antirazzista per il 2026: miliardi di euro per aumentare la sorveglianza digitale "contro l'odio", rieducare studenti e insegnanti, irreggimentare i media.
Papa Leone XIV. Nel riquadro, Kiko Argüello (Ansa)
Nato agli inizi degli anni Sessanta in Spagna, ad opera di due laici spagnoli, Kiko Argüello e Carmen Hernández con il sostegno dell’allora arcivescovo di Madrid, Casimiro Morcillo González, il Cammino si è diffuso in tutti i cinque Continenti ed è presente in più di 1.000 diocesi di 105 nazioni. Il carisma, la specificità, del Cammino neocatecumenale, è di non dare per scontata la fede; anzi di essere un percorso graduale di iniziazione alla fede e alla vita cristiana, che insegna ad incarnare la fede in ogni fatto e gesto della vita quotidiana, partendo proprio da eventi di dolore e sofferenza di fronte ai quali la ragione si perde e non ha parole di senso. Quando San Giovanni Paolo II lanciò il forte appello alla «nuova evangelizzazione», nel 1979, nello storico discorso tenuto a Nowa Huta, in Polonia, come risposta alla sfide del mondo sempre più secolarizzato, invitando a ripartire dall’annuncio pasquale della morte e Resurrezione di Gesù Cristo con un nuovo slancio missionario, il Cammino accolse l’appello e diede inizio a una stagione di missio ad gentes con presbiteri, laici e intere famiglie, itineranti in ogni angolo della Terra, dalla sperduta Siberia alla Terra del Fuoco. In particolare, le famiglie neocatecumenali hanno dato vita a una nuova, vera e propria implantatio ecllesiae, scegliendo di lasciare la propria città, per vivere in paesi stranieri, profondamente scristianizzati, come cellule vive di vita cristiana, nella certezza che «vedere la fede, invita alla fede».
Fu proprio papa Giovanni Paolo II a inviare in missione le prime famiglie, nel 1983, con il mandato che la Chiesa ha ricevuto dal suo stesso «fondatore»: «Andate e fate discepole tutte le genti, annunciando loro il Vangelo». A loro si è rivolto papa Leone, esprimendo il suo grazie: hanno lasciato «le sicurezze della vita ordinaria» e sono partite «con l’unico desiderio di annunciare il Vangelo ed essere testimoni dell’amore di Dio».
Negli stessi anni, cominciarono a nascere seminari per la «nuova evangelizzazione», a partire da Roma, sotto il titolo e la protezione della Redemptoris Mater. Ora se ne contano più di 100 in tutto il mondo. Un segno speciale della vitalità dell’esperienza neocatecumenale è proprio la presenza di numerose vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e consacrata, sia maschili che femminili, confermata anche dall’ultima chiamata vocazionale in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Tor Vergata: 130.000 giovani del Cammino, con 10.000 circa disposti a iniziare il percorso verso la definitiva consacrazione. In conclusione, papa Leone ha esortato a vivere in pienezza la comunione nella Chiesa: «La Chiesa vi accompagna, vi sostiene, vi è grata per ciò che fate, per il vostro impegno, per la vostra gioiosa testimonianza, per il servizio che svolgete nella Chiesa e nel mondo».
Continua a leggereRiduci