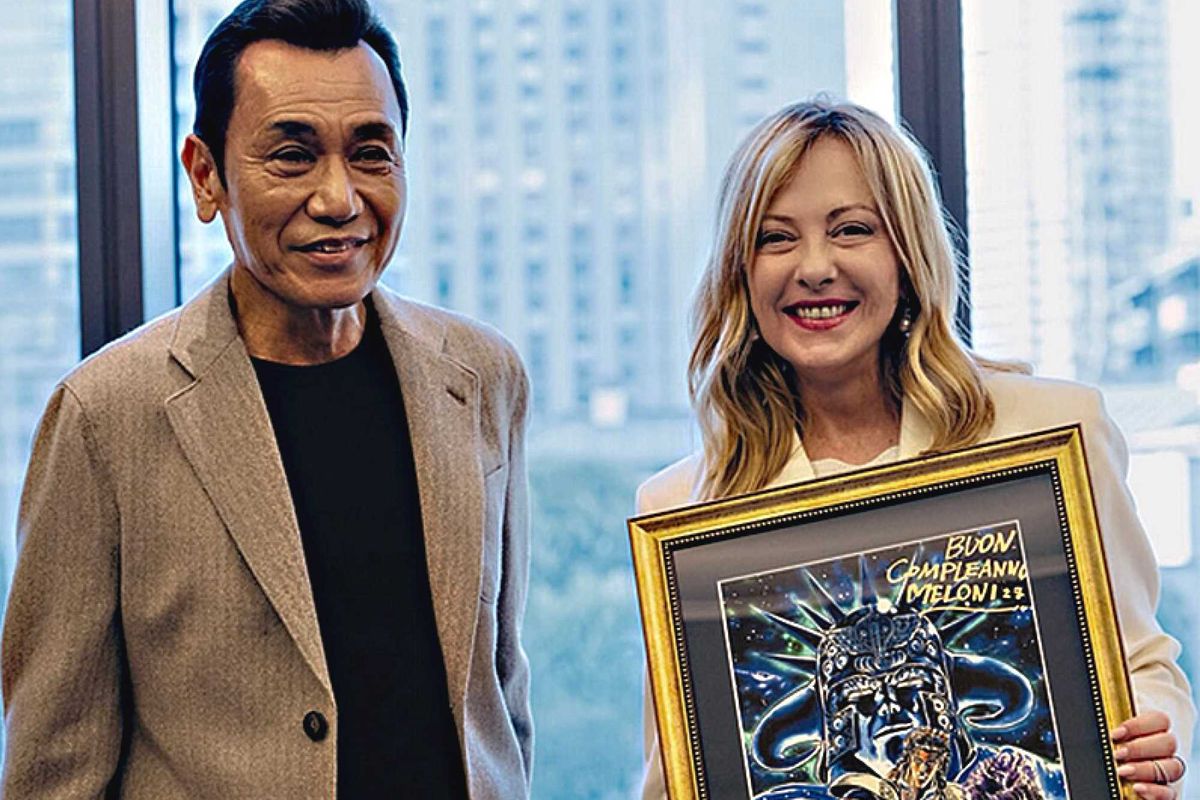I media adesso riscoprono Ratzinger per dipingerlo come un teologo rosso

di diventare Papa e che vengono ora riproposte dalla Libreria editrice vaticana in un volume (parte dell’opera omnia ratzingeriana) intitolato In dialogo con il proprio tempo. Un conto, però, è rivalutare, un altro conto è mistificare. I due testi, infatti, sono stati presentati come se fossero un concentrato di pensiero progressista: quasi a suggerire che Ratzinger, da cardinale, fosse molto più sensibile alle sirene della modernità di come si sarebbe dimostrato una volta salito al soglio pontificio. La Stampa, riportando una conversazione del 1992, lo presenta come un «progressista» favorevole ad «aprire le porte della Chiesa». Repubblica, citando un testo del 1997, tira in ballo «la lezione di Pasolini alla Chiesa», e rimarca il fatto che «l’allora cardinale Ratzinger si schierava con un intellettuale non proprio vicino alle gerarchie ecclesiastiche».
Esisteva dunque un teologo progressista prima del Papa conservatore? Niente affatto. Anzi, a dirla tutta non esistevano né il progressista né il conservatore. E a rivelarlo con chiarezza sono proprio le parole che Ratzinger dedica a Pier Paolo Pasolini.
Nell’intervista registrata nel 1997 per una radio tedesca, August Everding chiede al futuro Papa: «Lei sa che Pasolini ha detto che la Chiesa dovrebbe stare all’opposizione. Ha ragione?». La risposta è cristallina: Non mi esprimerei in termini così apodittici, ci sono anche tante cose che la Chiesa deve approvare. Non deve essere contro solo per principio, ma distinguere. Anche nella società moderna ci sono molte cose che possiamo approvare, per cui non dobbiamo semplicemente vincolarci a stare nei banchi dell’opposizione. Ma Pasolini ha ragione nel senso che ogni società è tentata di adattarsi a forme di vita che poi in qualche modo divengono ingiuste e disumane e che perciò l’opposizione è sempre necessaria. In questo senso la Chiesa deve veramente avere sempre il coraggio di stare all’opposizione contro ciò che è dominante e che tutti reputano giusto; ma non acriticamente: ci sono e ci saranno sempre anche molte cose buone. Ma il coraggio di opporsi, proprio in cose molto comuni, quello deve esserci».
A ben vedere, queste frasi rappresentano una potente lezione per la Chiesa di oggi, ma non nel senso che Repubblica suggerisce. Il «coraggio di opporsi» di cui l’allora cardinale trattava nasce dalla consapevolezza di essere nel mondo ma non del mondo. Ratzinger, dunque, non ha in qualche modo recitato la parte di antagonista o nemico del conservatorismo: ha spiegato che esistono aspetti del mondo ai quali non ci si può e non ci si deve adattare, ai quali bisogna opporsi con forza. Con tutta probabilità sono, almeno in parte, gli stessi a cui l’ultimo Pasolini si è più volte richiamato: la lotta al consumismo, la difesa dell’identità e della tradizione contro l’avanzata delle forze livellatrici della modernità. Temi che oggi, se vogliamo, appartengono più ai conservatori che ai progressisti. Ma la forza di Ratzinger sta proprio nel superamento di tali dicotomie, e nella ritrovata centralità di un pensiero cristiano robusto e per nulla debole.
Quali siano gli aspetti della modernità a cui non ci si deve piegare Ratzinger lo ribadisce più volte. Lo fa con decisione in una conversazione del 1994 con Martin Lohmann per il Reihnischer Merkur, anch’essa contenuta nel volume che abbiamo potuto sfogliare. Il discorso prende le mosse da una riflessione sul concetto di autorità, così tanto osteggiato nel mondo moderno. «L’autorità fallisce quando è una pretesa di dominio solo per la propria brama di potere. Ha invece una funzione quando non esprime il suo io privato e la volontà di potere dell’io, ma è, diciamo, permeabilità per il bene da portare insieme», spiega Ratzinger. «Questo è il senso dell’autorità nella tradizione della Chiesa a partire dalla Sacra Scrittura: che chi sa di essere stato chiamato a essere pastore non vuole affermare sé stesso, né cerca d’imporre agli altri opinioni private che per qualsivoglia ragione egli si sia formato; ma che gli è stato comunicato qualcosa, che ha percepito una voce dall’alto, se mi è permesso esprimermi così. Deve mettere a disposizione quello che gli è stato comunicato affinché con il suo aiuto possano vederlo anche gli altri. Credo sia molto importante che una tale autorità, come è prescritto dalla Bibbia e dalla tradizione della fede, non significhi esercizio del potere, ma al contrario sia la rinuncia a vivere i propri desideri, permeabilità alla voce della creazione e del Creatore; e, in questo senso, affermi e renda presente quello che l’autorità veramente ha, e cioè la verità, i valori».
Essere all’opposizione significa, dunque, diventare «testimoni della verità», difenderla contro le imposizioni di ogni genere, a partire da quelle politiche. «Non appena si pensa che tutto debba essere deciso da maggioranze, la democrazia si cambia in tirannia, perché il gruppo oppresso allora è sempre la minoranza, ed essa può essere anche molto numerosa, mentre la maggioranza può essere molto casuale», dice Ratzinger. «Il veicolo per le decisioni normali è la maggioranza, non ne abbiamo un altro. Ma essa deve anche inchinarsi a fondamenti che non sono inventati da qualcuno; deve riconoscere che non esiste una totale manipolabilità, che il meccanismo di maggioranza e minoranza è sostenibile solo quando tutti si sottomettono a qualcosa di più grande, a valori che in assoluto rendono possibile la convivenza umana. Dove questo è negato, dove la democrazia è priva di fondamenti spirituali che riguardano tutti, che interessano tutti, la democrazia si trasforma in anarchia. E l’anarchia diviene necessariamente dittatura».
Lungi dal sostenere quella che oggi chiameremmo «dittatura delle minoranze», in questo passaggio Ratzinger sta in qualche modo difendendo le ragioni del dissenso, che restano fondamentali nel momento in cui tale dissenso sia portato avanti in nome, appunto, della verità. Il discorso, di conseguenza, non può non toccare questioni come l’aborto e l’eutanasia. In entrambe «queste situazioni», dice il teologo, «l’uomo si fa signore della vita, perché egli esercita così un potere sugli altri - siano i non nati, siano i sofferenti e i moribondi - in una forma che non gli è permessa, con la quale egli chiaramente supera i limiti del potere umano e si arroga un diritto sugli altri che non può affatto avere, minando così proprio il fondamento per la comprensione reciproca».
Citando Spaemann, Ratzinger si erge a baluardo contro il nichilismo contemporaneo che può «essere vinto solo da testimoni, da persone che sono veramente toccate dalla verità, che non vogliono affermare sé stesse, ma che sanno ascoltare, che sono sensibili, accoglienti e che sono anche pronte a testimoniare la verità. Persone, dunque, nelle quali si vede che non ambiscono a diventare qualcuno, a fare carriera, a esercitare un potere».
Non ci si deve piegare alle logiche mondane, bisogna essere testimoni di verità anche quando ciò significa stare all’opposizione: «Abbiamo bisogno di persone che hanno qualcosa da trasmettere e lo fanno, nelle quali si vede che c’è qualcosa di più grande e di cui essi stessi si fanno servitori», conclude Ratzinger. «Solo dove ci sono persone così, che poi sono anche in grado di convincere altri e costituiscono la comune testimonianza, questo può semplicemente tornare a essere evidente perché, per noi, la verità non può essere astratta». Ecco, questa è la grande lezione ratzingeriana, la più forte e la più difficile da apprendere.