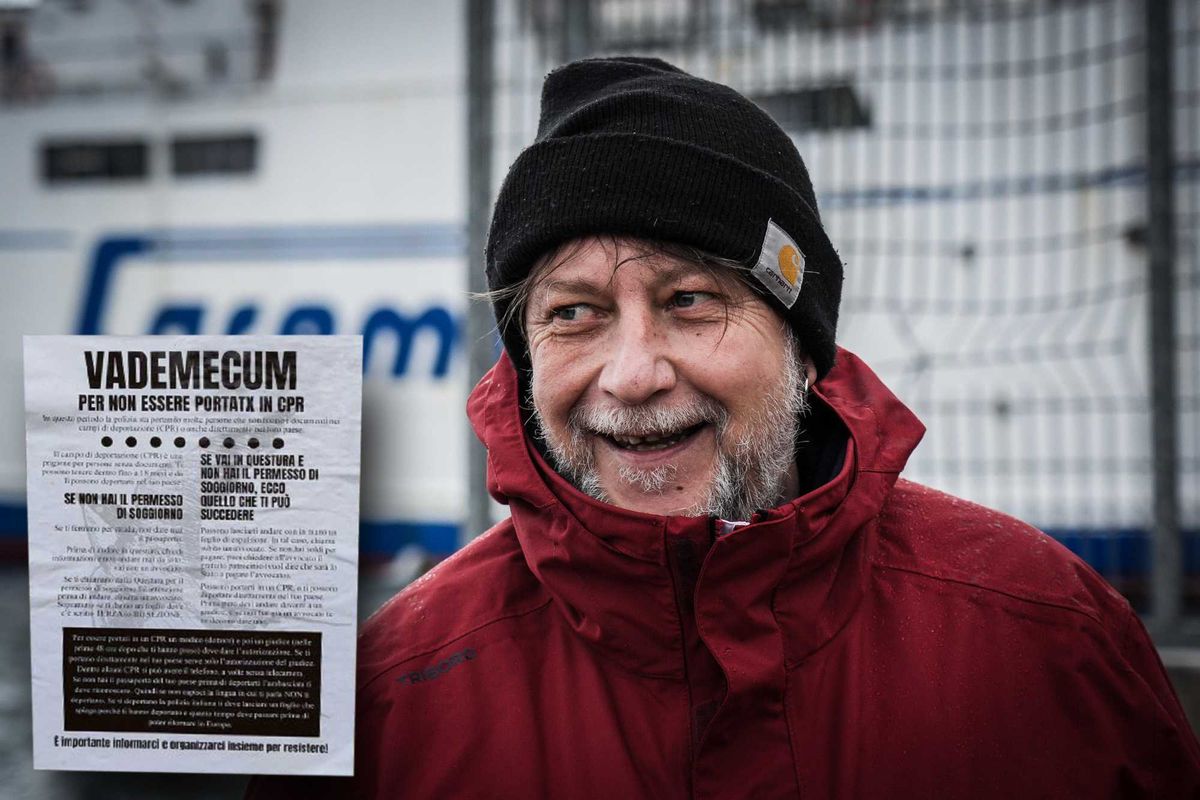Stiracchiato l’articolo 2 della Carta. Così i giudici si sono fatti autogol

Pietro Dubolino, Presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione
La logica è, notoriamente, dotata di un pessimo carattere. Non sopporta, infatti, di essere contraddetta e, per giunta, quando ciò avviene, si prende sottili e feroci vendette. A farne le spese è stata chiamata, ultimamente, la Corte costituzionale, davanti alla quale sono state riproposte questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale (che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio) sulla scorta proprio della sentenza della stessa Corte numero 242 del 2019 che aveva dichiarato la parziale incostituzionalità del suddetto articolo nella parte in cui non escludeva la punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di determinate condizioni. Fra queste vi era quella che la persona aspirante al suicidio fosse «affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili» e fosse «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». Le nuove questioni di costituzionalità attengono alla seconda di tali condizioni, da riguardarsi, in sintesi, secondo i giudici proponenti, come a sua volta incostituzionale, per lesione, nell’essenziale, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Ciò in quanto essa comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che, essendo parimenti affetti da patologie irreversibili e produttrici di intollerabili sofferenze, tanto da generare in essi il fermo proposito di porre fine alla loro vita, potrebbero o non potrebbero essere impunemente aiutati a realizzarlo a seconda che fossero o meno tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Ed è proprio nell’aver reso possibile un tale ragionamento che si manifesta la «vendetta» della logica per le molteplici offese arrecatele dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra citata.
La prima di tali offese era consistita nell’avere la Corte dettato, con la declaratoria di parziale incostituzionalità dell’articolo 580 del Codice penale, una complessa e articolata disciplina in materia di aiuto al suicidio nonostante che, in precedenza, con l’ordinanza numero 207 del 2018, avesse affermato che a ciò avrebbe potuto provvedere soltanto il Parlamento, quale organo istituzionalmente preposto, nella sua funzione di legislatore, a operare i «delicati bilanciamenti» tra le varie e potenzialmente confliggenti esigenze delle quali, nella materia in questione, si doveva tener conto. Il fatto che, alla data alla quale, con la suddetta ordinanza, era stata rinviata la decisione sulle proposte questioni di costituzionalità, il Parlamento fosse rimasto inerte non poteva certo valere a conferire alla Corte il potere che essa stessa, in precedenza, aveva riconosciuto di non avere.
La seconda, e ancor più grave, offesa era consistita nell’avere la Corte fatto derivare la pretesa, parziale incostituzionalità dell’articolo 580 del Codice penale da un contrasto ravvisabile soprattutto con l’articolo 32, secondo comma, della Costituzione, in base al quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà; contrasto che, peraltro, non era stato prospettato neppure nelle ordinanze dei giudici che avevano sollevato le questioni di costituzionalità, a sostegno delle quali erano stati evocati altri articoli della Costituzione che invece, secondo la Corte, non potevano dirsi violati. Per rendersi conto dell’assoluta insussistenza, in realtà, di tale contrasto basterebbe considerare che la Corte ha basato la propria decisione essenzialmente ponendo a raffronto, da una parte, le previsioni della legge numero 219/2017, in forza delle quali il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente che consapevolmente, quale che ne sia la ragione, rifiuti trattamenti sanitari, ivi compresi quelli dai quali dipenda la propria sopravvivenza; dall’altra, l’assolutezza, ritenuta irragionevole, del divieto penalmente sanzionato di aiuto al suicidio pur quando esso venga richiesto da un soggetto che voglia soltanto accelerare la morte che comunque conseguirebbe al suddetto rifiuto. Tale raffronto, a prima vista assai suggestivo, si rivela, però, del tutto arbitrario. Il valido rifiuto dei trattamenti salvavita, infatti, vale come scriminante per il medico che, altrimenti, omettendoli o interrompendoli e così provocando il decesso del paziente, risponderebbe, a seconda che la sua condotta sia caratterizzata da dolo o da colpa, di omicidio volontario o di omicidio colposo. Nulla a che vedere, quindi, con l’aiuto al suicidio. Quella posta in essere dalla Corte viene perciò a rivelarsi come null’altro che un’operazione di abile prestidigitazione, consistita nel far uscire, dal cappello a cilindro dell’incondizionato diritto di ciascun paziente di rifiutare sempre e comunque, anche a prezzo della sua vita, ogni e qualsiasi tipo di trattamento sanitario, il coniglio costituito da un preteso diritto al suicidio assistito, privo, in realtà, del benché minimo fondamento nella Costituzione, subordinandolo, per giunta, a condizioni di sua esclusiva creazione e facendone quindi derivare, in presenza di tali condizioni, la non punibilità dell’aiuto prestato all’aspirante suicida.
Di qui l’ovvia conseguenza che, essendo le condizioni in discorso del tutto assimilabili a quelle che avrebbero potuto essere liberamente create dal legislatore, possano essere oggetto, esse stesse, di ulteriori questioni di legittimità costituzionale, come, infatti, è puntualmente avvenuto. La Corte si troverà, quindi, nella seguente, imbarazzante alternativa: accogliere le suddette questioni, così riconoscendo, almeno implicitamente, la parziale erroneità della propria precedente decisione, ovvero respingerle, gravandosi del non facile compito di dimostrare la loro giuridica insostenibilità, nonostante l’aggancio che esse trovano, per altro verso, in quella medesima decisione. Appare probabile che la Corte, per evidenti ragioni di «immagine», opterà per la seconda di tali alternative, abborracciando comunque una parvenza di valida motivazione e salvandosi, ancora una volta, in angolo, con l’addebitare ogni colpa al mancato intervento, più volte sollecitato, del legislatore. Il tutto nella stretta osservanza dell’antica tradizione per cui non è tanto importante il conseguimento di un buon risultato (o presunto tale) quanto l’individuazione di un capro espiatorio sul quale far ricadere la responsabilità del fatto che esso sia mancato.