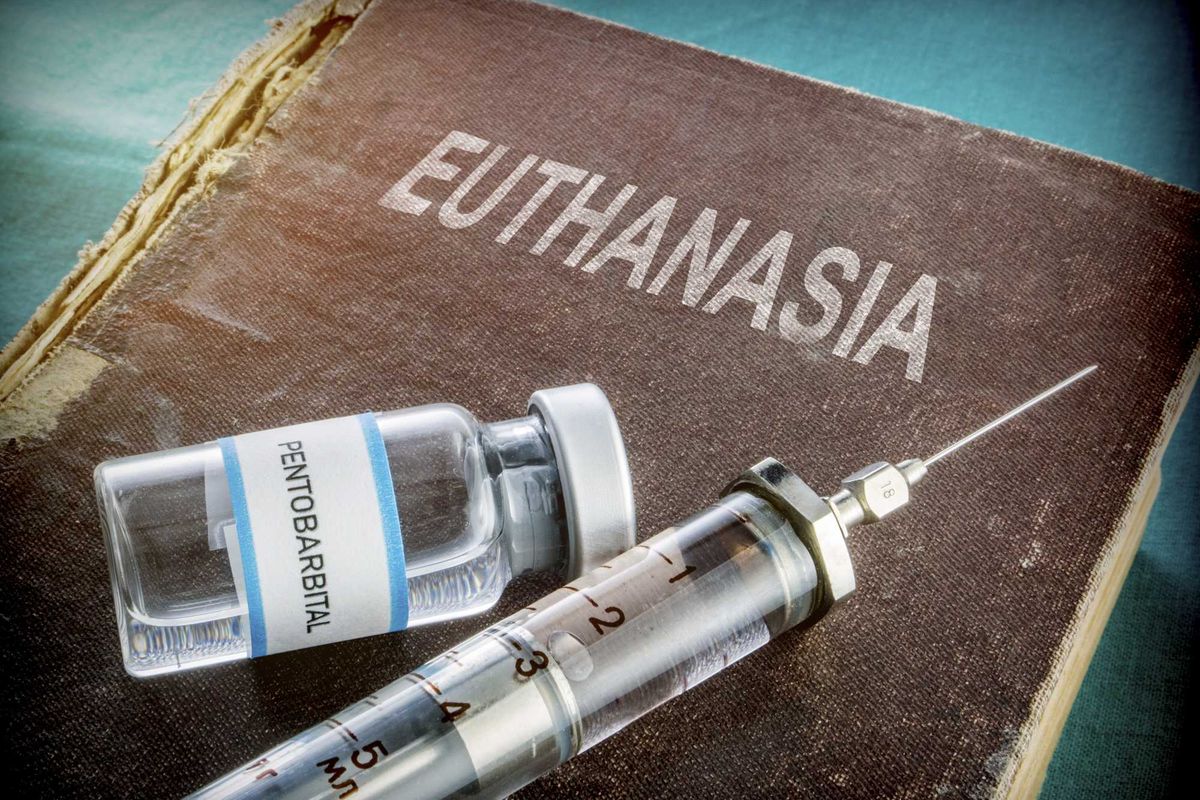C’è qualcuno ancora in grado di stupirsi del fatto che l’America tenda ad agire in modo unilaterale. Lo show al giardino della Casa Bianca, cartellone, cappellino e sindacalisti dell’auto in visibilio, ne è in fondo l’ennesima dimostrazione - forse tra le meno bellicose, viste le alternative e i precedenti. Malgrado si tenda a raffigurare i numeri esibiti da Donald Trump e la sua politica di dazi come il delirio di un pazzo, non è difficile scorgere sotto il kitsch postglobalista un dato di realtà piuttosto innegabile: il deficit commerciale americano è da almeno due decenni un problema, e da almeno un decennio un allarme. Un Paese così esposto sulla bilancia commerciale deve continuamente finanziare questo deficit, dipende eccessivamente da fattori al di fuori del suo controllo, e in ultima analisi rischia di vedere compromesso il suo status di potenza globale.
Per capire come si arrivi ai numerini esibiti dal presidente Usa, occorre partire da qui. A fianco di ogni Paese o area geografica comparivano due cifre: la prima indica i dazi che secondo la Casa Bianca gli altri Stati applicano agli Usa, la seconda - più o meno la metà, con eccezioni - la risposta reciproca «scontata». Dietro questi numeri ci sono contemporaneamente una grossolana approssimazione e una realtà economica difficile da negare, anche al netto del prevedibile cammino di trattative, negoziati, do ut des più o meno confessabili che seguiranno lo show di mercoledì sera.
Cos’è un dazio dal punto di vista di Washington? Si potrebbe rispondere: qualsiasi cosa che contribuisca allo squilibrio commerciale (ricavi da esportazioni meno spese per importazioni in un periodo di tempo). Per esempio, leggendo le 33 pagine dedicate all’Unione europea nel librone che Trump ha palleggiato sul palco (disponibile al link: rb.gy/gi54e4), ci si fa un’idea. Oltre ai dazi veri e propri (cioè le percentuali da versare per far entrare e vendere nell’Ue un bene prodotto in Usa), Washington mette nel calderone la «manipolazione valutaria», ovvero le azioni poste in essere per svalutare la propria moneta e, dunque, guadagnare quote di export su prodotti che diventano più convenienti per l’acquirente americano proprio grazie al cambio. Non è un mistero che per l’America l’euro in sé sia uno dei principali meccanismi di questa manipolazione: già l’amministrazione Obama denunciava questa pratica a tutto vantaggio dell’industria dell’auto tedesca, «prezzata» all’estero in una divisa - l’euro - per forza di cose più bassa del marco, che si sarebbe rivalutato se fosse rimasto la moneta solo della Germania. Macroeconomicamente, considerare questa dinamica alla pari di un dazio non è poi così strambo, dal punto di vista americano. Terzo fattore: quello regolatorio, recentemente preso di mira anche da Mario Draghi, il quale non a caso ha detto a chiara voce che un muro contro muro sarebbe devastante. Da pagina 131 a pagina 162 del documento citato l’amministrazione Usa elenca in modo capillare praticamente tutto il mandato della prima Commissione Von der Leyen: norme sulle etichette, sui gas serra, sulla deforestazione, sul packaging, sul green e le rinnovabili, sui pesticidi, sul vino, sul biotech agricolo, Digital service act e Digital markets act, fino al Cbam, il contestato meccanismo di adeguamento del carbonio studiato per ridurre le emissioni sulle merci importate ed evitare importazioni da aree che non rispettino i nostri standard. Sono provvedimenti di cui questo giornale ha spesso parlato evidenziandone le criticità per le nostre Pmi: ma l’America non è preoccupata per le imprese europee. Considera tali regole burocratiche come ostacoli per le aziende americane che intendano vendere a noi. Paradossalmente, accusa l’Ue - come altri Paesi - di protezionismo anti americano. Una bilancia commerciale in deficit infatti si può aggiustare non solo riducendo le proprie spese per importazioni (scuola Mario Monti, via «distruzione della domanda») ma anche aumentando i ricavi dalle proprie esportazioni.
Detti questi tre capitoli che Trump infila alla voce «dazi contro gli Usa», come quantificarli? Il metodo è brutale: la misura del dazio coincide con quella del deficit commerciale stesso. Ieri sui media americani circolava la formuletta: il rapporto tra squilibrio e importazioni. Se per assurdo l’America spendesse 100 dollari in importazioni col Paese B e il Paese B esportasse in America per 100 dollari nello stesso anno, la formula trumpiana prevederebbe un dazio pari a zero. Nel caso dell’Ue, la misura complessiva del «dazio percepito» contro gli Usa (primo numero) è pari al rapporto percentuale tra 236 miliardi di dollari (squilibrio commerciale a favore dell’Ue nel 2024) e 606 miliardi (valore delle importazioni americane, o delle esportazioni Ue): 38,94%. Ecco spiegato il 39% del tabellone. A questa cifra si applica la «gentilezza» trumpiana: senza mai scendere sotto un 10% di dazi «flat», questo valore è dimezzato nella risposta. E dunque se il dazio subìto dagli Usa (così calcolato) è pari al 39%, ecco il 20% applicato ai prodotti Ue.
Legioni di economisti stanno impazzendo da ieri mattina nell’evidenziare i limiti concettuali del modello. Resta il fatto che l’algoritmo trumpiano, violento e discutibile, dice della volontà di incidere sul vero dividendo della globalizzazione: l’immane deficit commerciale del «compratore di ultima istanza» del mondo. Se il cliente continui ad avere sempre ragione anche qui, lo scopriremo presto.