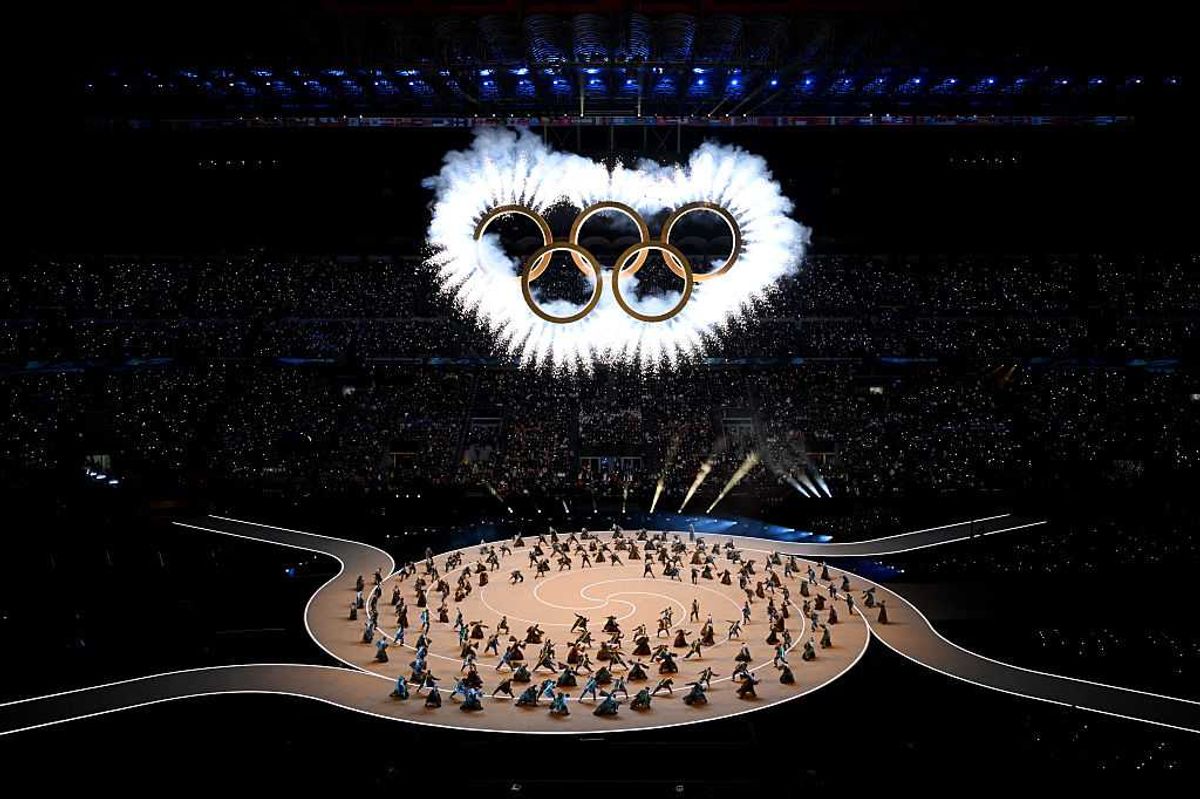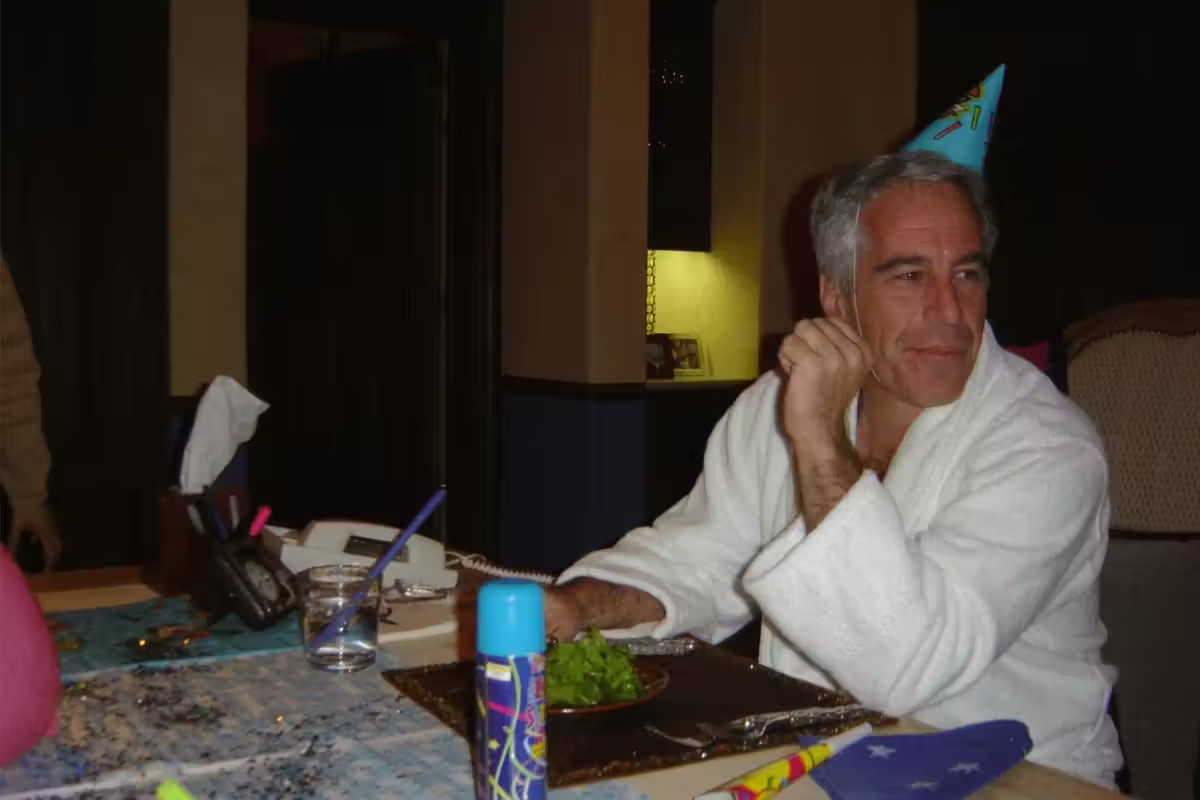L’intervista al professor Geminello Preterossi, pubblicata sulla Verità del 30 giugno 2025, ha offerto interessanti spunti di riflessione. Preterossi, accademico di altissimo valore scientifico, coglie perfettamente come il percorso di integrazione europea, di natura oligarchica e non democratica, soprattutto dopo Maastricht, abbia comportato, in nome del primato del diritto dell’Unione europea su quello interno, incluse le norme costituzionali (salvi i principi supremi dell’ordinamento, i cosiddetti controlimiti), una progressiva e sempre più invasiva erosione della sovranità statale, accompagnata da una delegittimazione dello stesso Testo fondamentale.
Che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 14/1964, abbia forzato, nel cosiddetto «dialogo» con la Corte di Lussemburgo, le «limitazioni di sovranità» per giustificare l’adesione dell’Italia alle allora Comunità europee (oggi Unione europea) è evidente. Come osservava Guastini, si è così consentita l’introduzione surrettizia nel nostro ordinamento di un sistema di revisione costituzionale alternativo a quello previsto dall’art. 138 della Costituzione, il tutto a vantaggio di un ordinamento che si caratterizza per un profondo deficit di democraticità. In altri termini, attraverso leggi ordinarie (e non costituzionali) di autorizzazione alla ratifica dei Trattati europei, il giudice delle leggi si è servito dell’art. 11 per permettere una limitazione (rectius: una cessione, come ben precisa Preterossi), di sovranità in modo permanente e illimitato, una volta per tutte.
La dottrina europeistica, ovviamente confortata sul punto dalla Corte costituzionale, contro ogni logica giuridica, ha teorizzato che le norme ad effetto diretto contenute nei Trattati, come i regolamenti e le direttive che presentano questa caratteristica, sarebbero subordinate unicamente ai principi supremi della Carta, con ciò ignorando l’ovvia constatazione che i Trattati e le fonti vincolanti da essi derivanti traggono la loro forza giuridica non dalla Costituzione, bensì da semplici leggi ordinarie.
L’idea del professor Preterossi di costituzionalizzare i controlimiti è certamente interessante, ma pone alcuni problemi di coerenza sistematica. La categoria, di per sé «ambigua» e «mitologica», dei controlimiti non coincide con l’intero contenuto precettivo della Costituzione e si presta a interpretazioni soggettive, di fatto rimesse all’organo di garanzia costituzionale senza un’adeguata determinazione normativa. Del resto, Palazzo della Consulta non li ha mai concretamente attivati: si è limitato a minacciarne l’utilizzo con la nota sentenza n. 115/2018 relativa al caso Taricco.
Anche l’idea, diversa dalla precedente, di un inserimento testuale del principio del primato della Costituzione (e non solo dei principi supremi) sulle norme europee rischierebbe di produrre più problemi che soluzioni, dal momento che proprio nel Testo fondamentale in vigore, a seguito della discutibile riforma del Titolo V operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, si rinviene all’art. 117, comma 1, un’espressa previsione secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto non solo della Costituzione, ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tale disposizione è gerarchicamente collocata allo stesso livello delle altre norme costituzionali e non può essere semplicemente ignorata o subordinata in modo meccanico a un principio di primato, qualora quest’ultimo venisse costituzionalizzato. Si porrebbe, pertanto, un problema di antinomia interna che non sarebbe agevolmente risolvibile con il solo richiamo ai controlimiti, poiché questi ultimi non configurano un criterio di soluzione delle contraddizioni tra norme costituzionali, ma soltanto un limite esterno alla penetrazione del diritto dell’Unione. Perciò, la «costituzionalizzazione» del primato della Costituzione dovrebbe necessariamente comportare anche una modifica del comma 1 dell’art. 117. Tuttavia, in tale evenienza, si esporrebbe lo Stato italiano a gravi conseguenze nell’ordinamento comunitario, giacché la mancata applicazione uniforme del diritto europeo costituirebbe una violazione degli obblighi derivanti dai Trattati e darebbe luogo all’avvio di procedure di infrazione ex art. 258 Tfue. L’esperienza polacca è emblematica: la sentenza della Corte costituzionale polacca K 3/21 del 7 ottobre 2021, che ha riaffermato la supremazia della Costituzione polacca sul diritto dell’Unione, sia pure limitatamente alla materia dell’organizzazione del sistema giudiziario, ha determinato un duro scontro istituzionale con la Commissione europea, culminato nell’attivazione di procedure di infrazione e nella sospensione di erogazioni di fondi. Ciò dimostra che, finché si resta entro il sistema del Leviatano eurounitario, ogni rivendicazione di primato costituzionale si risolve in un conflitto permanente con gli organi dell’Unione e in un inasprimento del controllo politico-finanziario sulla sovranità nazionale.
In definitiva, se la tensione fra primato del diritto dell’Unione e supremazia costituzionale è divenuta strutturale e non più episodica, e se l’assetto normativo post-Maastricht si è consolidato su un fondamento oligarchico refrattario a qualunque processo di democratizzazione, la sola scelta davvero coerente è quella drastica del recesso ex art. 50 Tue. Ogni altra ipotesi, per quanto animata da intenzioni condivisibili, finisce per consolidare una contraddizione insanabile tra un ordinamento costituzionale che, in tesi, rivendica il proprio primato, e un ordinamento sovranazionale che lo nega.