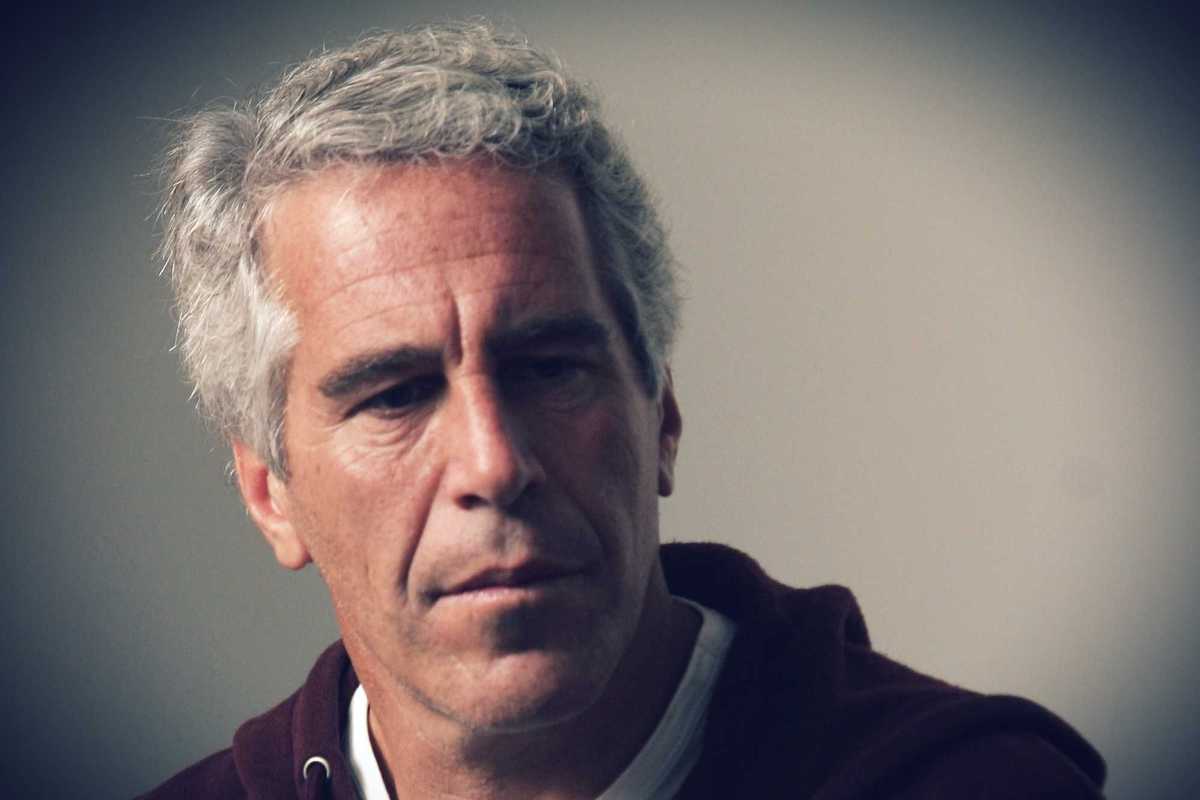La resa di un ingegnere giapponese davanti ai «fili di Dio» della Sardegna

Prosegue il viaggio in un'isola dei nuraghi che ha molto da offrire al di là delle spiagge assolate e della tintarella tra le calette delle sue insenature a tiro di yacht. Ci sono storie e tradizioni che bisogna andare a cercare, per gustarne le straordinarie meraviglie. Pane e pasta sono un binomio inscindibile laddove le miniere di grano sono patrimonio identitario. Benedetto Croce, nella traduzione di un testo napoletano del Seicento (il Pentamerone), riporta come la miglior pasta tra i rioni partenopei fosse «quella di Cagliari». Rinforza il messaggio, nel 1634, il novelliere Gian Battista Basile dove uno dei suoi personaggi è lapidario «voglio i maccheroni di Cagliari». Una fama che varca i confini patri tanto che, nel 1706, nei diari del suo viaggio in Italia, Jean Baptiste Labat certifica come «la finezza delle semole prodotte in Sardegna danno maccheroni ottimi e adatti alla tavole dei nobili», ma non solo prodotto elitario da gustare servito da maggiordomi su piatti d'argento.
Nell'isola era prassi celebrare spensierate maccaronadas, ovvero jam session a palato libero nei giorni di festa con le varie eccellenze della tradizione familiare. Ad esempio i culurgiones, nativi dell'Ogliastra, sorta di gnocchi ripieni di crema di patate condita con menta e pecorino, serviti poi al piatto con pomodoro e basilico e relative varianti, ad esempio scorza di limone o arancia in Gallura, come sugo di salsiccia e menta in Barbagia. Per alcuni l'etimo deriva da culleus, sacchetto, considerata la forma che li rende subito riconoscibili, per quella affascinante cucitura a spiga (sa spighitta), che rinviava al grano da cui traeva origine. Un rito manuale che si trasmetteva in famiglia, tanto che ogni donna era orgogliosa della sua firma. Una pericolosa tentazione golosa tanto che, in una memoria della Reale società agraria dei primi dell'Ottocento, si metteva nero su bianco «il pane di vin cotto, le zeppole e i cosiddetti culurgiones de casu, in cui si impiega non poca farina, andrebbero proibiti fino al nuovo raccolto, e s'avrebbe tanta farina in più da applicarsi alla panizzazione». Resi ancora più tentatori di peccati di gola con le varianti createsi nel tempo. Arrosto, posti sulla brace e mangiati a scottadito, come fritti, sorta di street food della porta accanto. Vi è anche la versione «nature», cioè spoglia dell'involucro di pasta, ovvero i culurgionis spoggiausu, con l'aggiunta di farina nell'impasto che li rende poi più compatti alla cottura.
I malloreddus sono gli gnocchetti autoctoni, anche se l'anagrafe varia a seconda di dove li si incontra. Ciciones a Sassari, cravoas a Nuoro, cassulli a Carloforte, dove vi conquisteranno con tonno e pomodoro. La loro origine sembra riferita al Campidano, l'etimo rimanda al malloru, il toro locale, declinato a giovane vitellino, simbolo di prosperità, vuoi mai per quella forma scanalata che cattura il condimento: pomodoro, salsiccia, pecorino e basilico. Lo zafferano per le grandi occasioni, già nell'impasto, piatto identitario per la giornata dei defunti. Tradizione vuole che l'impasto di acqua e semola di grano duro venga modellato facendolo scorrere su di un apposito cestino di vimini (su ciuliri) che gli dona quella silhouette unica. Un tempo era prassi che le giovani spose portassero in dote nella nuova famiglia sa scraria, la batteria di setacci e cesti che serviva per tutto il relativo processo di lavorazione. Ne dà una bella pittata narrativa Grazia Deledda, «Prese il coltello piccolo e tagliò una fetta della pasta che ridusse ad una biscia bianca, con il coltello si affrettò a tagliare piccoli pezzi come se si trattasse davvero di una bestia pericolosa. Poi formò gli gnocchi e il loro esercito ben schierato sull'asse e ricoperto dalla tenda di una salvietta, in attesa che l'acqua bollisse».
Un vero e proprio prodotto di architettura edibile le lorighittas, piatto identitario di Morgongiori, meno di settecento anime, eccellenza riconosciuta per la lavorazione di arazzi e tappeti. Ne veniva inviato omaggio già nel XVI secolo al re di Spagna. Da un lungo spaghetto di venticinque centimetri, l'abilità manuale delle madri di famiglia lo trasforma in una treccina chiusa a formare un anello, loriga. Era il piatto della festa di Ognissanti. L'etimo rinvia a svariate ipotesi legate alla civiltà rurale. Lorigas, le escrescenze del collo delle caprette, ma anche gli anelli di ferro usati come orecchini dalle giovani del posto come pure i più pratici anelli di ferro fissati alle pareti delle case di campagna per legare buoi e cavalli. Un plauso all'amministrazione locale che è riuscita a dare nuova vita a questa tradizione grazie anche a fondi appositamente stanziati dall'Unione Europea.
Un piatto che vale il viaggio nell'isola dei nuraghi sono i filindeu. Già l'origine ne sottolinea l'eccellenza senza tempo: per alcuni sono i «fili di Dio», per altri, più laicamente, derivano da findeus, che in sardo sta per capelli. Non stiamo parlando di acconciature edibili, anche se la lavorazione è testimone di raro talento artistico. Ritorniamo a Grazia Deledda, non a caso Nobel per la letteratura nel 1926. «Pare un grosso velo, viene benedetto assieme a tutte le vivande. Lo si ritiene quasi miracoloso e viene recato agli ammalati». Custode e regina della tradizione Paola Abraini, nuorese, con la decina di «discepole» che la affiancano nella quotidianità come nelle grandi occasioni, su tutte il filindeu di san Francesco che si volge a Lula, una trentina di chilometri dal capoluogo. Qui, a fine Ottocento, si rifugiò nelle grotte il giovane Francesco Tolu, ingiustamente accusato di un delitto che non aveva commesso. Dopo una lunga latitanza si consegnò alla giustizia, dopo aver promesso un voto all'omonimo santo invocandone la protezione. Assolto dai tribunali del tempo, edificò a sue spese un piccolo santuario campestre, affermatosi in poco tempo quale centro di gravità permanente della popolazione locale. Due volte l'anno si tengono processioni che partono dalla chiesa del Rosario di Nuoro.
Presso il santuario si svolgono celebrazioni religiose come pratici riti di vita materiale. Contrattazioni di vendita di bestiame, strategie di futuri matrimoni, più distensive sfide di morra, con la distribuzione del piatto cult del posto, i filindeu serviti su brodo di pecora e abbondante pecorino fresco. Tradizione vuole che tutti i partecipanti ai raduni ne assaggino almeno un cucchiaio. In particolare, le spose novelle dovevano baciare in segno di devozione il mestolo caldo. Vi fu una renitente, la quale se ne tornò disgustata sul suo cavallo in città. Mal gliene colse. Ad un tornante perse l'equilibrio e rovinò nel dirupo che, da allora, si chiama «fosso della sposa». Si prende un blocco di pasta, con ripetuti passaggi, quasi si suonasse una fisarmonica, si stende il panetto. Le ripetute piegature, rigorosamente otto, portano ad una trama di duecentocinquantasei fili di pasta, una sfoglia chiamata pidzos. «Il segreto è un'armonia delle dita di una mano e l'altra che allunga con un movimento dolce, armonico, e poi all'improvviso bruscamente rapido». Stesi poi su foglie di asfodelo intrecciati per asciugarsi, in tre strati sovrapposti ad angolazione variabile. Essiccati formano una specie di garza che viene poi stracciata a pezzi, bolliti per un minuto. Una tecnica apparentemente semplice, ma inimitabile. Un tecnico venuto dal Giappone, ingaggiato da una primaria azienda italiana, si è arreso, impossibile meccanizzarne la produzione, e lo stesso starchef James Oliver ha preso atto che, di fronte al talento autoctono, non restava che sedersi e gustare il tutto a futura memoria. Un petroliere del Texas, collezionista di capolavori degli espressionisti come dei macchiaioli, nella sua galleria ha racchiuso in un'enorme teca una composizione di filindeu. «È un'opera d'arte, starà accanto ai miei quadri».