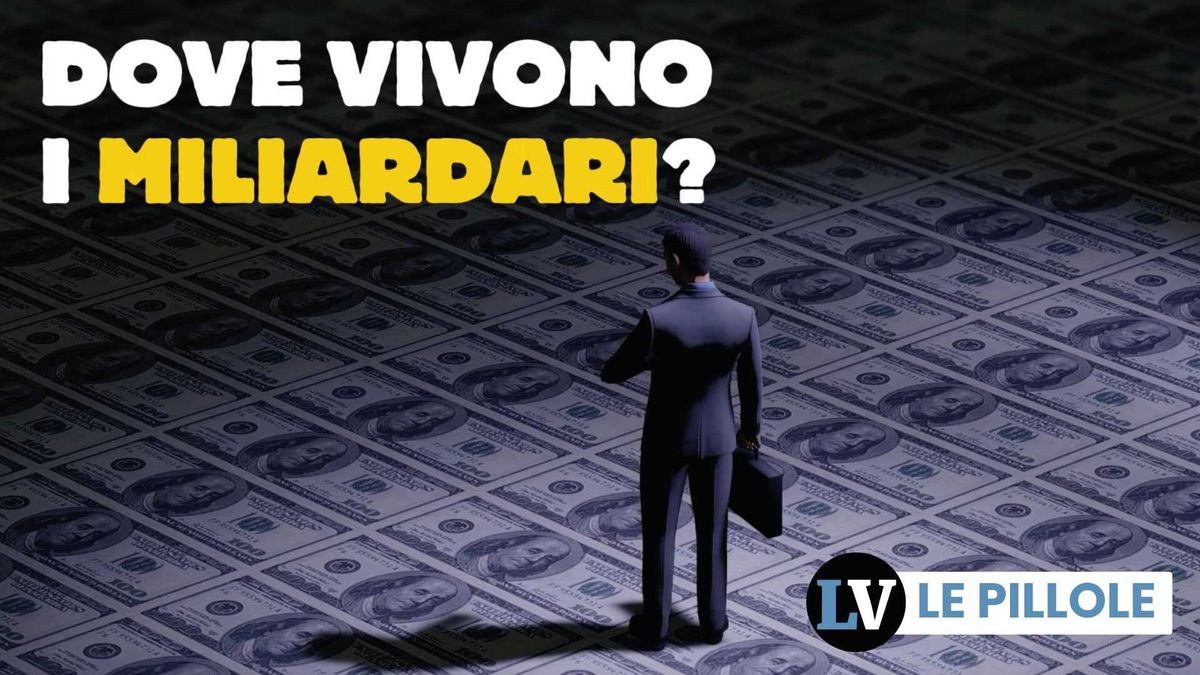- Dopo la bufala di Bruxelles che regala soldi, adesso arriva la doccia fredda della realtà: quei fondi andranno rimborsati. Ecco perché Roberto Gualtieri vuole destinare 87 miliardi a spese già previste: così non si aggraverà la situazione dei nostri conti.
- Bankitalia conferma la stretta sui conti correnti delle aziende: basta un «rosso» e si bloccano gli accrediti. Ma la politica si accorge solo ora delle regole Ue. Allarme delle società di leasing: i contratti da dichiarare in default raggiungerebbero i 43 miliardi. Il Ristori 5 promette solo mini stralci fiscali.
Lo speciale contiene due articoli.
«All'apparir del vero tu, misera, cadesti». Ci perdoneranno i lettori se ci rifacciamo nuovamente ai famosi versi di Giacomo Leopardi per descrivere l'evoluzione del dibattito politico sul Recovery fund. Allora a cadere fu l'ingenua speranza del poeta, oggi si dissolve come neve al sole la concreta efficacia del Ngeu ai fini della ripresa dell'economia del nostro Paese. A questo fine dobbiamo essere grati al leader di Italia viva, Matteo Renzi, che ha posto nei giorni scorsi con grande chiarezza il tema dell'entità e della destinazione della spesa dei fondi Ue: 127 o 209 miliardi? Cosa finanziamo? Il dissesto idrogeologico o i progetti di fatto preconfezionati secondo le linee guida della Commissione che riflettono le priorità delle filiere industriali tedesche, come la transizione ambientale?
Ieri, dopo essere stati a lungo voce solitaria sul tema, è finalmente arrivato il confronto con la realtà. Sono caduti miseramente i sogni partoriti in afose serate agostane da invincibili task force e gli improbabili Stati generali (ma non ci sono le Camere e le audizioni parlamentari?) si sono rivelati una passerella in favore di telecamere. La realtà fonda su tre pilastri:
1 Quei fondi, raccolti dalla Ue sui mercati e prestati agli Stati membri, sono per la gran parte debiti da rimborsare. E la Bundesbank è dell'idea che anche i contributi futuri (circa 50 miliardi per l'Italia) che serviranno alla Ue per rimborsare i bond emessi per i sussidi vadano inclusi nel debito nazionale già oggi.
2 Proprio per questo motivo, il ministro Roberto Gualtieri è fermo nella sua posizione di destinare almeno 87 dei 127 miliardi complessivi a spese già previste nel bilancio dello Stato ma non ancora finanziate. Non aumenterebbe così il debito, cambierebbe solo il finanziatore dell'Italia (Ue anziché i mercati). Gli investimenti aggiuntivi che contribuiranno alla crescita si riducono quindi a 40 miliardi.
3 Esiste un ferreo vincolo posto dalla Commissione sulla destinazione della spesa: non meno del 57% dei fondi a favore di transizione ambientale e digitale e tutto il resto sarà comunque sotto la tagliola della coerenza con le raccomandazioni Paese e con tutto lo strumentario del semestre europeo (patto di stabilità in testa).
Noi lo scrivevamo da mesi non perché avessimo chissà quali fonti a Bruxelles, ma perché ci eravamo semplicemente sobbarcati la fatica di leggere almeno un migliaio di pagine di bozze di Regolamenti, oggetto di negoziati terminati solo il 22 dicembre scorso.
Oggi è un coro e la prima voce, quasi dal sen fuggita, è stata quella del vice ministro dell'economia, Laura Castelli, che il 28 dicembre ha dichiarato al Fatto quotidiano: «Penso che i toni usati in questi giorni siano esagerati, perché alla fine a decidere è la Ue». Infatti la Commissione avrà 8 settimane per valutare l'ammissibilità dei progetti e portarli all'approvazione del Consiglio, che dovrà farlo entro 4 settimane. La Commissione utilizzerà una griglia a maglie strettissime ed abbiamo il sospetto - fondato proprio sulla parziale incoerenza tra i progetti finora elencati nel Recovery plan e le linee guida della Commissione - che il recente accapigliarsi su contenuto e governance del piano sia proprio il risultato di una prima non felice interlocuzione con i burocrati di Bruxelles.
Chi, come Mario Monti, queste cose le sa, ieri sul Foglio ha avvertito che un errore da non compiere è quello di «dimenticare che anche questa volta l'Europa chiede risanamento dei conti e riforme, che sono nel nostro interesse, e che questa volta avrà anche l'autorità morale per esigerli». Sono le condizioni sopra illustrate. Ci permettiamo solo di aggiungere che la Ue avrà anche l'autorità giuridica per imporci austerità e riforme, altrimenti non riceveremo un cent.
Monti conferma anche la differenza tra la linea di Gualtieri e quella di Renzi: «I prestiti del Recovery fund […] andrebbero pur sempre ad accrescere il debito complessivo dello Stato. È possibile che altri, non trovandosi esposti in prima linea come il Mef e il ministro che lo guida, considerino invece un'opportunità mancata un eventuale utilizzo non pieno dei prestiti». In altre parole: accumuleremmo troppo debito e non riusciremmo nemmeno ad avere sufficienti progetti ammissibili a quei fondi. Meglio chiederne meno.
A versare la secchiata gelata finale, ieri ha concorso Federico Fubini sul Corriere della Sera, che già in precedenza aveva evidenziato il tema dei prestiti per investimenti aggiuntivi: «Se Next Generation Eu non fosse mai nato, l'Alta velocità al Sud si sarebbe fatta semplicemente emettendo titoli di Stato. In altri termini cambia il creditore (e l'Unione europea di fatto non chiede interessi, a differenza degli investitori privati) ma non il progetto, né l'ammontare sostanziale di deficit e debito necessari per realizzarlo».
Va solo detto, per inciso, che la Ue non fa beneficenza e che anche un Btp a 5 anni ha tassi negativi. Fubini solleva un punto chiave: siamo sicuri che la Ue riterrà finanziabile la proroga del credito d'imposta per industria 4.0 (esisteva già nel 2020) o quella del superbonus 110%? Tutte spese in parte in già in programma e finanziabili con normale indebitamento. È molto probabile che la Ue chieda più progetti tecnologici e infrastrutture che sgravi a pioggia per famiglie o imprese.
È il paradosso del Ngeu: più ne prendiamo e meno conviene.
Norme su scoperti di conto e cartelle spingono le imprese in un vicolo cieco
Da tre giorni sono entrate in vigore le norme dell'Autorità bancaria europea sugli scoperti di conto o di linea di credito. Adesso, per essere dichiarati cattivi pagatori, basterà andare in rosso di 100 euro o 500 (se si è una azienda) o più in generale oltre l'uno per cento dell'esposizione totale. Lo sconfinamento deve durare per almeno 90 giorni. Di per sé verrebbe da dire che tra il tutto e il niente c'è sempre il buon senso, e che per evitare la black list basterebbe poco.
Il problema invece è molto più grande di quanto sembri. Innanzitutto perché le situazioni attuali dovranno essere riclassificate. E come al solito la politica e i cosiddetti stakeholder nostrani si accorgono dell'arrivo di nuove regole Ue solo il giorno dopo, quando se ne discute da anni. Non vivendo in Nuova Zelanda, il governo dovrebbe sapere da mesi il pericolo a cui andiamo incontro. Non tanto per le persone fisiche. Piuttosto per le imprese. Ieri La Stampa ha proposto uno studio di Assilea, l'associazione che rappresenta le società di leasing, condotto tra marzo e giugno 2019 in collaborazione con Bankitalia. Assilea ha calcolato che applicando la percentuale dell'uno per cento la somma di contratti da dichiarare in default sarebbe di 43 miliardi di euro. Oltre la metà del totale. Infatti, a oggi la soglia di allarme per ogni singolo soggetto giuridico è calcolato al 5%. Per questo lo scorso anno è stato chiesto di portare la soglia al 2,5%, sfruttando una opportunità concessa dall'Ue. Bankitalia ha detto no, confermando l'uno per cento.
Soltanto ieri Antonio Patuelli, il presidente dell'Abi, l'associazione delle banche italiane, ha scritto una lettera al quotidiano Mf spiegando quanto sia importante «insistere per una sospensione e una revisione della norma, anche se entrata in vigore». Ma come? Adesso? Ci ricorda la bocciatura del bail in, due anni dopo l'adozione forzata. Siamo stati i primi in Europa a cambiare le regole bancarie, al netto di Cipro che lo fece con una sorta di pistola puntata alla tempia. La storia non insegna nulla. Per Patuelli «il percorso delle nuove regole sul default è ricco di incognite». Se lo dice lui, c'è da credergli. Non tanto perché il Sud Europa è più predisposto alla flessibilità rispetto ai Paesi del Nord, sempre descritti ligi alle regole tranne quando c'è da affrontare i «problemini» del riciclaggio di denaro. Ma piuttosto perché fino ad oggi il sistema italiano, per tenere di una tacca più in alto il Pil, ha chiuso un occhio sui ritardi delle aziende in sofferenza per la scarsa capitalizzazione e per le tasse estenuanti. Una sorta di patto non detto. Un circolo vizioso sulla liquidità. Lo Stato fa il furbo, tassa e paga in ritardo, le aziende aspettano e nel frattempo vanno sotto in banca o saltano la rata del leasing. Vale almeno per gli ultimi 15 governi, ma il riferimento è attualissimo. Metà dei fondi per i decreti Ristori bis e ter sono stati pescati dal fondo creato con la manovra 2020 e destinato alla Pubblica amministrazione perché pagasse una fetta delle fatture arretrate. Stanziati a dicembre 2019 circa 12 miliardi; usato nei primi sei mesi non più di un miliardo. Il fondo è poi stato cannibalizzato nella fine d'anno appena trascorsa.
Rende l'idea di come lo Stato consideri le aziende un bancomat. Salvo scaricarle quando piovono regole da Bruxelles. Regole che in astratto sono forse giuste, ma che in Italia diventano una doppia fregatura per il settore privato cornuto e mazziato. Che succederà, infatti, dopo marzo, quando saranno trascorsi i fatidici 90 giorni di scoperto? Il presidente Patuelli nella sua lettera ha invitato i correntisti e le banche a prevenire piuttosto che curare. Meglio avvisare prima dello scadere del trimestre. Passi per le persone fisiche, ma le aziende avranno più difficoltà. In molti casi non sconfinano per disordine amministrativo, ma perché non hanno i soldi per pagare e aspettano. Spesso tra 10 fatture ne scelgono 5 e le altre le rimettono nel cassetto. A volte pagano le tasse e rimandano la rata del leasing. Ecco, da marzo in avanti il gioco sarà più pericoloso. Diventare «cattivi pagatori» significa avviare un percorso da quale è difficilissimo fare marcia indietro. E quindi il governo ha deciso di mettere il carico da undici.
Sono in arrivo 35 milioni tra atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi amministrativi) sospesi nel 2020 ai quali si aggiungono quelli di inizio 2021. Ci sono altri 15 milioni di accertamenti e lettere di compliance. Quindi, in assenza di una rapido intervento del governo, la macchina fiscale si rimetterà in moto implacabile. «Penso che serva una rottamazione quater per gli anni dal 2016 al 2019 per dare respiro a quei contribuenti con morosità incolpevoli», ha detto più volte il vice ministro dell'Economia, Laura Castelli (M5s), come se il problema fosse soltanto il pregresso. Il prossimo decreto Ristori, il numero 5, sarà venduto come un nuovo stop alle cartelle. In realtà ci sarà un mini stralcio e un piccolo rinvio. Prima o poi però il buco di gettito causato dal Covid sarà da affrontare in modo inequivocabile. Le aziende per riprendersi avranno bisogno di un condono tombale, sul periodo d'imposta da certificare il prossimo giugno. Invece gli imprenditori si troveranno in un vicolo cieco. Da un lato dovranno pagare le imposte del 2019 e dall'altro affrontare il problema della liquidità sul conto e i leasing. Serviranno soldi da pompare nel capitale e allora si capirà che la strategia portentosa dei 400 miliardi annunciati a marzo scorso e inseriti nel dl Liquidità da salvagente si trasformerà in zavorra. Avremo il sistema produttivo più indebitato al mondo.