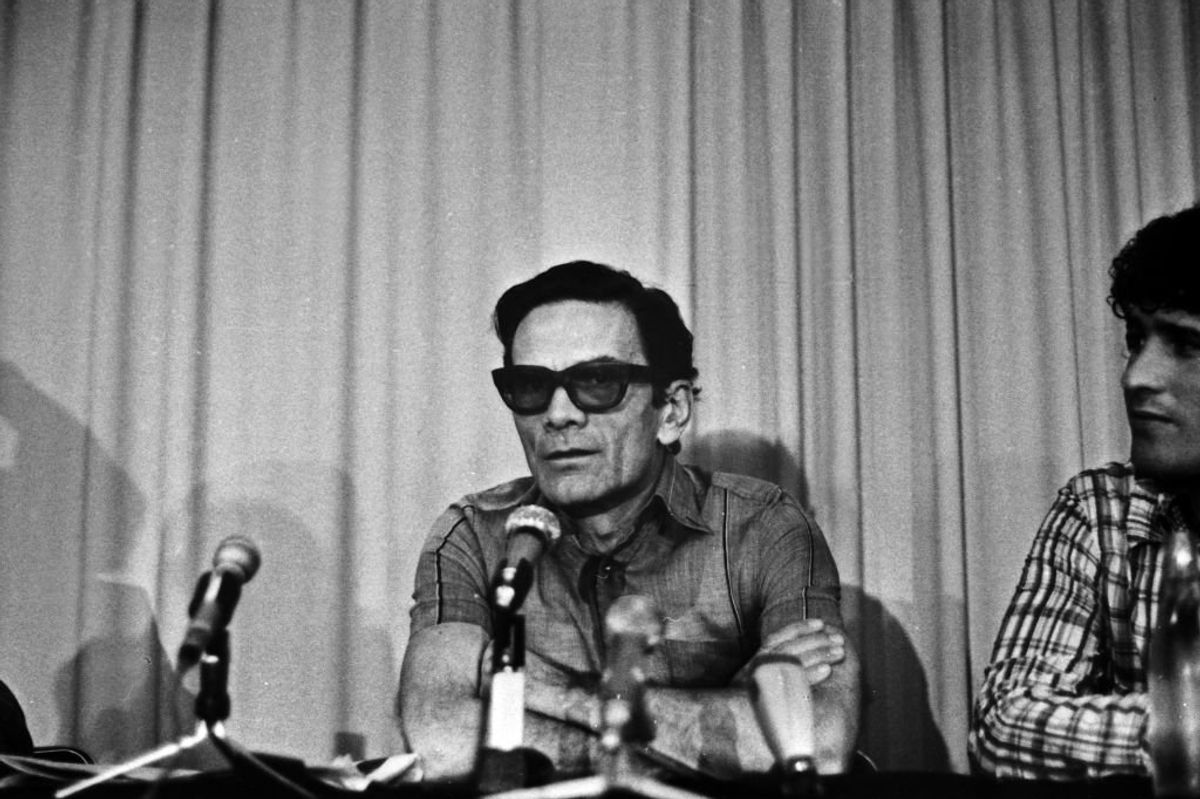
Un eccesso di luce, si sa, acceca. O, più prosaicamente, si potrebbe dire che il troppo stroppia. Di certo la quantità di libri, studi, saggi, interventi, filmati, tributi di ogni sorta dedicati alla figura e all’opera di Pier Paolo Pasolini è pervenuta, già da tempo, a una tale dismisura da far apparire come pleonastico quasi tutto ciò che di nuovo viene proposto riguardo a PPP e, soprattutto, da rendere paradossalmente arduo approdare a una conoscenza profonda, reale, non adulterata della personalità e del pensiero - sovente contraddittori, anzi programmaticamente contraddittori - di questo genio capace, sì, di essere ancora spiritualmente e intellettualmente presente tra di noi (ovunque, non solo in Italia) a mezzo secolo di distanza dalla sua morte violenta, ma ormai cristallizzato, nella percezione comune, in una serie di «immagini» fisse e stereotipe che - a dispetto dei loro propositi per lo più nobilitanti - non dicono il vero sul suo conto, alimentando semmai i luoghi comuni, le leggende e le riduzioni a cattivo maestro o, più spesso, a santino.
Tra le persone consapevoli di quanto appena detto vi è il curatore di questa ricca antologia di cinquanta interviste a Pasolini, Franco Grattarola, che ha intelligentemente scelto di celebrare il poeta, scrittore e regista lasciando a lui la parola, senza interferire in alcun modo se non mettendo a disposizione dei lettori quelle informazioni e quella documentazione che solo chi studi Pasolini praticamente da tutta la vita, senza preconcetti e raccogliendo ogni sorta di materiali sul suo conto (è appunto il caso di Grattarola), è in grado di fornire. In modo analogo all’altro lavoro pasoliniano curato da Grattarola, il fondamentale Pasolini una vita violentata. Pestaggi fisici e linciaggi morali: cronaca di una Via Crucis laica attraverso la stampa dell’epoca, pubblicato vent’anni fa da Francesco Coniglio, questa raccolta di conversazioni con PPP ha un merito doppio: da una parte attingere a fonti tanto preziose quanto disperse e dimenticate, vale a dire riviste e giornali d’epoca, spesso testate minori o addirittura specialistiche assenti sia dalle bibliografie pasoliniane sia dalle biblioteche italiane, anche le più fornite e vaste; dall’altra respingere la tentazione dell’inferenza a tutti i costi, dell’interpretazione magari tendenziosa o grossolanamente ideologica. Così come, in Una vita violentata, a parlare erano essenzialmente gli articoli - quasi sempre malevoli, mendaci, ingiusti - di Il Borghese, di Lo Specchio e delle altre pubblicazioni da Grattarola passate scrupolosamente al vaglio, la voce che qui si può ascoltare, in qualche modo sempre attuale pur provenendo talora da un passato che è ormai quasi remoto, è non mediata né rielaborata: la voce di Pier Paolo Pasolini.
Il valore di questi scambi di PPP con interlocutori sempre diversi - a volte suoi colleghi del mondo letterario, altre giornalisti di nome, altre ancora pubblicisti occasionali o semisconosciuti (e non mancano i casi, estremamente probabili, di autointerviste mascherate, come quella, fluviale, ospitata sul numero del maggio 1969 della rivista per adulti Jet) - non è solo nel loro contenuto, stimolante di per sé in quanto proveniente dalla mente mercuriale di Pasolini, ma nell’essere stati recuperati, come già sottolineato, dal più assoluto oblio. È, insomma, come se fossero degli inediti.
E cos’è che risalta, soprattutto, in questi «inediti de facto»? Pur nella loro inevitabile e benvenuta eterogeneità, i dialoghi raccolti da Grattarola presentano degli elementi ricorrenti che, da un lato, consentono di fissare dei punti fermi in relazione alla psicologia di Pasolini e, dall’altro, di percepire nitidamente la già richiamata distanza tra la biografia autentica dello scrittore friulano e le non poche incrostazioni «leggendarie» che, nel tempo, hanno contribuito a opacizzarla. Il tratto che emerge in modo più netto è forse quello di un «antitaliano italianissimo», cioè di un uomo completamente immerso in un viscerale rapporto di amore-odio con il suo paese. Nelle frequenti accuse nei confronti dell’Italia, nel disprezzo espresso non di rado in modo enfatico, non vi sono mai distanza o indifferenza; al contrario, si avverte una continua e imperterrita richiesta di attenzione e persino di affetto. E si coglie il disperato auspicio di Pasolini - disperato poiché consapevole di dover vivere una perenne frustrazione - che la sua nazione migliori, «progredisca», ovvero torni almeno un poco ad assomigliare a ciò che essa era stata fino alla fine degli anni Cinquanta, data che - quantomeno nell’immaginario pasoliniano se non nella realtà - segna la fine dell’Italia reale, animata da un suo popolo culturalmente e linguisticamente differenziato (e in gran parte ancora «contadino» anche quando già urbanizzato, come nel caso delle borgate romane), e l’avvento dell’Italia irreale, omologata e sfigurata dal consumismo neocapitalistico. [...]
I dialoghi di questo libro ci regalano però molto altro. Alcune «rimozioni» pasoliniane, come la difficoltà, per condizionamento ideologico, a parlare in termini espliciti e veritieri della morte di suo fratello Guido, partigiano «bianco» ucciso agli inizi del 1945 da partigiani comunisti filotitini, episodio che Pier Paolo racconta così, omissivamente, a Gideon Bachmann ancora nel luglio del 1975 (su Playmen): «In quei tempi io stavo nel Friuli, che era diventato una regione tedesca, ed era stato annesso alla Germania. Qui c’era una delle più forti lotte partigiane. Mio fratello c’è morto. Era una delle lotte più crudeli. Il Friuli era completamente sotto la Germania, e i fascisti erano veri e propri sicari». Poi il bulimico affastellarsi di progetti che, sovrastati delle decine di altri contemporaneamente seguiti ed effettivamente condotti a termine, non vedranno mai compiutamente la luce: tra gli altri, il «dantesco» poema in prosa La mortaccia, una pellicola su di un santo medievale, un’altra dal provvisorio titolo Il viaggio a Citera, il film su San Paolo... E ancora il pessimismo totale e irredimibile degli ultimi anni, che impregna l’intervista a Massimo Conti uscita su Panorama l’8 marzo 1973; l’ingenuità di certe valutazioni, dovuta anch’essa al prevalere dell’ideologia sulla lucidità, come quando parla dei rozzi epigoni sexy dei film della cosiddetta «Trilogia della vita» immaginandosi, per quest’ultima, una tipologia di pubblico inesistente: «È vero, questo mi disturba moltissimo, perché danneggia il mio film e il mio pubblico, quello al quale io voglio bene, quello fatto di gente modesta, operai, poliziotti, che sono senza dubbio anch’essi disturbati dall’uscita di queste opere minori» (a Franco Nebbia, su L’Intrepido del 17 ottobre 1974); il rapporto personale e diretto, che mai è stato possibile chiarire fino in fondo (aspetto che ha notevolmente ostacolato, finora, l’avvicinamento alla verità sull’assassinio di PPP all’Idroscalo di Ostia), con il mondo della criminalità romana della prima metà degli anni Settanta: «Adesso è finito tutto. È finito. Non hanno più la loro cultura e non hanno ancora raggiunto la cultura piccolo-borghese che viene loro imposta perché non hanno la possibilità economica di raggiungerla. E quindi sono smarriti e sono in uno stato di disorientamento per cui, e mi ripeto in maniera ossessiva, se in Italia venisse il nazismo troverebbe il terreno adeguato. Perché queste masse fluttuanti di gente che ha perduto i suoi valori morali e non ha acquistato dei valori morali nuovi è una massa amorfa, disorientata, imponderabile e che è infatti crudele. E la malavita è diventata spaventosamente crudele perché è al di fuori di ogni scala di valori» (a Paolo Ceratto dell’Avanti!, conversazione apparsa sul quotidiano socialista il 9 novembre 1975 e svoltasi una decina di giorni prima che Pasolini fosse ucciso). E naturalmente le riflessioni dirette o indirette sull’omosessualità: non tanto l’omosessualità in generale, quanto proprio la sua, di Pier Paolo, così particolare ed esperita dovendo convivere con l’atroce fardello rappresentato da quell’idea di peccato, arcaicamente cattolica, di cui egli era intriso e in ragione della quale ricercava, comprensibilmente, una giustificazione e una forma di salvezza: «Ho notato che Cristo non è intransigente con i peccati perché è sempre disposto a perdonare i peccatori. Potremmo fare un elenco degli episodi nei quali Cristo perdona immediatamente i peccatori. Anche se Cristo non l’ha mai detto in maniera esplicita, poiché perdona così facilmente, vuol dire che egli capisce che uno può anche peccare, che i peccati sono inevitabili, che addirittura l’uomo può talvolta non impedirsi di peccare. Con tutta la buona volontà, il livello anche elevato di coscienza, la responsabilità che un uomo possa avere, vi sono peccati che sono inevitabili perché provengono da zone della sua personalità, della sua psiche che egli non controlla. E cioè evidentemente Cristo ha previsto l’inconscio» (a Clemente Ciattaglia sul Popolo del 19 giugno 1971). Adesso come allora, attraverso il suo dire - ossia attraverso il suo offrirsi - Pasolini dà molto, moltissimo. Ciò che domanda in cambio è un ascolto attento; è comprensione («La morte non è / nel non poter comunicare / ma nel non poter più essere compresi»); è, possibilmente, un’assoluzione.






