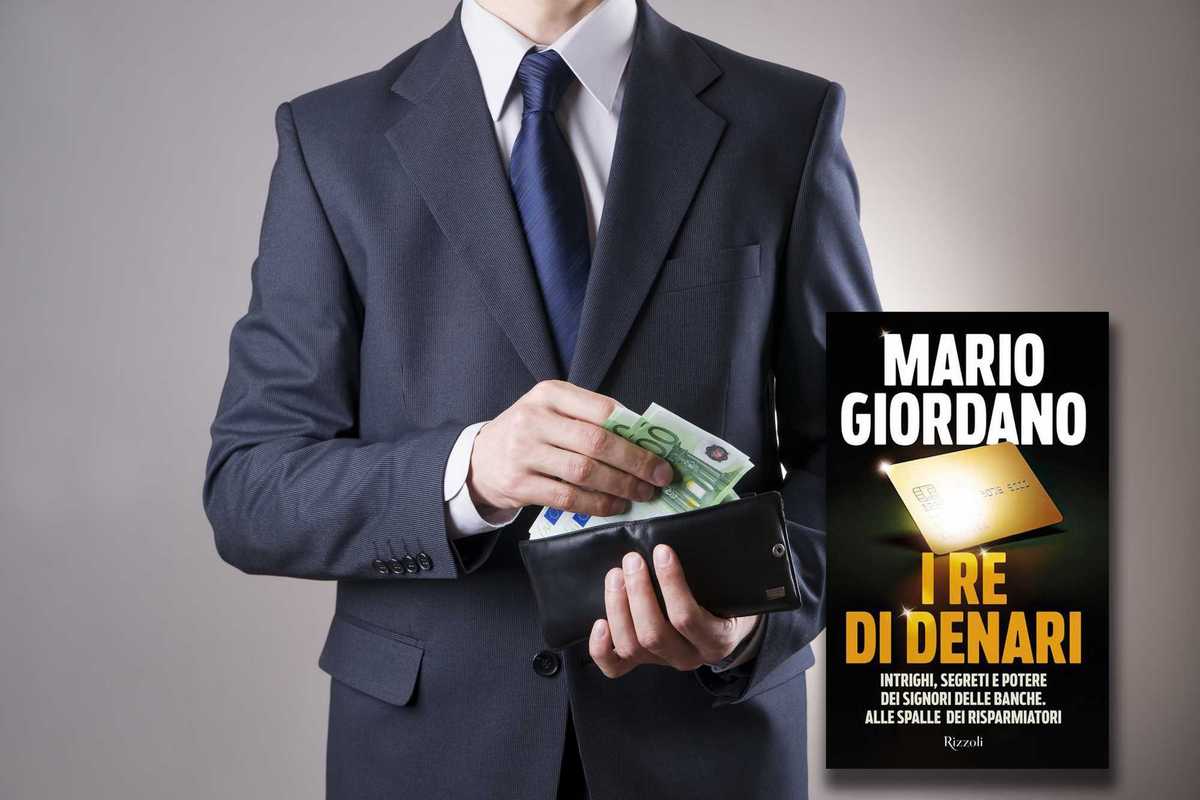Caro Mister Prezzi, le scrivo questa cartolina perché, improvvisamente, mi sono ricordato della sua esistenza. Che strano eh? Ogni volta che c’è un aumento sconsiderato dei prezzi, salta fuori che in Italia abbiamo Mister Prezzi, cioè lei, un funzionario del ministero incaricato proprio di controllare gli aumenti sconsiderati dei prezzi.
Senza, per altro, poterli controllare. Sì, proprio così: lei ha la facoltà di «osservare», «scrutare», «monitorare», «segnalare», in pratica è il voyeur delle oscenità tariffarie. Una specie di umarell nei cantieri della speculazione. Nel senso che gli speculatori ci spennano e lei li guarda (o li monitora, se preferisce) senza avere gli strumenti per fermarli. Al massimo compila una relazione per dire che speculare è proprio una brutta cosa. Come se non lo sapessimo già da soli. Ci siamo chiesti tante volte a che diavolo serva avere Mister Prezzi, e ogni volta ci siamo dati la stessa risposta: a nulla. O, al massimo, a dire «abbiamo attivato Mister Prezzi», come ha fatto l’altro giorno il ministro Urso. Detta così, sembra quasi una cosa vera. Ma, in effetti, che cosa abbiamo attivato? La targhetta sulla porta? La carta intestata? Perché queste sono le uniche armi effettive su cui lei può contare, caro Mister Prezzi: un po’ poco per fermare gli assatanati speculatori. E in effetti lei non li ferma affatto. Ogni volta si riduce a «monitorare». A «osservare». Lei è un guardiano delle vacche scappate, l’uomo che piange sull’aumento versato. Più che Mister Prezzi, Mister X. L’inutilità fatta funzione. O funzionario. La figura fu istituita con la finanziaria approvata il 24 dicembre 2007. Da allora sono stati nominati sei Mister Prezzi, suoi compagni di sventura. Lei è lo sventurato settimo. Il suo nome non è noto ai più: si chiama Benedetto Mineo, palermitano, 65 anni, già amministratore delegato di Equitalia, nonché boss dell’Agenzia delle Entrate, ora è un alto funzionario del ministero delle Imprese e del made in Italy. È in carica come Mister Prezzi dal 2021, senza stipendio aggiuntivo (meno male: ci mancherebbe pure), e ha visto passare sotto i suoi occhi le tempeste più violente, dalla guerra dell’Ucraina a oggi, senza riuscire a fare nulla per fermarle. E, per altro, senza nemmeno riuscire a fare nulla per prevederle. Come un Bernacca che annuncia pioggia quando ormai siamo già tutti bagnati…
Il suo nome Benedetto (benedetto, si fa per dire) salta fuori, infatti, ogni volta che la crisi è già esplosa. Dopo, non prima. Se ne sta in sonno per mesi e mesi, ci dimentichiamo della sua esistenza, poi i prezzi impazziscono e, dopo che sono impazziti, arriva lei che «monitora». Ma che diavolo monitora, mi scusi? Che ci stanno spennando ce ne accorgiamo da soli, non le pare? Lei che sta al ministero dovrebbe fare qualcosa per evitarlo. Oppure dovrebbe rinunciare al titolo di Mister Prezzi che così sa di beffa. Nel 2023 si parlò di un suo possibile ritorno all’Agenzia delle entrate. «Al suo posto», scriveva Repubblica il 10 gennaio di quell’anno, «arriverà un figura che si farà sentire e metterà timore alle compagnie petrolifere». C’eravamo illusi e invece, niente: è rimasto lei che non mette timore a chicchessia. Nessuna altra figura. Soltanto la sua solita figuraccia.
La più antica banca italiana è a Siena e si chiama Monte dei Paschi. Fino a qualche tempo fa tutti la conoscevano come Monte dei Fiaschi. Era praticamente fallita. Poi è intervenuto lo Stato, cioè noi contribuenti. Prima un paio di miliardi. Poi altri. Poi altri ancora. Gli italiani hanno sborsato di tasca loro, per salvarla, almeno 7 miliardi di euro (vogliamo essere prudenti).
Ma come si è finiti nell’abisso? Com’è stato possibile quel disastro? Il manager che incontro in un caldo pomeriggio di luglio conosce dal di dentro la storia della banca di Siena. Una banca nata nel 1472, vent’anni prima della scoperta dell’America. [...] Quando chiedo al manager come sia stato possibile distruggere questo patrimonio in pochi anni, lui sorride. Poi, dopo un attimo di silenzio, mi mostra la cattedrale della città. «La vedi quella?». La vedo. Ma che c’entra? «C’entra». Perché? «Guarda bene: vedi che è incompiuta?». Certo. «E sai perché?». No. «Perché nel Medioevo i senesi volevano costruire la chiesa più grande della cristianità». E non ci sono riusciti. «Cominciarono i lavori, ma poi arrivarono i guai. La peste, la guerra...». Così l’opera è rimasta a metà. «In realtà oggi è un quarto di quello che doveva essere. I senesi sono stati traditi dalla loro ambizione». L’ambizione, sempre quella. «La stessa che li ha traditi con la banca».
[...] Tutto comincia il 3 novembre 2007, in una riunione riservata a Siena, Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps. L’allora presidente del Monte dei Paschi, Giuseppe Mussari, annuncia a tre stretti collaboratori un’operazione colossale: «Prendiamo Antonveneta». Ma Antonveneta è un gigante, si stupiscono loro. «Se la prendiamo diventiamo la terza banca italiana». Ma quanto ci costa? «Il prezzo è a Nord di 6 miliardi», risponde testualmente Mussari. A Nord di 6 miliardi che vuol dire? «Più di 6 miliardi». Più di 6 miliardi? «Sì». E dove li troviamo tutti quei soldi?
In effetti: dove si trovano tutti quei soldi? La domanda rimane senza risposta. Non solo. Il prezzo «a Nord di sei miliardi», in realtà, si rivela molto più a Nord. Troppo a Nord. Arriva infatti a 10 miliardi (9 miliardi più il successivo acquisto di Interbanca da parte di Mps). Che sono tanti. Anzi, un’esagerazione. Soprattutto sono un’esagerazione per comprare una banca che solo poche settimane prima, il 30 luglio 2007, era stata valutata 6,64 miliardi. A rilevarla allora gli spagnoli del Santander che dopo due mesi l’hanno rivenduta al Monte dei Paschi per 10 miliardi. Buon affare per loro, un po’ meno per il Monte: com’è possibile pagare 10 miliardi a novembre ciò che a luglio ne valeva meno di 7? E com’è possibile che nessuno dica nulla? Che nessuno si opponga? Che nessuno protesti? Eppure è quello che succede. Effetto grandeur. L’operazione viene accolta da rulli di tamburo e grida di giubilo. Tutta la città è travolta da un’ondata di euforia. [...]
La notizia del colpo grosso senese trapela la sera del 7 novembre 2007 al Palasport, dove la squadra di pallacanestro sta giocando una partita di Eurolega, appuntamento immancabile per la città. [...] Il giorno dopo, 8 novembre, il Consiglio di amministrazione vara formalmente l’operazione e la notizia diventa ufficiale. È l’inizio del disastro. Eppure sembra l’inizio di una marcia trionfale: le autorità locali festeggiano, le assemblee approvano con votazioni bulgare. E il Capodanno 2008 viene celebrato in piazza del Campo con un superconcerto di cantanti famosi come l’ex Pfm Mauro Pagani, idolo del sindaco di Siena. Concerto gratis, ovviamente, grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi.
A discolpa dei senesi, però, va detto che ad applaudire, in quei giorni sciagurati, non ci sono soltanto loro con la loro vanità. Tutt’altro. L’operazione Mps-Antonveneta viene sottoscritta dalle meglio società di consulenza presenti sul mercato: ci mettono lo zampino Merrill Lynch, J.P. Morgan, Credit Suisse, Banca Leonardo e Mediobanca. Per Merrill Lynch c’è Andrea Orcel, ora a Unicredit. Per Mediobanca c’è Alberto Nagel. Sono, questi ultimi, due dei protagonisti del risiko bancario di oggi. Due dei manager supervalutati e superpagati, re di denari e del mercato. Ebbene: anche loro danno il via libera. Così come dà il via libera la Banca d’Italia, alla cui guida c’è niente meno che Mario Draghi. E così come dà il via libera il ministero del Tesoro, nonostante il parere contrario dei tecnici: lo fa con un «atto politico» da parte dell’allora direttore generale Vittorio Grilli (personaggio interessante, che poi ritroveremo in questa storia). Possibile che fra tutti questi fenomeni, più o meno draghi dell’economia, nessuno si accorga che in quell’operazione c’è qualcosa che non va? Che comprare per 10 miliardi ciò che è appena stato valutato 6 miliardi (e che probabilmente ne vale poco più di 2) non è una buona idea?
Invece nulla. Solo applausi ed euforia. E ovviamente pure i giornali, sempre pronti a cantare nel coro dei potenti, danno fiato alle trombe. Festeggiano l’operazione senza se e senza ma. Anche se qualche dubbio dovrebbe emergere. Anche se il giorno dell’annuncio il titolo di Mps perde il 10 per cento in Borsa. Niente da fare: nessuno coglie i segnali negativi. I titoli grondano solo entusiasmo. Monte Paschi si fa colosso e non cede poteri (La Repubblica, 9 novembre 2007). Mps blitz su Antonveneta. Via alla terza banca italiana (Corriere della Sera, 9 novembre 2007). Il capolavoro del Monte Paschi (Giuseppe Turani, La Repubblica, 11 novembre 2007). Il miracolo Monte Paschi: «Una piccola città regina d’Europa» (La Repubblica, 17 novembre 2007). Nel marzo 2008 il presidente della banca, Giuseppe Mussari, viene addirittura nominato banchiere dell’anno: il premio gli viene conferito proprio per quell’operazione che nel giro di pochi mesi porterà la banca al disastro.
Catanzarese trapiantato a Siena, ex Fgci diventato notabile, matrimonio altolocato e villa chic, più elegante che competente, impeccabile nei suoi abiti tasmania ma non sempre a proprio agio fra i numeri, proprietario di un cavallo (Già del Menhir) capace di vincere il Palio, Mussari si andrà così a schiantare circondato da yes-men e avvolto da una nuvola di tracotanza. Racconta Marco Parlangeli nel suo libro che tempo dopo, incontrandolo in un tribunale, gli chiese perché si era buttato in quella folle avventura. E lui rispose: «Perché così almeno abbiamo una storia da raccontare». Peccato solo che sia la storia di una catastrofe. E peccato soprattutto che quella catastrofe, poi, l’abbiamo pagata noi italiani.
Non si capisce nulla di questa storia, però, se non si racconta che cos’era il Babbo Monte, o se preferite: mucchina, prima del patatrac. Che cosa significava per Siena. In effetti: Babbo Monte era il bancomat della città. Un distributore di soldi e di benessere. Uno sportello automatico sempre aperto. Ovviamente a disposizione della politica. La banca, infatti, dipendeva dalla Fondazione e la Fondazione dipendeva dagli enti locali, che ne nominavano i vertici (dei 16 amministratori otto erano scelti dal Comune, cinque dalla Provincia, uno a testa da Regione, università e diocesi). E gli enti locali a loro volta dipendevano dalla politica, che a Siena nel dopoguerra ha avuto un solo colore, quello rosso del Partito comunista, poi Pds, Ds e Pd. Per questo si è sempre parlato di «banca della sinistra».
Ai tempi dell’operazione Antonveneta, per dire, l’eminenza grigia, l’uomo forte, il gran burattinaio delle vicende bancarie era tal Franco Ceccuzzi, professione dirigente di partito, parlamentare Pd dal 2006 al 2011, primo firmatario di 20 proposte di legge (nessuna diventata legge) fra le quali «tutela del Palio di Siena», «salvaguardia di Siena», «concessione contributi all’Università di Siena» ed «esenzione di Siena dalle imposte». Diventato sindaco nel 2011, stava per ricandidarsi nel 2013 quando ha ricevuto un avviso di garanzia ed è stato costretto a ritirarsi. Verrà assolto dopo 12 anni e dirà: «Il Pd mi ha fatto sparire». Strano, no? L’hanno fatto sparire mentre veniva giù tutto il castello rosso della banca. Chissà perché.
Comunque il castello rosso, bisogna dirlo, per anni è stato un meccanismo a suo modo perfetto. Un motore a quattro tempi che funzionava così: 1) la politica al comando (cioè la sinistra) sceglieva chi comandava in Fondazione; 2) chi comandava in Fondazione sceglieva chi comandava in banca; 3) chi comandava in banca girava i soldi guadagnati a chi comandava in Fondazione; 4) chi comandava in Fondazione distribuiva i soldi sul territorio, consentendo così alla politica (di sinistra) di restare al comando. Un circolo vizioso, insomma. Oppure virtuoso, dipende dai punti di vista.
In quel periodo, in effetti, Siena brillava di luce sfolgorante, mietendo successi in ogni campo: la squadra di basket vinceva scudetti su scudetti, la squadra di calcio era in Serie A, c’era un aeroporto funzionante, mostre, teatri, concerti, attività culturali a non finire. E dietro tutto, ovviamente, i soldi di Babbo Monte. Non c’era iniziativa che non fosse finanziata dalla banca. Nel 2007 la Fondazione era arrivata a distribuire 239 milioni di euro, in pratica più di mille euro per ogni abitante della provincia, neonati compresi. Oltre 3.000 euro a famiglia. È stato calcolato che con i suoi soldi la banca influenzava il 34 per cento del reddito della provincia e il 50 per cento del reddito del comune. Senza contare i 30.000 dipendenti dietro lo sportello. A Siena si diceva: «Qui ogni famiglia ha almeno una persona che lavora, ha lavorato o lavorerà per la banca».
Ma per tenere in piedi quel castello rosso, per tenere oliato quel motore perfetto, c’era una condizione da rispettare. Un elemento fondamentale. Quello che a Siena chiamavano «il tabù del 51 per cento». Cioè: per comandare la banca, e dunque la distribuzione dei soldi sul territorio, la Fondazione doveva continuare a possedere il 51 per cento delle azioni. E per questo anche quando la legge Ciampi (1998) impose alle fondazioni di scendere al di sotto del 51 per cento, a Siena lo fecero solo formalmente, sulla carta. Ed è per questo che, mentre le altre banche si fondevano, il Monte dei Paschi rimase lì, nella sua splendida solitudine senese, evitando ogni proposta di matrimonio che arrivava da fuori. La Fondazione doveva mantenere il 51 per cento delle azioni. Doveva comandare. Perché la politica non poteva fare a meno della sua gallina dalle uova d’oro.
Caro Filippo Anelli, caro presidente dell’Ordine dei medici, le scrivo per sapere a che serve l’Ordine dei medici che lei presiede. Scusi la domanda diretta ma sono rimasto colpito l’altro giorno a leggere di quell’anestesista, Vincenzo Campanile, condannato in primo e secondo grado per l’omicidio volontario di sette pazienti, che continuava a operare indisturbato nel servizio pubblico nazionale, in particolare all’ospedale di Merate, Monza e Brianza. Domando: ha senso un Ordine dei medici che non ferma chi ha sterminato sette anziani? Ha senso un Ordine dei medici che non ferma chi avrebbe sterminato sette anziani dopo aver fermato chi non si voleva vaccinare?
Ricordiamo tutti, infatti, il pugno duro che lei e il suo Ordine avete avuto con quei medici che contestavano il divin siero. Ricordiamo le di sospensioni, le radiazioni, la guerra in ogni ospedale, la caccia a chi, con motivazioni più scientifiche delle vostre, metteva in dubbio la punturina obbligatoria. Ricordo un primario nel mio studio che diceva: «Ho fatto due volte Pfizer e poi ho preso il virus: ho sempre studiato che in questi casi è sbagliato vaccinarsi. Perché ora, invece, mi obbligano?». Sospeso anche lui. La prossima volta ammazzi qualche vecchietto e vedrà che gli andrà meglio.
Non è la prima volta, per altro, che l’Ordine sembra guardare di buon occhio chi sbaglia, purché vaccinato. Per esempio i medici indagati per la morte di Margaret Spada, 22enne uccisa da una rinoplastica sbagliata, dopo quattro mesi erano al lavoro come niente fosse. Il medico indagato per la morte di Simonetta Kalfus, uccisa da una liposuzione sbagliata, ha continuato a operare. Due casi, una polemica. Ma allora lei, caro Anelli, rispose che, in base alle regole dell’Ordine, non si può radiare nessuno fino a condanna definitiva in Cassazione (o, in alternativa, al tribunale ecclesiastico del dio vaccino). Ma io mi chiedo: lei è da otto anni alla guida dei medici italiani. Perché quelle regole non le cambia? Non dovrebbe essere difficile. Eviterebbe di passare per il difensore degli assassini, oltre che dei vaccini Pfizer.
Pugliese di Noicattaro (Bari), 69 anni, medico dal 1987, specializzato in Reumatologia e Farmacologia clinica, presidente dell’Ordine di Bari dal 2012 e dell’Ordine nazionale dal 2018, gran tifoso dei lockdown e anche degli «autolockdown», lei non ha mai esitato a usare l’Ordine per fare politica (lo schierò contro l’autonomia usando discutibili manifesti con una donna malata) e nemmeno a difendere i peggiori esemplari della sua categoria, compresi (di recente) i medici che dichiarano il falso per non mandare i clandestini nei Cpr («Non si può militarizzare la sanità», ha detto). Quando fu eletto nel 2018 proclamò: «Nessun medico dia scandalo», poi se ne deve essere dimenticato perché continua a chiudere gli occhi su chi dà scandalo, purché vaccinato. «Da bambino volevo cambiare il mondo», confidò in un’intervista a Fortune nel novembre 2024. Bel proposito. Peccato però che, da grande, non sia riuscito a cambiare nemmeno un anestesista assassino.