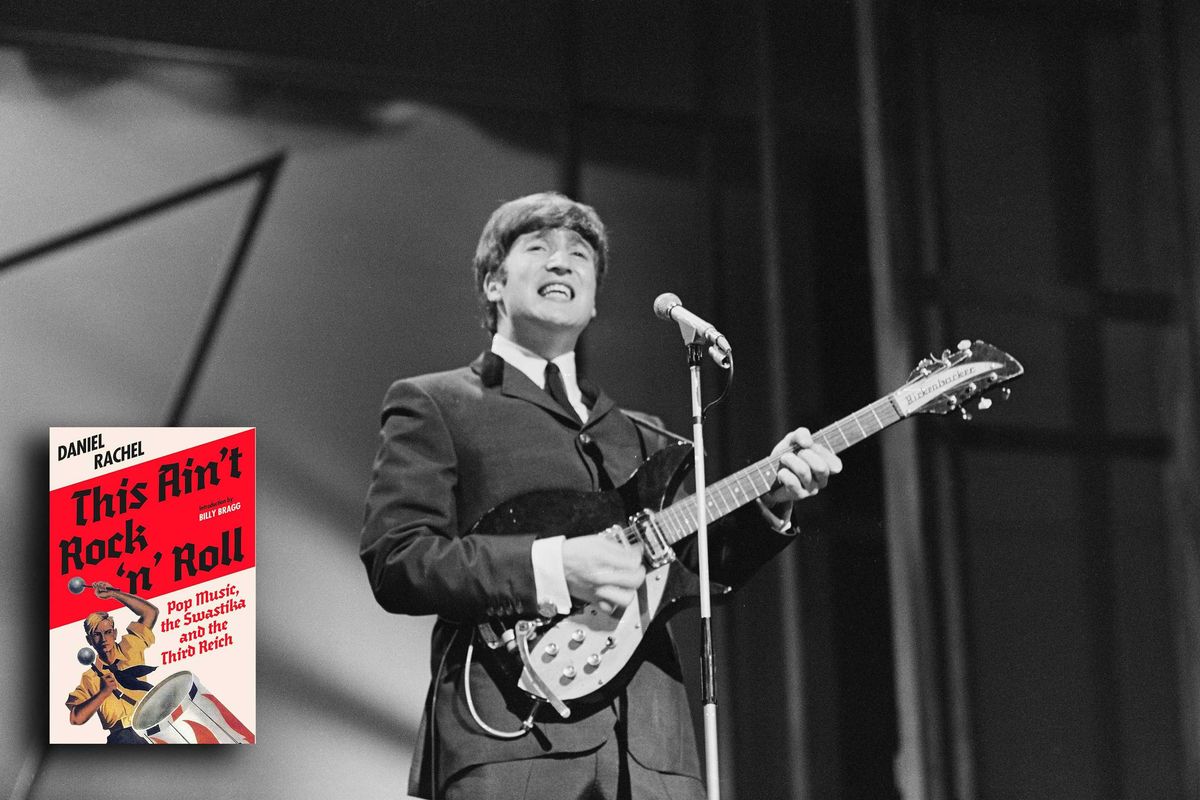2021-02-22
Tre milioni di italiani restano senza cure
Nei primi 9 mesi del 2020 sono saltati 2 milioni di screening oncologici. E i ritardi continuano ad accumularsi. La mappa delle Regioni con gli arretrati più gravi. Cresce la povertà sanitaria: rinviati esami, interventi e controlli Chi può si è rivolto alle strutture private, spesi in media 300 euro. La direttrice dell'Osservatorio Paola Mantellini: «Macchinari e personale sono assorbiti dal Covid. Recuperare il tempo perso? Dipende dall'impegno di ogni Regione». Lo speciale contiene tre articoli. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); Prevenire è meglio che curare. Un vecchio adagio che in tempo di pandemia sembra essere stato dimenticato. Sono oltre 2 milioni, infatti, gli screening oncologici effettuati in meno tra gennaio e settembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Cifre da capogiro quelle fornite dal «Rapporto sui ritardi accumulati dai programmi di screening italiani a seguito del Covid-19», elaborato dall'Osservatorio nazionale screening (Ons) e pubblicato a gennaio di quest'anno. Prima il blocco imposto dal lockdown, poi la ripartenza a passo di lumaca. Spiega Paola Mantellini, oncologa dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) di Firenze e attuale direttore dell'Ons, che non solo «non vi è stato un recupero rispetto al ritardo accumulato precedentemente», ma anzi «il ritardo si è accentuato». Per l'esattezza, sono 2.118.973 gli screening effettuati in meno nei primi nove mesi del 2020, anche se «il quadro complessivo appare molto eterogeneo» e «con grandi differenze tra le Regioni». Sono tre le categorie prese in esame dal rapporto. La situazione peggiore riguarda i controlli per il tumore del colon-retto: 1,9 milioni di soggetti invitati in meno (-42%), 967.000 test persi (-52,7%) e un ritardo accumulato pari a 4,7 mesi. Tradotto in termini di diagnosi mancate, si parla di 1.168 carcinomi e 6.667 adenomi avanzati in meno. Segue poi lo screening del tumore del collo dell'utero, con -1,1 milioni di soggetti contattati (-40,5%), oltre mezzo milione di test effettuati in meno e 2.383 lesioni Cin2+ perse. Regge meglio l'urto - si fa per dire - lo screening del tumore alla mammella, quasi 1 milione di persone invitate in meno (-34,5%), oltre 600.000 test effettuati in meno e 3,9 mesi di ritardo accumulati. Per questa categoria l'Ons stima che le diagnosi perse siano pari a -2.793 carcinomi. Complessivamente, dunque, si stima che l'impatto della pandemia sulle attività di screening sia quantificabile, nei primi 3 trimestri dell'anno passato, in 4 milioni di italiani invitati in meno, e circa 13.000 diagnosi in meno. «Un altro elemento di grande importanza è la stima delle lesioni perse perché la storia naturale di questi tre tumori è molto diversa», ha precisato a margine della presentazione del rapporto il direttore generale di Ispro, Gianni Amunni. «Le conseguenze cliniche maggiori sono potenzialmente a carico dello screening mammografico e di quello colo rettale, dove potrebbe capitare che l'individuazione della lesione tumorale si verifichi a uno stadio più avanzato, perdendo quindi una parte del vantaggio legato alla diagnosi precoce». C'è poi l'effetto deterrente esercitato dalla pandemia. La rilevazione condotta dall'Ons ha riscontrato una minore propensione pari al -17% per lo screening cervicale, -20% per quello colorettale e -21% per il mammografico. Sono state 20 tra Regioni e Province autonome a rispondere alla survey dell'Ons (manca solo la Basilicata), e i risultati dimostrano la presenza di situazioni completamente differenti. Anche in questo caso vanno fatti i dovuti distinguo in base alla tipologia di screening. Per ciò che concerne lo screening cervicale, la prestazione peggiore in termini percentuali l'ha fatta registrare la Liguria (-68,5% di donne esaminate rispetto al 2019), seguita dal Lazio (-56,6%) e dal Piemonte (-56,6%). In termini di ritardo accumulato, invece, primo posto alla Lombardia (-6,2 mesi), secondo alla Liguria (-6) e terzo al Piemonte (-5,1). Sono riuscite a contenere i danni, invece, Sardegna (-19,7%), Valle d'Aosta (-20,2%) e Bolzano (-20,4%), con ritardi accumulati «appena» sotto i due mesi. Viceversa, la Sardegna risulta la peggior regione rispetto alla percentuale di screening mammografico (-68,7%), seguita da Calabria (-65,1%) e Trentino (-59,7%). Virtuoso, invece, il Friuli Venezia Giulia, con una donna su 5 in meno invitata all'appuntamento. Eccezion fatta per questa regione, che ha accumulato un ritardo di 1,7 mesi, le performance in termini di tempo da recuperare sono tutte negative: si va dai 2,6 mesi della Toscana fino ai 6,2 della Sardegna. Malissimo lo screening colorettale in Calabria (-93,9% di donne esaminate) con un ritardo di ben 8,4 mesi, ma rimangono indietro anche Lombardia (-7,1 mesi), Liguria e Campania (-6,4). «Sulla base di quanto osservato non sembra essere più nemmeno adeguato parlare di piani di rientro», ha osservato l'epidemiologo ed ex direttore dell'Ons Marco Zappa, «ma è necessario che il sistema screening vada fortemente ripensato nel suo complesso e con logiche di solida ristrutturazione, cioè di corretta, efficiente e stabile allocazione delle risorse». E di questo passo, avverte l'Ons, «il danno alle lesioni giustificate potrebbe diventare clinicamente importante». Trascurare il tassello fondamentale della prevenzione, in altre parole, rischia non solo di vanificare i progressi compiuti finora in termini di sensibilizzazione della popolazione, ma anche di costringerci a dover fronteggiare nel prossimo futuro un'ondata di casi gravi, con costi incalcolabili sul piano umano ed economico. Ma c'è anche un altro aspetto a destare particolare preoccupazione. L'attività di screening, osserva l'Ons, funge da «ri-equilibratore sociale», e «stante la difficoltà a recuperare il ritardo accumulato, le fasce di popolazione più abbienti e con livelli di istruzione più elevati decidano di ricorrere a offerte di prevenzione individuale di tipo privatistico». Con una conseguenza piuttosto ovvia, e cioè che «le persone che potrebbero risentire maggiormente dell'impatto negativo del ritardo sarebbero quelle appartenenti alle fasce di popolazione più fragile». Rispondendo a un'interrogazione presentata a fine ottobre dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli, l'allora sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ha certificato la situazione disastrosa. «L'epidemia da Covid-19 ha impattato fortemente anche sui programmi organizzati di screening», ha ammesso la Zampa, citando le risorse stanziate dal decreto Agosto (pari a 478 milioni di euro) al fine di «corrispondere alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo emergenziale dovuto» alla pandemia. Senza dubbio il ruolo delle Regioni nella pianificazione della ripartenza degli screening è cruciale, ma ci vuole l'aiuto dello Stato per superare le criticità logistiche e organizzative. Contattato dalla Verità, l'Osservatorio nazionale screening spiega che i prossimi dati saranno disponibili per l'inizio della primavera. Chissà se per quella data si potrà intravedere i primi segnali positivi. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/non-pensate-solo-al-covid-la-prevenzione-e-crollata-2650689730.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="tre-milioni-di-italiani-rinunciano-alle-cure-non-abbiamo-soldi" data-post-id="2650689730" data-published-at="1613939759" data-use-pagination="False"> Tre milioni di italiani rinunciano alle cure. «Non abbiamo soldi» Tre milioni di italiani sono stati costretti a rinunciare alle cure mediche per colpa delle difficoltà economiche insorte a seguito della pandemia. È questo il dato principale, e forse anche il più inquietante, emerso da una ricerca condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione adulta nazionale e pubblicato a gennaio. Tra marzo e dicembre 2020, dunque, 1 italiano su 20 si è dovuto arrendere alla dura realtà e scegliere suo malgrado di procrastinare esami, cure e interventi, semplicemente perché non poteva permetterseli. La fotografia di un aspetto spesso dimenticato della pandemia, quello che riguarda tutti gli «altri», vale a dire i milioni di cittadini bisognosi di assistenza e cure al di là del Covid. Non è tutto, perché 32,8 milioni di persone - dunque più di 1 italiano su 2 - si sono visti rinviare o annullare operazioni o visite. Circa 27,9 milioni di cittadini hanno subito due o più rinvii, mentre 13 milioni hanno dovuto far fronte all'annullamento. Scendendo nel dettaglio delle discipline, più di 8 pazienti su 10 che attendevano prestazioni nel campo della gastroenterologia e 3 pazienti su 4 in quello dell'urologia hanno subito ritardi o cancellazioni. Disservizi che hanno colpito anche i pazienti affetti da patologie gravi, come quelle cardiologiche (61,7%) e oncologiche (47,2%). Pesanti i ritardi in termini di mesi: mediamente i rinvii si sono attestati intorno ai due mesi (53 giorni), mentre quasi 7 appuntamenti su 10 sono stati rinviati sine die, cioè a data da destinarsi. Una situazione che, spiega il rapporto Facile.it, ha dissuaso il 68,6% - parliamo di circa 30 milioni di italiani - a prenotare o effettuare operazioni, visite ed esami specialistici. Nella maggioranza dei casi (71,3%) il motivo della rinuncia è stata la paura di ammalarsi di Covid, mentre la restante parte si è fatta intimorire dai lunghissimi tempi di attesa. La situazione di forte stress del sistema sanitario pubblico fa gioire il settore privato. Quasi un terzo (30,2%) degli intervistati che hanno subito annullamenti o rinvii nel pubblico hanno poi deciso di effettuare il controllo in una struttura privata. Secondo l'indagine, circa 7 milioni di italiani hanno scelto di abbandonare la sanità pubblica optando per quella privata. E qui iniziano le note dolenti. Chi si è rivolto a una struttura privata dichiara di aver speso, in media, 292 euro per ogni singola visita, esame o operazione. Forse si tratta di pochi spiccioli per chi se lo può permettere, ma un'enormità per una fetta considerevole di concittadini che fa i salti mortali per arrivare a fine mese e si trova spesso a faticare nel mettere insieme il pranzo con la cena. Non sorprende, dunque, che per fare fronte ai costi della sanità privata il 73,2% degli italiani abbiano attinto ai propri risparmi. Quel gruzzoletto conservato per prudenza, e sul quale 7 italiani su 10 hanno fatto affidamento pur di non rinunciare alle cure. Il 16,6% ha fatto invece ricorso a un'assicurazione sanitaria, mentre circa 2,2 milioni di pazienti (pari al 9,1% di chi ha fatto ricorso alla sanità privata) ha dovuto indebitarsi chiedendo un prestito a parenti, amici, oppure a una finanziaria. Una quota ancora superiore al Sud e nelle isole, territori nei quali questa percentuale sale inaspettatamente all'11,9%. L'osservatorio di Facile.it e Prestiti.it ha passato al vaglio ben 125.000 domande di finanziamento, svelando l'identikit dei richiedenti. Nel 2020, l'importo medio dei prestiti personali con questa motivazione è stato pari a 6.145 euro, con tempo di restituzione pari a 53 mesi (quasi 4 anni e mezzo). L'età media è di 46 anni, superiore del 10% rispetto alla media dei prestiti, e nel 39% dei casi a richiedere il finanziamento è stata una donna (contro il 25% del totale dei prestiti). Un'evoluzione che sorprende fino a un certo punto. Secondo un'elaborazione di Quotidiano Sanità, il Sistema sanitario nazionale perde pezzi ormai già da tempo. Confrontando i dati dell'Annuario Ssn pubblicato dal ministero della Salute, dal 2013 al 2018 il settore pubblico ha perso il 5,2% delle strutture, mentre quello privato ne ha guadagnato il 7,2%. Le lunghissime liste d'attesa peggiorate dall'attuale contesto pandemico hanno solo aggravato un fenomeno in corso. L'ultimo rapporto Rbm-Censis sulla sanità ha messo in luce come nel 2019 la spesa privata abbia toccato quota 37,3 miliardi di euro, facendo registrare una crescita del 7,2% contro un -0,3% rispetto a quella pubblica. Le prestazioni sanitarie pagate dai cittadini sono passate da 95 a 155 milioni, mentre la spesa privata per famiglia è pari a 1.522 euro (+3% rispetto al 2017) e quella pro-capite a 691,84 euro (+12%). Parallelamente, l'incidenza della spesa sanitaria privata sul reddito è passata dal 2,6% del 2007 al 3,3% del 2019. E già due anni fa il ricorso al prestito rappresentava una tendenza in crescita, con una quota di italiani che decidono di fare ricorso ai finanziamenti per sostenere le cure passata dal 10% al 27%. «Dall'inizio della crisi, in circa 10 anni, la spesa pubblica per la salute in Italia, si è fermata, mentre la spesa delle famiglie ha continuato a crescere», recita il rapporto. «Nella maggior parte dei percorsi di cura gli italiani si trovano a dover accedere privatamente a una o più prestazioni sanitarie. E la necessità di pagare di tasca propria cresce in base al proprio stato di salute (per i cronici la spesa sanitaria privata è in media del 50% più elevata di quella ordinaria, per i non autosufficienti è in media quasi 3 volte quella ordinaria) e all'età (per gli anziani la spesa sanitaria privata è in media il doppio di quella ordinaria)». Ovviamente le esigenze variano a seconda degli ambiti di intervento. Nel solo settore odontoiatrico, il 92% delle cure viene pagato di tasca propria dagli italiani, con una spesa media di 575 euro. Non mancano tuttavia i beni sanitari di assoluta evidenza, con i farmaci a rappresentare la seconda voce di spesa pagata direttamente dai cittadini (380 euro) e la prima in termini di frequenza (380 euro). Pesano poi anche gli occhiali (220 euro) e protesi e presidi (185 euro). Capitolo a parte per gli esami diagnostici, che vengono pagati privatamente in un caso su quattro, e sulle prestazioni ospedaliere, dove i cittadini sostengono direttamente i costi una volta su dieci. Un vero e proprio bagno di sangue per gli italiani che la pandemia non ha fatto altro che aggravare. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/non-pensate-solo-al-covid-la-prevenzione-e-crollata-2650689730.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="bisogna-ripensare-tutto-il-sistema" data-post-id="2650689730" data-published-at="1613939759" data-use-pagination="False"> «Bisogna ripensare tutto il sistema» L'oncologa Paola Mantellini lavora a Firenze all'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) della Regione Toscana e dirige l'Osservatorio nazionale screening. I vostri dati registrano una gigantesca frenata nell'attività di prevenzione. Non si poteva fare diversamente? «È molto difficile. Nella sanità tutto è concatenato e se si presenta un'emergenza alla quale non si è preparati ne risente tutto il sistema. Diciamo che si sarebbe potuto fare diversamente se tutta l'organizzazione della salute pubblica fosse stata pronta alla pandemia». Che cosa non ha funzionato in particolare? «C'è stato un problema di spazi: la scorsa primavera abbiamo dovuto chiudere tutto per due mesi, marzo e aprile. Le persone che dovevano sottoporsi ai test di screening, ad esempio, non potevano più presentarsi nelle strutture sanitarie che erano state destinate a spazi per i malati Covid. E poi il nostro personale dedicato agli screening è stato in buona parte assegnato alla gestione dell'emergenza, e in taluni territori lo è ancora». Quindi si sono accumulati ritardi nella fase acuta della prima ondata e anche dopo. «È inevitabile. Le nuove regole di sicurezza sanitaria impongono distanziamento fisico e sanificazione, per cui se prima dell'emergenza - poniamo - si potevano prevedere 4 appuntamenti all'ora, adesso sono dimezzati. Le sale d'attesa devono essere vuote e tutti gli ambienti vanno sanificati, il che non consente di tenere i ritmi precedenti. E molte persone ora, per paura del contagio, hanno maggiori timori nel presentarsi se non si tratta di vere urgenze». Problemi anche per le attrezzature mediche? «Non tutto il personale è ancora rientrato a tempo pieno per svolgere le attività di prevenzione. In più, una buona parte dei macchinari utilizzati per analizzare i campioni, come ad esempio il test Hpv, sono stati destinati quasi a tempo pieno per processare i tamponi molecolari». È così in tutta Italia? «Dipende dall'organizzazione sanitaria delle singole Regioni. È chiaro che chi è stato più colpito fa più fatica a riprendersi, e così pure chi già prima presentava carenze organizzative». L'Ons segnala che si sono accumulati arretrati anche di molti mesi. Anche da voi si allungano le liste d'attesa? «Non abbiamo liste d'attesa perché gli screening avvengono su inviti spediti periodicamente dalle strutture di prevenzione. Ma è chiaro che il numero di inviti è stato drasticamente ridotto. E si deve tenere conto che certi fattori non dipendono da noi». Per esempio? «Banalmente, durante il lockdown di marzo e aprile i servizi postali hanno consegnato in ritardo le lettere o non le hanno consegnate proprio. Teniamo anche conto che molte nostre attività per favorire la prevenzione si basano sull'azione di volontari: un buon numero sono pensionati e in questo periodo non possiamo contare su di loro». Quanto ci vorrà per recuperare il tempo perduto? «Dipende dall'impegno di ogni Regione. I dati di settembre ci dicono che non c'è stato un completo recupero in estate rispetto ai ritardi accumulati durante i due mesi di chiusura, anche se la situazione non è uguale in tutta Italia. Ci sono infatti Regioni che hanno sensibilmente ridotto il ritardo, altre invece sono più in difficoltà. Sicuramente, finché non sarà raggiunta l'immunità di gregge saremo costretti ovunque a procedere a ritmo ridotto». Che cosa hanno insegnato questi mesi a chi svolge attività di prevenzione? «Che occorre un profondo ripensamento dell'organizzazione sanitaria. Non è soltanto una questione di risorse economiche: serve anche una riflessione per immaginare nuovi modelli di sanità. La prevenzione oncologica è considerata un'attività importante ma rinviabile, non indispensabile. Come abbiamo visto, è accaduto anche con l'esplodere della pandemia. Invece gli screening vanno potenziati». Un investimento oggi per un risparmio futuro. «Non è appena un tema finanziario. Scoprire un tumore nella fase iniziale consente cure migliori, meno invasive e con maggiori possibilità di successo. Degli screening beneficiano soprattutto i pazienti: è questo che bisogna capire».
Il Tempio di Esculapio, all’interno del parco di Villa Borghese (IStock)
John Lennon e la cover del libro di Daniel Rachel (Getty Images)
Gianrico Carofiglio (Ansa)