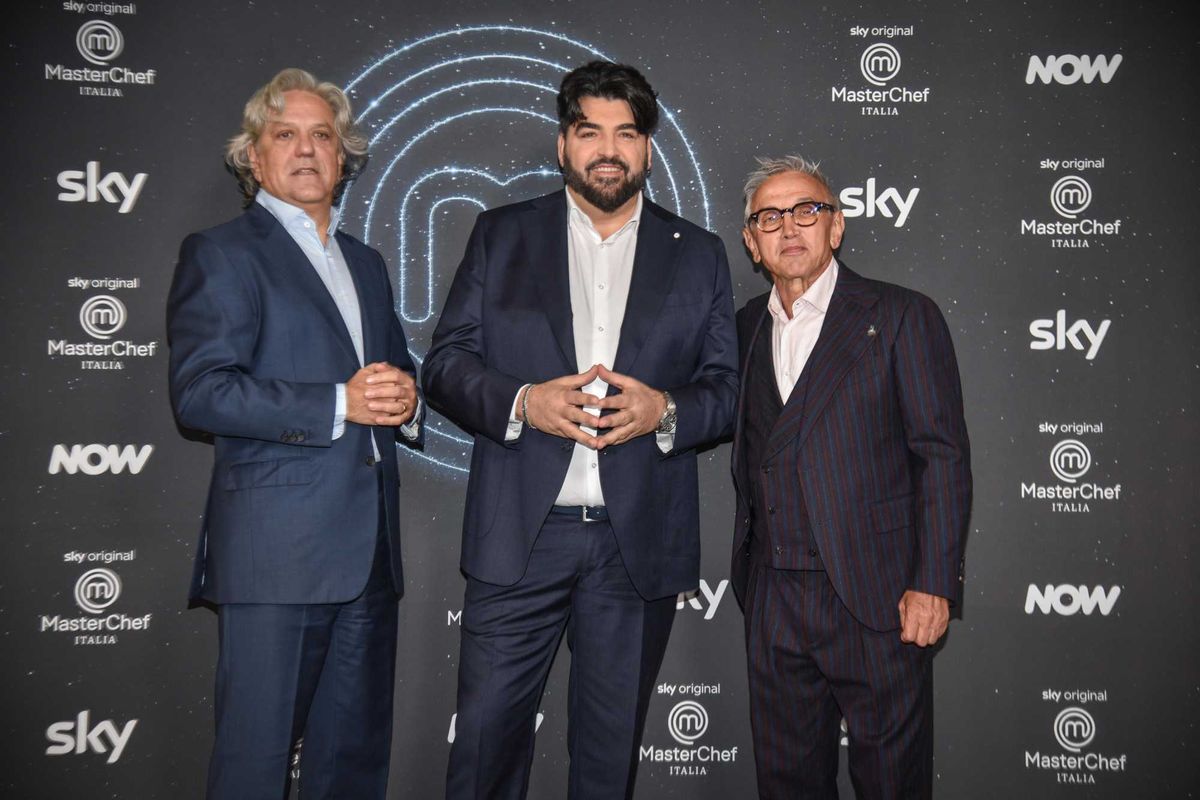Hanno puntato il dito contro le forze dell'ordine, accusandole di essere intervenute con ritardo, lasciando così la povera Saman Abbas in balia dei suoi aguzzini. Hanno detto che era colpa dell'Italia, che non integra a sufficienza, non fa passare lo ius soli e non è abbastanza accogliente nei confronti degli stranieri. Poi, ovviamente, hanno chiamato in causa la violenza maschile, la grande piaga che affligge tutto il mondo. «L'islam non c'entra!», gridavano. «È colpa dei maschi che trattano le donne come oggetti “a tutte le latitudini"».
Fin dall'inizio, insomma, hanno cercato di occultare aspetti fondamentali del mostruoso caso di Saman: in primis il ruolo della religione e della cultura di appartenenza. Ed è un ruolo molto rilevante, dato che in Pakistan non sono permessi ma sono frequenti i matrimoni forzati, e sono invece concessi ed estremamente diffusi i matrimoni fra maschi adulti e ragazze minorenni (del resto queste pratiche sono ammesse dalla legge coranica, che in Pakistan ha un'influenza fondamentale).
Incolpare la «violenza maschile», inoltre, ha fatto sì che passasse in secondo piano il comportamento della famiglia, e quello della madre in particolare. Sappiamo da giorni della raccapricciante telefonata - udita dalla stessa Saman - in cui Nazia Shaheen, la donna che le aveva dato la vita e avrebbe dovuto amarla più di sé stessa - parlava di ammazzarla perché troppo riottosa. La madre si preoccupava di «quale figura» avrebbe fatto con i parenti e gli amici pachistani a causa della figlia degenere, e già questo basterebbe a descriverla. Ma c'è di più. A quanto pare, Nazia è stata l'ingranaggio fondamentale del meccanismo scattato attorno a Saman come una trappola per topi. Sarebbe stata proprio lei, la madre, a convincerla a tornare a casa dopo il soggiorno nella struttura protetta. Come? Con un sms rassicurante, quasi implorante: «Ti prego fatti sentire, torna a casa. Stiamo morendo. Torna, faremo come ci dirai tu». Peccato, appunto, che fosse solo una scusa.
Le tante, troppe parole sul «patriarcato» e la «mascolinità tossica» hanno occultato verità atroci, ma sono servite a individuare un capro espiatorio sempre utile, buono per ogni circostanza: il bianco occidentale. Il filosofo francese Pascal Bruckner ha individuato nel «maschio bianco» il «colpevole quasi perfetto», l'oggetto di odio per eccellenza, il nemico numero uno di tutte le minoranze e di larghissima parte della cultura progressista.
La sua collega italiana Michela Marzano, ieri sulla Stampa, ha risposto che Bruckner esagera, e gli ha raccomandato di non fare troppo il piagnone, perché concentrandosi sui maschi bianchi si cancellerebbe «la sofferenze di chi, per secoli, è stato relegato ai margini della società» (neri, stranieri, gay, trans eccetera). Il fatto, però, è che oggi le istanze di queste minoranze sono tutt'altro che oscurate, anzi dominano la scena. E tutte, senza esclusione, sostengono che la causa dei loro mali sia la stessa: l'uomo bianco, appunto. «C'è una sorta di “peccato originale"», ci ha spiegato Bruckner. «L'uomo bianco, qualunque cosa faccia, è colpevole di esistere. È colpevole di essere. Questa è la definizione stessa di razzismo, era l'accusa rivolta dai nazisti agli ebrei. In questo caso diamo la colpa ai bianchi. È abbastanza sorprendente vedere che gli “antirazzisti" sono in realtà neorazzisti».
A differenza di ciò che sostiene la Marzano, parlare del capro espiatorio bianco non esclude i ragionamenti sulle minoranze, semmai avviene l'esatto contrario. Dando sempre la colpa al bianco, non vediamo i veri colpevoli delle violenze e delle discriminazioni, che nel caso di Saman sono la cultura di provenienza e il clan.
Puntando gli occhi sull'uomo bianco trascuriamo persino le dinamiche (per lo più dipendenti dal sistema economico dominante) che causano problemi alle minoranze. Ci concentriamo sul razzismo sistemico o la discriminazione dei trans ed evitiamo di parlare dei salari troppo bassi, delle tasse troppo alte, dello sfruttamento della manodopera, dei problemi legati alla casa. Non vediamo l'oppressione reale per concentrarci su oppressioni immaginarie. Tutto ciò, manco a dirlo, è molto conveniente non solo per i potentati economici che lucrano sul mercato delle minoranze, ma pure per gli attivisti. Un esempio è Reni Eddo-Lodge, giornalista e militante britannica nera che ha appena pubblicato un libro intitolato Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche (Edizioni e/o). Costei sostiene, al solito, che i bianchi siano razzisti proprio in quanto bianchi. È diventata famosa grazie a una sorta di articolo-manifesto sul razzismo sistemico, e da quando lo ha pubblicato, spiega, non ha «fatto altro che parlare di razzismo - in festival di musica e studi televisivi, ad allievi di scuola secondaria e a convegni di partito - e le richieste non sembrano accennare a diminuire». Già: la Eddo-Lodge, come le tante Murgia di casa nostra, è diventata una professionista dell'indignazione. Parlando di «privilegio bianco» ha ottenuto privilegi negati alla grandissima parte delle persone comuni, bianche e non.
Ecco che cosa accade nella realtà: corriamo appresso a questi maestrini del risentimento senza ragionare. Si parla delle ricche manager «vittime» dei colleghi maschi che guadagnano qualche milione di dollari più di loro, ma non delle donne che non si azzardano a fare figli per timore di non poterli mantenere. Parliamo della fluidità di genere che dovrebbe ribaltare il patriarcato, ma poi ci si dimentica degli «spazi sicuri» per le donne (anche lesbiche). Parliamo del razzismo dei bianchi e intanto una madre pachistana attira in trappola la figlia e la consegna al carnefice, e se citi l'islam ti accusano di razzismo.
Chissà, forse a questo punto ci toccherà creare la nuova categoria di «privilegio islamico».