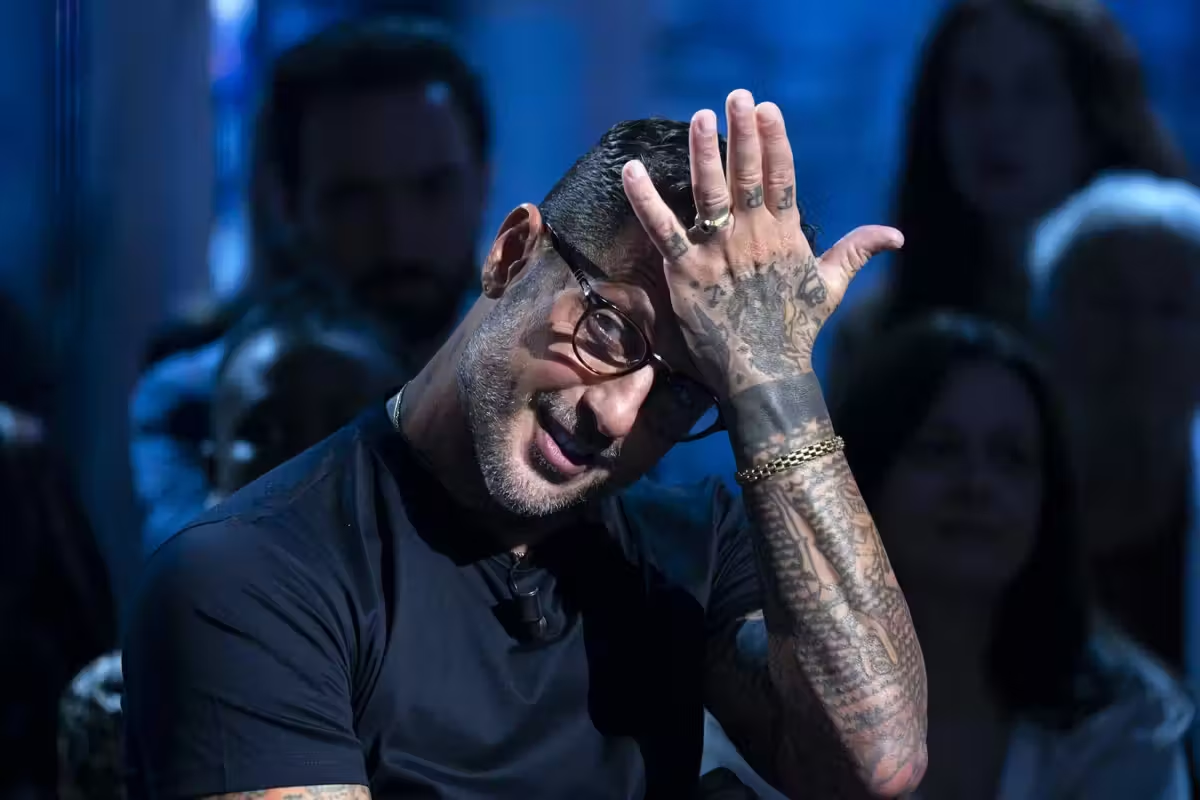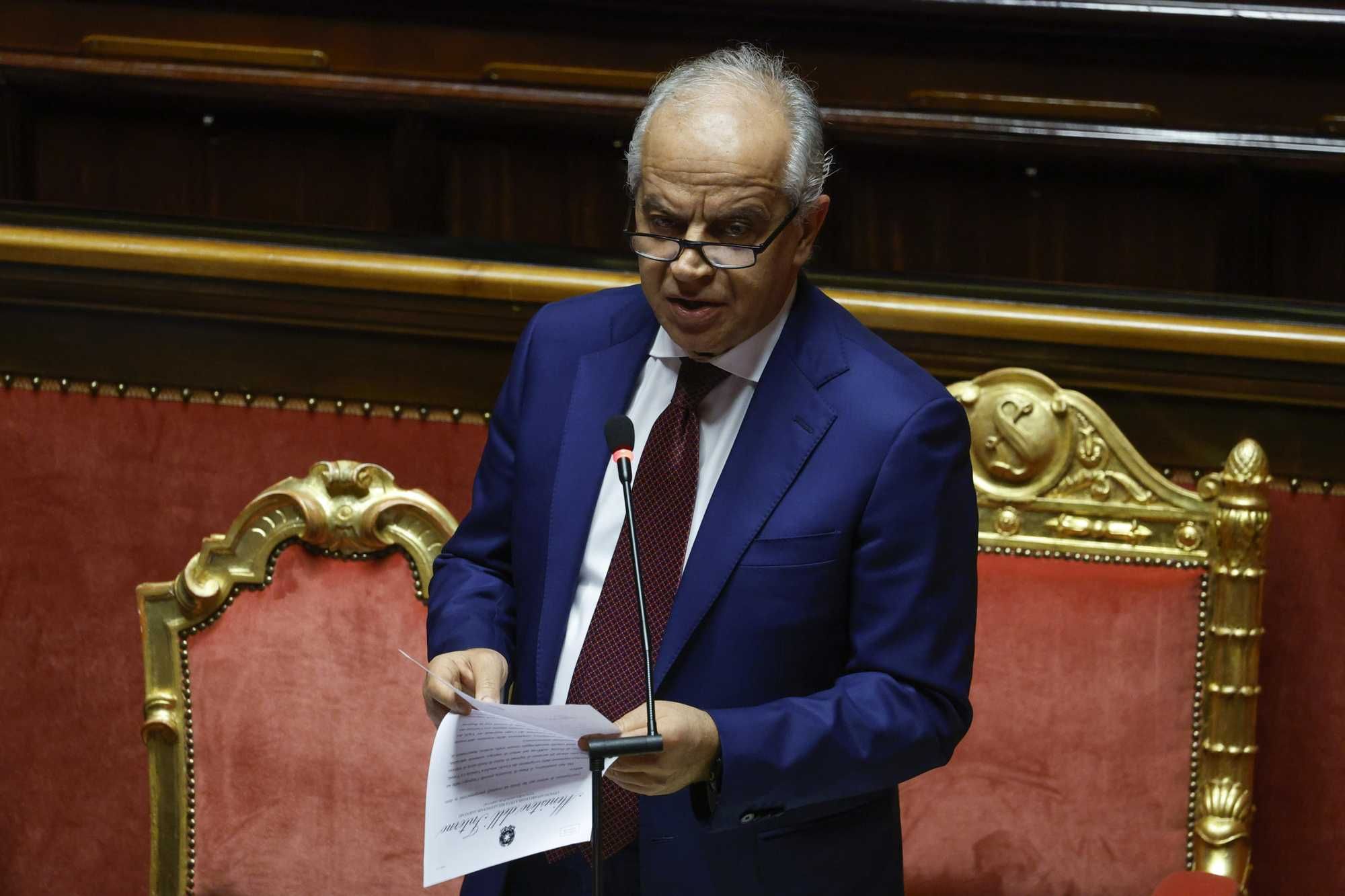Mao Zedong una volta ebbe a dire: «Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione dunque è eccellente». In questa frase, il leader cinese racchiudeva l'essenza di quella che era la Rivoluzione culturale: l'idea era sostanzialmente quella di tenere la Repubblica popolare in un movimentismo costante, con cui Mao poteva - nel breve termine - colpire i suoi avversari interni, impedendo al contempo - nel lungo - che la società e le istituzioni cinesi si ritrovassero soggette a cristallizzazioni di potere e a rendite di posizione. La Cina avrebbe dunque dovuto fondarsi su una dialettica perenne, onde evitare ogni irrigidimento reazionario. Si tratta, a ben vedere, di una strategia sotto molti aspetti simile a quella adottata da Donald Trump. Una strategia, cioè, che consente al presidente di interpretare la parte dell'uomo forte: pronto a silurare i subalterni incapaci, secondo i rodati princìpi dello «you're fired».
In tal senso, il presidente non soltanto mira a ottenere maggiore efficienza dai suoi collaboratori tenendoli sulla corda ma, nel riproporre il movimentismo originario, l'obiettivo è anche quello di mantenere in piedi il contatto diretto con il suo elettorato. Istituzionalizzarsi troppo significherebbe, in questa logica, tradire la propria base. Inoltre, questa sorta di baraonda organizzata permette al presidente di evitare che possano crearsi grumi di potere interni all'esecutivo: grumi che potrebbero contrapporsi alla sua persona e alla sua linea. Vuole insomma evitare di avere a che fare con delle eminenze grigie che cerchino di dirigerlo (un po' come, si racconta, avrebbe fatto l'allora vicepresidente, Dick Cheney, con George W. Bush ai tempi della guerra in Iraq).
Certo: il rovescio della medaglia di tutto questo è rappresentato da un forte grado di imprevedibilità politica, oltre al fatto che il presidente mostri spesso delle difficoltà a trovare dei collaboratori capaci e leali. Ciononostante, piaccia o meno, questa è l'anima operativa della Trump revolution: la volontà di negare i bizantinismi politico istituzionali, in ossequio a una leadership potentemente bonapartista. Eppure, alla fine, un «problema» c'è. Ed è la stessa Costituzione americana. Il presidente degli Stati Uniti non è onnipotente. Non è un sovrano assoluto, non è il Re Sole. […]
La paralisi politico istituzionale in cui l'amministrazione Trump si è trovata soprattutto nei primi sei mesi fu dovuta in particolare a questo problema. L'essersi inimicato gran parte del ceto politico statunitense (tanto democratico quanto repubblicano) ha avuto delle conseguenze. E le vendette politiche non si sono fatte attendere.
Non dimentichiamo che, per ben due volte, il tentativo portato avanti dai repubblicani di abolire Obamacare sia stato boicottato da una fronda interna (soprattutto al Senato). Per quanto riguarda i democratici, poi, viste le faide che li dilaniano, l'unica bandiera che sembrano politicamente seguire è quella dell'ostruzionismo anti trumpista (indubbiamente legittimo, ma un tantino sterile). In questo clima da Vietnam parlamentare, Trump, a un certo punto, ha dovuto parzialmente cambiare atteggiamento. Non soltanto nei rapporti con quello che -almeno teoricamente - dovrebbe essere il suo partito. Ma anche nelle relazioni con l'asinello. La trasversalità politica del presidente lo porta infatti ogni tanto a intestarsi battaglie tradizionalmente legate al mondo democratico. Il caso più eclatante è senza dubbio la questione del controllo delle armi. Pur essendo stato uno strenuo sostenitore della lobby delle armi ai tempi della campagna elettorale, dopo la strage di Parkland, il magnate ha iniziato a proporre una serie di restrizioni che cozzano profondamente con la linea tenuta dai repubblicani negli ultimi dieci anni. Senza poi dimenticare che, già nel settembre del 2017, la Casa Bianca avesse raggiunto un accordo provvisorio con i democratici sul rifinanziamento delle attività federali e sulla sospensione del tetto del debito, andando loro parzialmente incontro sul tema dell'immigrazione (una mossa che suscitò non a caso le ire della destra).
Da tutto questo, si comprende come Trump non sia affatto un presidente ideologizzato e che non disdegni di ricorrere talvolta a una riedizione della «strategia dei due forni» di andreottiana memoria. Negli anni Settanta, in Italia, Giulio Andreotti governò più volte oscillando tra il Partito socialista (da una parte) e il Partito liberale (dall'altra), per cercare di dare la massima solidità possibile a esecutivi invero non poco scricchiolanti. Bisognava dunque capire, di volta in volta, quale dei due forni fosse quello più conveniente. E comportarsi di conseguenza.
Ecco: pur fatte le dovute distinzioni, Trump non è affatto estraneo a questo atteggiamento. Lo abbiamo visto per quanto concerne i mesi passati. E, probabilmente, ce ne accorgeremo in quelli futuri. Sono infatti almeno due le proposte politiche annunciate dal magnate che richiederanno, probabilmente, un appoggio da parte dei democratici. Innanzitutto c'è la riforma infrastrutturale che, prevedendo una cospicua serie di investimenti pubblici, molti repubblicani guardano con sospetto, laddove - invece - soprattutto tra i seguaci di Bernie Sanders vi sono non pochi fautori di questa linea. Un discorso simile è valso per i dazi. Anche in questo caso, alcuni deputati della sinistra si erano detti d'accordo con il protezionismo anti cinese del presidente, quando svariati repubblicani non hanno risparmiato critiche a Trump. [...]
D'altronde, la strategia dei due forni il miliardario non deve usarla solo nei rapporti tra elefantino e asinello. Ma anche all'interno dello stesso Partito repubblicano [...]. Sotto questo aspetto quindi, l'approccio «democristiano» di Trump tra le sue file non è esattamente una novità. L'esempio più recente è quello di George W. Bush che dovette barcamenarsi tra le varie fazioni repubblicane con complicatissimi equilibrismi [...].
Ma non è tutto. Perché l'attuale presidente mescola queste linee ossimoriche anche nell'àmbito delle relazioni internazionali: basti pensare ai rapporti altalenanti con la Cina sul versante commerciale o all'approccio usato nei confronti della Corea del Nord prima di arrivare alla distensione diplomatica: una tecnica negoziale che, a ben vedere, il magnate aveva già parzialmente «teorizzato» nel suo libro The art of the deal, pubblicato nel 1987. In tutto questo, Trump si trova dunque nella difficile situazione di coniugare movimentismo e diplomazia, rottura e riformismo. È attraverso questa via strettissima che si giocano le sorti della Trump revolution, nel tentativo (non certo facile) di fondare un bonapartismo istituzionale. Quello davanti a cui ci troviamo è una sorta di centauro, insomma: una mescolanza tra Mao e Andreotti, tra la volpe e il leone, che non è chiaro ancora se riuscirà a fondare una tradizione politica o se sarà invece destinata a risolversi in una bolla di sapone.