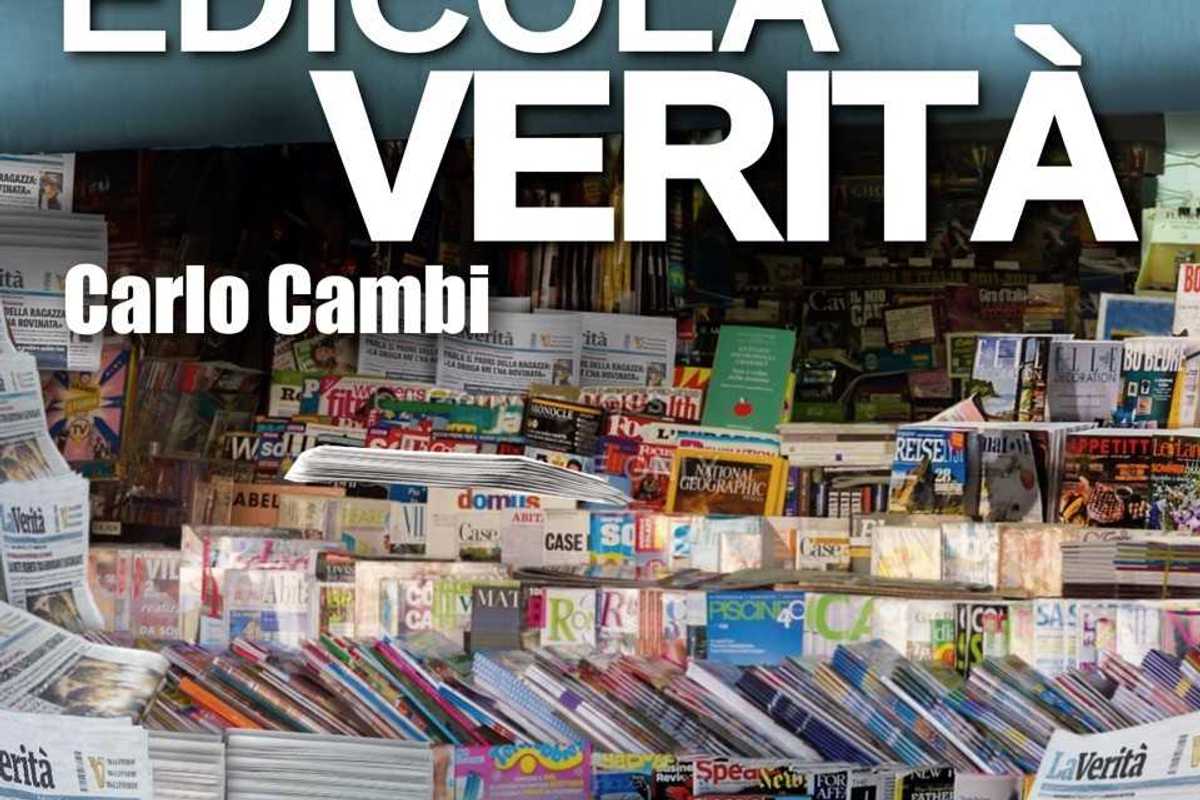True
2024-01-11
Meglio «I Soprano» vecchi di 25 anni che le favole buoniste degli algoritmi
Getty Images
«Sono il Re Mida al rovescio, tutto quello che tocco si tramuta in mer...», diceva il capomafia Tony Soprano (interpretato da James Gandolfini, rimasto nell’immaginario ancora oggi, nonostante sia morto da 10 anni), scandendo una delle tante battute che hanno reso la serie prodotta dalla Hbo uno spartiacque di tre ere televisive recenti. In questi giorni di gennaio le avventure della famiglia criminale italoamericana del New Jersey - andate in onda dal 1999 al 2007 nell’arco di sei stagioni e 86 episodi - compiono 25 anni, e sembra passato un secolo dalla prima puntata, anche perché quella libertà narrativa che ha fatto della sceneggiatura scritta da David Chase «la serie più determinante di decenni di cultura pop televisiva» (la definizione è del New York Times) è stata sacrificata sull’altare dell’algocrazia addizionata di abbondanti dosi di cultura woke e censura. Prima dell’avvento dei Soprano, la serialità televisiva era spesso raccontata attraverso archetipi manichei: c’erano i personaggi totalmente buoni e quelli totalmente cattivi, una dirittura morale precisa sullo sfondo di vicende a parabola tradizionale.
In Italia, per esempio, fioccavano i marescialli Rocca, i don Matteo, i cari maestri: il caravanserraglio dei carabinieri, dei sacerdoti, degli insegnanti, custodi di un focolare narrativo pedagogico, avvincente, ma mai disposto a rischiare nel mostrare il lato oscuro dei buoni sentimenti. Quando Hbo fece sbarcare nel nostro paese I Soprano, la tv non fu più la stessa, una lampadina si accese nella testa di sceneggiatori e spettatori. Per la prima volta, tematiche scomode come l’adulterio, le sedute psicanalitiche, gli omicidi, ma anche il rispetto delle regole e l’adeguamento a una certa morale venivano raccontate senza lesinare in passione dopata di prurigine assai realistica. I protagonisti non erano né del tutto buoni, né del tutto cattivi, lo spettatore poteva immedesimarsi nell’altro da sé contemplando pulsioni inconsce che mai avrebbe avuto il coraggio di sfoderare nella vita vera, ma che lo avrebbero solleticato nell’ora e mezza di astrazione garantita dalla visione di una puntata. Ecco che Tony Soprano, profanatore delle consuetudini politicamente corrette, mette in scena la sua vita di boss mafioso soggetto ad attacchi di panico, paziente di una psicanalista tanto arguta quarto caustica, circondato da una famiglia in cui l’intreccio conflittuale si mescola a un umorismo nero crudo, evolvendosi a ogni stagione, in una commistione di vita affettiva familiare e intrecci tra gang criminali per la contesa del territorio.
Introspezione alla Dostoevskji in salsa ultrapop, con un tocco del più frizzante Bret Easton Ellis, il tutto sullo sfondo di una pellicola come Quei Bravi ragazzi, vera ispirazione di Chase. La svolta fu epocale. Arrivarono serie come Breaking Bad, che raccontava la vicenda di un professore costretto a mantenersi spacciando droga ma per una giusta causa, o la monumentale produzione storica Roma, sempre di Hbo è prodotta da John Milius, ambientata ai tempi di Giulio Cesare, disposta a indulgere sui dettagli meno noti della vita nell’Urbe. Prodotti mai consolatori nello spiattellare il lato umano, troppo umano, dunque in chiaroscuro, del reale, calamitando il pubblico in cerca di affrancamento da tematiche didascaliche. Fino all’avvento della terza era televisiva, quella che stiamo vivendo oggi, frutto della sbornia ideologica woke americana, infarcita di progressi tecnologici, algoritmi e, naturalmente, appetiti mercatisti. Le piattaforme come Netflix hanno sostituito buona parte dei vecchi televisori e si sono adeguate ai dogmi dei campus universitari a stelle e strisce, quelli, per intenderci, che vorrebbero proibire i corsi su Aristotele perché «schiavista» e che provvedono a distribuire assorbenti pure agli studenti maschi perché sarebbe discriminatorio sostenere che le mestruazioni siano solo femminili. Ogni prodotto, pur senza una pertinenza al contesto, deve mostrare tutte le etnie residenti negli Usa, non scordando di distribuire con percentuali da manuale Cencelli la presenza di attori maschi, femmine, di personaggi che non si riconoscono in una sessualità precisa e guardandosi bene da deviare dal sentiero ideologico proposto: raccontare la realtà non per come è, ma per come talvolta qualche élite ultraliberal atlantica vorrebbe diventasse col supporto dell’artificio tecnico. La conseguenza è scontata: in questi anni, una serie come I Soprano, difficilmente sarebbe stata prodotta. Gli algoritmi delle piattaforme in streaming, pensati per accontentare la foga dei loro creatori, ne avrebbero sconsigliato persino un accenno.
Normale, in un’era in cui anche la politica sceglie di agire solo dopo aver consultato il sondaggio del momento. Come spesso accade però, la componente umana è ancora in grado di smentire dogmi disumani. Serie come Yellowstone - dramma western che non fa sconti su passioni shakespeariane nel raccontare le vicende rurali di una famiglia dell’entroterra statunitense - inanellano pubblico nonostante lo snobismo iniziale dei critici, piattaforme come quella Disney iniziano a fare marcia indietro sui loro propositi dopo aver stravolto le più celebri fiabe per bambini perché il politicamente corretto a taglio coercitivo, anche quando il contesto narrativo non lo richiede, sta facendo scappare gli abbonati. Insomma, la Sirenetta esotica, le eroine femminili trasformate a forza in virago violente, i racconti classici stravolti e infarciti di rimandi a un futuro ideologico, non funzionano come ci si aspettava e fanno perdere soldi ai produttori americani: il pubblico vuole riconoscersi nell’altro da sé vivendo emozioni autentiche, non essere rieducato a suon di metafore di costume. Anche per questo I Soprano restano la stella polare di una serialità ottimamente scritta e drenata da fascinazioni dottrinali. Come le più importanti opere narrative della storia, ancorché pop.
Il legale da film della mala del Brenta
Non bombe, ma testi di legge. Enrico Vandelli, figlio degli anni Cinquanta e di una Padova rosa dalle tensioni politiche, ha trasformato la propria militanza, il suo attivismo, nella ragione di una professione scelta con cognizione di causa. Sarebbe stato avvocato, al fianco non dei deboli ma degli assassini, dei terroristi. Vandelli, cui Sky ha voluto dedicare la miniserie Fuorilegge - Veneto a mano armata, ha scelto di laurearsi in giurisprudenza per supportare i compagni. Per difenderli. Per esserne angelo e protettore. Ma i soldi, allora, erano pochi e l’alternativa alla legalità più facile e allettante. Vandelli, che a 20 anni ha sposato la causa della formazione di sinistra extraparlamentare Autonomia operaia, è diventato così avvocato di Felice Maniero, «Faccia d’angelo». Un passaparola nel carcere di Torino: un brigatista, la sua soddisfazione di assistito e il consiglio al collega recluso. «Esiste un legale amico», avrebbe detto a Maniero, boss della Mala del Brenta, convincendolo ad assumere Vandelli. L’avvocato, cui il cosiddetto processo del 7 Aprile e la difesa di 54 fra gli imputati vicini ad Autonomia operaia avevano garantito una certa reputazione professionale, ha preso in mano la pratica e, in breve, ottenuto una scarcerazione. Ma quel che avrebbe dovuto rivelarsi un rapporto esclusivamente lavorativo si è trasformato presto in altro: un’amicizia, un sodalizio, un’affinità che ha portato il legale ad essere inghiottito dalle trame criminali di Maniero. E da questi, poi, scaricato. Una volta tornato alle proprie attività, Maniero è finito parimenti al centro di nuove indagini. Di lì a poco, gli si sono rispalancate le porte del carcere. Ed è stato un attimo. Maniero, a capo della banda che, come quella della Magliana a Roma e della Comasina a Milano, ha messo a ferro e fuoco l’Italia, fra rapine, sequestri, omicidi e traffici di droga, ha scaricato Vandelli. Lo ha accusato. Un tradimento in piena regola che, al legale, è costato la libertà. Vandelli, protagonista di una serie in onda su Sky Documentaries dalle 21.15 di sabato, si è dato alla fuga, la latitanza foraggiata da vecchi amici di Autonomia operaia. A Padova, dov’è nato e cresciuto, figlio del boom industriale, ha lasciato la moglie e i figli. Per quattro anni ha mandato loro brevi lettere, concedendosi solo di tanto in tanto incontri clandestini. Poi è stato arrestato: condannato per associazione mafiosa e costretto a lasciare la toga. Michele, suo figlio minore, nella docuserie racconta come tutto questo abbia stravolto la vita sua e della famiglia, come la parabola discendente di Enrico Vandelli - ripercorsa in tre puntate - possa essere letta oggi per (ri)raccontare un territorio, quello veneto, e la sua trasformazione socio-economica, per fotografare il sistema giuridico italiano e l’impatto che la contestazione politica ha avuto su di esso.
Continua a leggereRiduci
La saga dei mafiosi italoamericani con James Gandolfini compie un quarto di secolo però funziona ancora perché è scorretta, e quindi vera. A differenza dei prodotti streaming farciti di dogmi woke e paranoie razziali. Sky lancia una docuserie sull’avvocato Vandelli: dapprima difensore dei terroristiper ragioni ideologiche, si fece sedurre dal denaro di Maniero e della sua banda. Lo speciale contiene due articoli. «Sono il Re Mida al rovescio, tutto quello che tocco si tramuta in mer...», diceva il capomafia Tony Soprano (interpretato da James Gandolfini, rimasto nell’immaginario ancora oggi, nonostante sia morto da 10 anni), scandendo una delle tante battute che hanno reso la serie prodotta dalla Hbo uno spartiacque di tre ere televisive recenti. In questi giorni di gennaio le avventure della famiglia criminale italoamericana del New Jersey - andate in onda dal 1999 al 2007 nell’arco di sei stagioni e 86 episodi - compiono 25 anni, e sembra passato un secolo dalla prima puntata, anche perché quella libertà narrativa che ha fatto della sceneggiatura scritta da David Chase «la serie più determinante di decenni di cultura pop televisiva» (la definizione è del New York Times) è stata sacrificata sull’altare dell’algocrazia addizionata di abbondanti dosi di cultura woke e censura. Prima dell’avvento dei Soprano, la serialità televisiva era spesso raccontata attraverso archetipi manichei: c’erano i personaggi totalmente buoni e quelli totalmente cattivi, una dirittura morale precisa sullo sfondo di vicende a parabola tradizionale. In Italia, per esempio, fioccavano i marescialli Rocca, i don Matteo, i cari maestri: il caravanserraglio dei carabinieri, dei sacerdoti, degli insegnanti, custodi di un focolare narrativo pedagogico, avvincente, ma mai disposto a rischiare nel mostrare il lato oscuro dei buoni sentimenti. Quando Hbo fece sbarcare nel nostro paese I Soprano, la tv non fu più la stessa, una lampadina si accese nella testa di sceneggiatori e spettatori. Per la prima volta, tematiche scomode come l’adulterio, le sedute psicanalitiche, gli omicidi, ma anche il rispetto delle regole e l’adeguamento a una certa morale venivano raccontate senza lesinare in passione dopata di prurigine assai realistica. I protagonisti non erano né del tutto buoni, né del tutto cattivi, lo spettatore poteva immedesimarsi nell’altro da sé contemplando pulsioni inconsce che mai avrebbe avuto il coraggio di sfoderare nella vita vera, ma che lo avrebbero solleticato nell’ora e mezza di astrazione garantita dalla visione di una puntata. Ecco che Tony Soprano, profanatore delle consuetudini politicamente corrette, mette in scena la sua vita di boss mafioso soggetto ad attacchi di panico, paziente di una psicanalista tanto arguta quarto caustica, circondato da una famiglia in cui l’intreccio conflittuale si mescola a un umorismo nero crudo, evolvendosi a ogni stagione, in una commistione di vita affettiva familiare e intrecci tra gang criminali per la contesa del territorio. Introspezione alla Dostoevskji in salsa ultrapop, con un tocco del più frizzante Bret Easton Ellis, il tutto sullo sfondo di una pellicola come Quei Bravi ragazzi, vera ispirazione di Chase. La svolta fu epocale. Arrivarono serie come Breaking Bad, che raccontava la vicenda di un professore costretto a mantenersi spacciando droga ma per una giusta causa, o la monumentale produzione storica Roma, sempre di Hbo è prodotta da John Milius, ambientata ai tempi di Giulio Cesare, disposta a indulgere sui dettagli meno noti della vita nell’Urbe. Prodotti mai consolatori nello spiattellare il lato umano, troppo umano, dunque in chiaroscuro, del reale, calamitando il pubblico in cerca di affrancamento da tematiche didascaliche. Fino all’avvento della terza era televisiva, quella che stiamo vivendo oggi, frutto della sbornia ideologica woke americana, infarcita di progressi tecnologici, algoritmi e, naturalmente, appetiti mercatisti. Le piattaforme come Netflix hanno sostituito buona parte dei vecchi televisori e si sono adeguate ai dogmi dei campus universitari a stelle e strisce, quelli, per intenderci, che vorrebbero proibire i corsi su Aristotele perché «schiavista» e che provvedono a distribuire assorbenti pure agli studenti maschi perché sarebbe discriminatorio sostenere che le mestruazioni siano solo femminili. Ogni prodotto, pur senza una pertinenza al contesto, deve mostrare tutte le etnie residenti negli Usa, non scordando di distribuire con percentuali da manuale Cencelli la presenza di attori maschi, femmine, di personaggi che non si riconoscono in una sessualità precisa e guardandosi bene da deviare dal sentiero ideologico proposto: raccontare la realtà non per come è, ma per come talvolta qualche élite ultraliberal atlantica vorrebbe diventasse col supporto dell’artificio tecnico. La conseguenza è scontata: in questi anni, una serie come I Soprano, difficilmente sarebbe stata prodotta. Gli algoritmi delle piattaforme in streaming, pensati per accontentare la foga dei loro creatori, ne avrebbero sconsigliato persino un accenno. Normale, in un’era in cui anche la politica sceglie di agire solo dopo aver consultato il sondaggio del momento. Come spesso accade però, la componente umana è ancora in grado di smentire dogmi disumani. Serie come Yellowstone - dramma western che non fa sconti su passioni shakespeariane nel raccontare le vicende rurali di una famiglia dell’entroterra statunitense - inanellano pubblico nonostante lo snobismo iniziale dei critici, piattaforme come quella Disney iniziano a fare marcia indietro sui loro propositi dopo aver stravolto le più celebri fiabe per bambini perché il politicamente corretto a taglio coercitivo, anche quando il contesto narrativo non lo richiede, sta facendo scappare gli abbonati. Insomma, la Sirenetta esotica, le eroine femminili trasformate a forza in virago violente, i racconti classici stravolti e infarciti di rimandi a un futuro ideologico, non funzionano come ci si aspettava e fanno perdere soldi ai produttori americani: il pubblico vuole riconoscersi nell’altro da sé vivendo emozioni autentiche, non essere rieducato a suon di metafore di costume. Anche per questo I Soprano restano la stella polare di una serialità ottimamente scritta e drenata da fascinazioni dottrinali. Come le più importanti opere narrative della storia, ancorché pop.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/meglio-soprano-che-favole-buoniste-2666931963.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="il-legale-da-film-della-mala-del-brenta" data-post-id="2666931963" data-published-at="1704991059" data-use-pagination="False"> Il legale da film della mala del Brenta Non bombe, ma testi di legge. Enrico Vandelli, figlio degli anni Cinquanta e di una Padova rosa dalle tensioni politiche, ha trasformato la propria militanza, il suo attivismo, nella ragione di una professione scelta con cognizione di causa. Sarebbe stato avvocato, al fianco non dei deboli ma degli assassini, dei terroristi. Vandelli, cui Sky ha voluto dedicare la miniserie Fuorilegge - Veneto a mano armata, ha scelto di laurearsi in giurisprudenza per supportare i compagni. Per difenderli. Per esserne angelo e protettore. Ma i soldi, allora, erano pochi e l’alternativa alla legalità più facile e allettante. Vandelli, che a 20 anni ha sposato la causa della formazione di sinistra extraparlamentare Autonomia operaia, è diventato così avvocato di Felice Maniero, «Faccia d’angelo». Un passaparola nel carcere di Torino: un brigatista, la sua soddisfazione di assistito e il consiglio al collega recluso. «Esiste un legale amico», avrebbe detto a Maniero, boss della Mala del Brenta, convincendolo ad assumere Vandelli. L’avvocato, cui il cosiddetto processo del 7 Aprile e la difesa di 54 fra gli imputati vicini ad Autonomia operaia avevano garantito una certa reputazione professionale, ha preso in mano la pratica e, in breve, ottenuto una scarcerazione. Ma quel che avrebbe dovuto rivelarsi un rapporto esclusivamente lavorativo si è trasformato presto in altro: un’amicizia, un sodalizio, un’affinità che ha portato il legale ad essere inghiottito dalle trame criminali di Maniero. E da questi, poi, scaricato. Una volta tornato alle proprie attività, Maniero è finito parimenti al centro di nuove indagini. Di lì a poco, gli si sono rispalancate le porte del carcere. Ed è stato un attimo. Maniero, a capo della banda che, come quella della Magliana a Roma e della Comasina a Milano, ha messo a ferro e fuoco l’Italia, fra rapine, sequestri, omicidi e traffici di droga, ha scaricato Vandelli. Lo ha accusato. Un tradimento in piena regola che, al legale, è costato la libertà. Vandelli, protagonista di una serie in onda su Sky Documentaries dalle 21.15 di sabato, si è dato alla fuga, la latitanza foraggiata da vecchi amici di Autonomia operaia. A Padova, dov’è nato e cresciuto, figlio del boom industriale, ha lasciato la moglie e i figli. Per quattro anni ha mandato loro brevi lettere, concedendosi solo di tanto in tanto incontri clandestini. Poi è stato arrestato: condannato per associazione mafiosa e costretto a lasciare la toga. Michele, suo figlio minore, nella docuserie racconta come tutto questo abbia stravolto la vita sua e della famiglia, come la parabola discendente di Enrico Vandelli - ripercorsa in tre puntate - possa essere letta oggi per (ri)raccontare un territorio, quello veneto, e la sua trasformazione socio-economica, per fotografare il sistema giuridico italiano e l’impatto che la contestazione politica ha avuto su di esso.
Elly Schelin (Ansa)
Certo, a trarre in fallo gli eredi di Palmiro Togliatti (il Guardasigilli che ha concesso l’amnistia ai veri fascisti) potrebbe essere stata anche la Procura barese che in un eccesso di enfasi, durante il processo, ha fatto trasmettere in aula filmati del Ventennio realizzati dall’Istituto Luce.
E, per rendere più suggestivo il tutto, nel procedimento si è costituita come parte civile l’Associazione nazionale partigiani.
I pm avevano chiesto il rinvio a giudizio e la condanna di 17 persone per gli articoli 1 e 5 della legge Scelba del 1952 (aggiornata dalla legge Reale del 1975) «per aver partecipato a pubbliche riunioni, compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per avere attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica». Ma, già nel capo di imputazione, non è contestata la ricostituzione.
Anche perché l’articolo 1 della legge non è una norma sanzionatoria, ma descrive in generale quali comportamenti debbano tenere associazioni e movimenti per essere accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista (minaccia alle libertà e alla democrazia, propaganda razzista, uso della violenza quale metodo di lotta politica, ecc.).
Il secondo articolo della legge prevede che per promotori, organizzatori o dirigenti la pena oscilla dai 5 ai 12 anni, mentre per i semplici partecipanti dai 2 ai 5.
L’articolo 5, quello per cui sono arrivate le condanne, punisce, invece, «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione fino a 3 anni». Il giudice, anche in questo caso, «può disporre la privazione dei diritti» politici «per un periodo di 5 anni». Come in effetti ha deciso il collegio presieduto dal giudice Ambrogio Marrone.
Insomma, se gli imputati fossero stati accusati di aver ricostituito il partito fascista, di esserne dirigenti o anche di farne semplicemente parte avrebbero subito una condanna ben più grave di quella che gli è toccata.
Invece i cinque militanti accusati per l’articolo 5 della legge Scelba hanno subito una pena a 1 anno e 6 mesi. I sette soggetti che, invece, sono stati condannati anche per le lesioni procurate ad alcuni militanti antifascisti (che si erano riuniti per manifestare contro la presenza di Matteo Salvini a Bari) hanno accumulato 2 anni e 6 mesi di reclusione. Condanne che, come detto, non collimano con le sanzioni previste per fondatori e membri di un rinato partito fascista.
L’avvocato Saverio Ingraffia ha diramato un comunicato che avrebbe evitato figuracce ai più volenterosi, in cui segnalava «con forza» che «nessuno degli odierni imputati è mai stato processato e, di conseguenza, condannato per il delitto di ricostituzione del partito fascista».
Il legale ha ricordato che la norma per cui gli imputati sono stati condannati «vieta gesti, saluti (come quello romano) o simboli riconducibili al fascismo o al nazismo».
L’entità della punizione avrebbe dovuto mettere in guardia coloro che hanno subito denunciato la ricostituzione del partito fascista.
Per esempio Elly Schlein ha subito definito quella di Bari una «sentenza molto importante», che «per la prima volta» stabilisce «che CasaPound ha tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista, violando la Costituzione e la legge Scelba. Ora c’è una sentenza che lo stabilisce, al governo non resta che fare quello che gli chiediamo da tempo: sciogliere CasaPound». Le ha fatto eco Laura Boldrini, la quale ha chiesto l’immediato intervento del ministro dell’Interno. Hanno invocato la chiusura dell’associazione anche altri leader del centrosinistra come il dem pugliese Francesco Boccia, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (che ha definito Casapound «un’organizzazione neofascista e violenta, non un centro culturale»).
Il Tribunale ha riconosciuto che alcuni degli imputati non erano certo delle educande, ma picchiatori. Il 21 settembre 2018 ci fu un’aggressione che ha portato al ferimento di quattro persone (le lesioni sono state giudicate guaribili da 7 a 15 giorni). La ricostruzione degli avvenimenti è contenuta in un’informativa della Digos. Gli investigatori parlano di «una azione violenta» o, meglio, di «una vera e propria aggressione» compiuta da militanti di CasaPound ai danni di partecipanti alla manifestazione «Mai con Salvini». Le immagini delle telecamere mostrano gli imputati che, dopo essere partiti da una sede di CasaPound, raggiungono il corteo e aggrediscono i manifestanti. Al grido di «antifascisti di merda» sono partiti i pestaggi, per cui sono stati usati sfollagente, manubri da palestra, manganelli telescopici e cinture dei pantaloni. Gli investigatori ricostruiscono poi una seconda fase, scattata «mentre i militanti si accingevano a rientrare alla base»: vedendo giungere un altro gruppo di manifestanti sarebbe partita un’altra aggressione. Ma c’è anche un terzo episodio, nei confronti di una persona che non è stata riconosciuta e che non ha presentato denuncia. Tutti e tre gli episodi, accaduti in momenti ravvicinati, secondo gli inquirenti, sarebbero riconducibili alla «medesima azione criminosa» e, a giudizio della Procura, all’«ideologia fascista».
Per i pm, l’aggressione sarebbe stata organizzata «in periodo precedente alla manifestazione con raccolta di armi e organizzazione di uomini», da qui la contestazione della premeditazione. Il Tribunale ha, invece, escluso questa aggravante.
Continua a leggereRiduci
Michele Emiliano (Ansa)
Da Decaro, infatti, è arrivata una raffica di no alle richieste do ricoprire un posto come consigliere regionale o, addirittura, di avere uno strapuntino nella nuova giunta. Un miraggio, il ruolo di assessore, fatto balenare da Elly Schlein in campagna elettorale e poi spazzato via dall’ottima performance nelle urne di Decaro che così, forte dei voti ottenuti, ha avuto vita facile a far naufragare l’ingresso di Emiliano nella propria squadra di governo.
Al magistrato in aspettativa, però, un posto serviva, altrimenti sarebbe tornato a lavorare con leggi e codici. Da qui l’ideona del «consulente giuridico», in attesa della ventilata candidatura alle prossime elezioni nazionali. Caso risolto? Non proprio, perché la parola finale, infatti, spettava al Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, doveva esprimersi su una questione dirimente: se fare il «consulente giuridico» del presidente Decaro sia un incarico abbastanza importante per prolungare l’aspettativa. E qui, per Emiliano, iniziano i guai perché trovata la quadra politica, arriva il cuneo dei suoi ex colleghi che se la sono presa comoda. Secondo quanto racconta Repubblica, infatti, il Csm, per non alimentare il clima di scontro nelle ultime settimane di campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, avrebbe stabilito di mettere in stand by le pratiche di quei colleghi magistrati che preferirebbero continuare a occuparsi, o iniziare a occuparsi, di politica. Tra questi incartamenti messi da parte ci sarebbe anche il faldone di Emiliano.
Il problema dell’ex governatore si chiama legge Cartabia, che ha ridotto da 200 a 180 il numero di giudici e pm che possono andare «fuori ruolo», «portando ad appena 40 quelli che possono essere assegnati a istituzioni diverse dai ministeri della Giustizia e degli Esteri, dal Csm e dagli organi costituzionali», spiega Repubblica. La finestra per non indossare la toga si è ridotta, dunque, e quei posti sono stati già quasi tutti occupati. O, comunque, lo saranno non appena il Csm tornerà a vagliare le richieste avanzate dai colleghi per prima dell’alto papavero del Pd. Ed Emiliano, che farà? Il rischio, che pare concretissimo oggi, è che il debba rinunciare al tanto sudato contrattino da consigliere giuridico e che possa essere costretto addirittura a lasciare la sua Regione (dove non può esercitare) per trasferirsi in un’altra. Quello che è sicuro è che Emiliano sia appeso a doppio filo alle decisioni dei suoi ex colleghi. Oltre allo strapuntino da 130.000, scrive Repubblica che «l’ex presidente è ancora in attesa di capire cosa deciderà il Consiglio giudiziario di Roma in merito alla sua richiesta di ottenere la settima valutazione di professionalità, che gli consentirebbe di saltare a pie’ pari i 22 anni in cui è stato fuori ruolo e andare in pensione con il massimo livello». Inoltre, Emiliano è costretto a tifare pure il governo Meloni visto che, secondo quanto sostengono in molti, l’esecutivo potrebbe riformare la parte della legge Cartabia che ha portato a 180 il numero dei magistrati «fuori posto», rialzandolo a 200. Una boccata d’ossigeno che farebbe bene alle tasche di Emiliano.
Continua a leggereRiduci
Ansa
A quanto si è appreso, il gip avrebbe scritto nell’ordinanza che permane l’esigenza di tenere l’impianto sotto sequestro per svolgere ulteriori accertamenti sulle cause dell’incendio verificatosi lo scorso 7 maggio. Lunedì, in udienza, il pm Mariano Buccoliero aveva sostenuto che il mantenimento del sequestro era finalizzato a ulteriori accertamenti sull’impianto chiesti dai consulenti della Procura verso la fine del 2025. Ma il legale dell’azienda aveva osservato che gli accertamenti ulteriori erano già stati prefigurati a luglio, ma furono allora scartati poiché ritenuti non necessari dalla consulente incaricata dalla Procura. Questi nuovi accertamenti, ha argomentato in udienza il legale di Adi, si potevano fare mesi fa e nessuno allora avrebbe mosso particolari obiezioni, mentre farli ora non solo mantiene il sequestro probatorio, ma contrasta soprattutto con gli orientamenti della Corte di Cassazione per la quale questa tipologia di sequestro deve avere tempi stretti. Adesso l’azienda impugnerà il no al dissequestro in Cassazione. E comunque anche se l’altoforno 1 fosse stato dissequestrato, non sarebbe ripartito subito poiché sarebbero stati necessari almeno otto mesi per il suo ripristino.
Ma vediamo che impatto avrà lo stop dei giudici. Lo Stato ha investito dal 7 maggio 2025 al 12 febbraio 2026, circa 1,2 miliardi per il ripristino delle attività dopo l’incidente occorso alla tubiera 11 dell’altoforno 1, a maggio 2025, che ha causato la fuoriuscita di materiale incandescente. Le attività di verifica e ripristino dell’impianto sono iniziate subito ma il sequestro dell’impianto ha impedito di procedere. Inoltre non ha consentito lo svuotamento del suo contenuto e il risultato è stato la solidificazione dell’acciaio presente al suo interno. Ciò comporterà una manutenzione pesante. Questo tipo di attività si sarebbe potuta evitare se la Procura, come chiesto sin da subito dai commissari, avesse consentito il colaggio dei fusi. La durata di queste attività di manutenzione straordinaria si può stimare in circa 9 mesi che rappresentano un ulteriore intervallo di non produzione. Ora lo stop dei giudici costerà quasi 2,5 miliardi che sarebbe il danno qualora il sequestro fosse accaduto oggi. Ogni altro giorno di ritardo costa all’ex Ilva e allo Stato qualcosa come 4,5 milioni di euro al giorno in più tra mancato fatturato e costo della cassa integrazione. Il sequestro disposto dalla Procura sarebbe dovuto solo servire a ricostruire la dinamica dei fatti. Ma dopo ben 282 giorni, gli accertamenti non sono ancora conclusi.
Questi ritardi impattano anche sui lavoratori che erano impiegati a valle dell’altoforno 1, gli stabilimenti del Nord, che per la minor produzione di Taranto, hanno visto una diminuzione delle ore lavorate. Ma anche le aziende italiane che acquistavano dall’Ilva, hanno dovuto acquistare all’estero l’acciaio primario anche pagandolo di più. Risultato: il ritardo della Procura costa più del doppio di quanto lo Stato ha investito per tenere in piedi l’azienda e sistemare i danni lasciati dalla precedente gestione Arcelor Mittal.
Continua a leggereRiduci
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 13 febbraio con Carlo Cambi