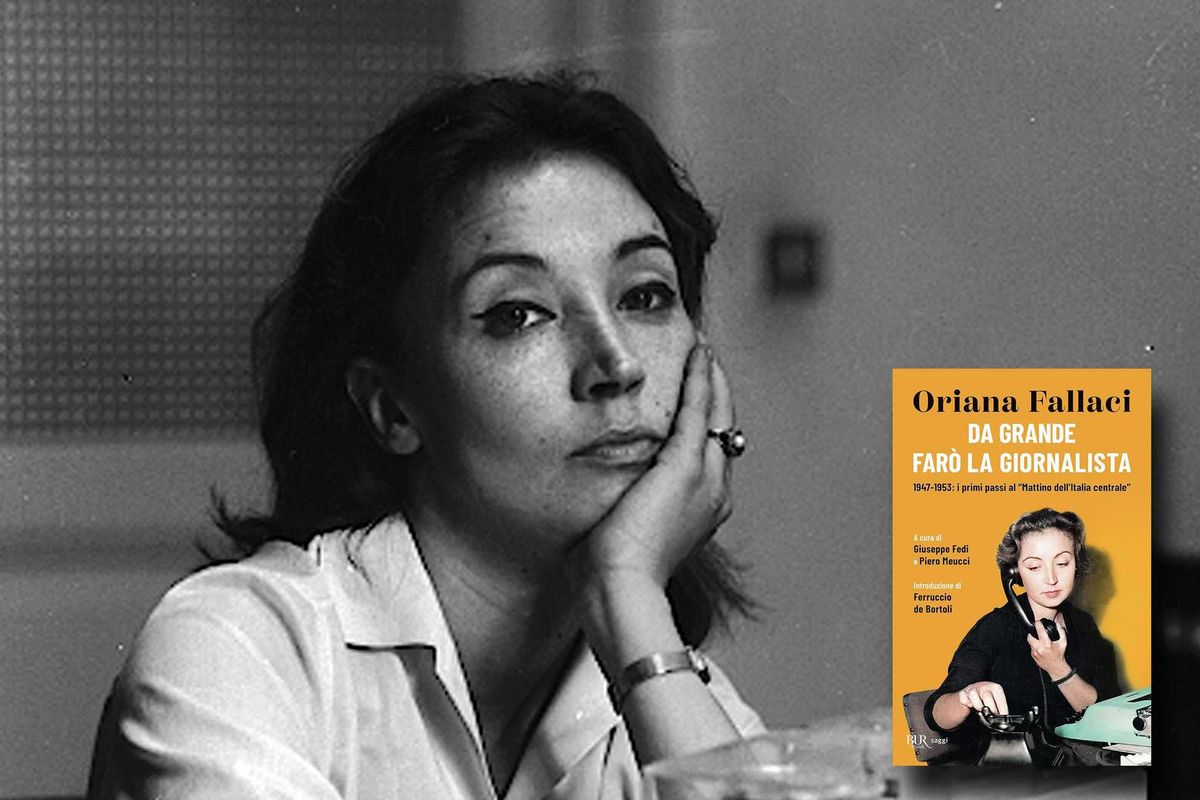Riccardo Cotarella è un enologo di fama internazionale. Nato a Monterubiaglio (Terni), nel 1948, diplomato nella prestigiosa scuola di Conegliano Veneto, produttore a Montecchio (Terni) e consulente di un nutrito portfolio di aziende vitivinicole, presiede l'Associazione degli enologi italiani e l'Union international des oenologues.
Nella scala delle espressioni della bellezza e della civiltà, il vino occupa un gradino assai alto, specialmente in Italia, che ne è il primo produttore mondiale. Dispensa piacevolezza e delizia ma, in caso di sregolatezza, riserva negatività e talvolta inferni. Come si beve il vino per elevare lo spirito e, di conseguenza, la civiltà?
«Il vino è grande espressione di civiltà, forte di una storia millenaria che pochi altri prodotti possono vantare, ma che non lo mette al riparo da luoghi comuni. Basti pensare all'abusata espressione in vino veritas. Esso dovrebbe rivelare verità nascoste, tanto da essere utilizzato dai re, come ricorda Orazio, quale strumento di verifica della sincerità degli ausiliari. Ma ciò si contraddice con il fatto che l'eccesso di vino può creare realtà fittizie. Preferisco la riflessione di Erasmo da Rotterdam, per il quale la verità si contrappone non solo alla menzogna, ma anche alla simulazione. Dobbiamo pertanto distinguere l'ebbrezza sfrenata, che generalmente falsifica la corretta visione della realtà, dalla moderata euforia, che scioglie simulazione e ipocrisia. Insomma, il vino va gestito, come ogni altra preziosa risorsa della civiltà. Lo sapevano bene Greci, Etruschi e Romani. Nessun poeta, condottiero o storico ha mai esaltato gli eccessi del vino, enfatizzandone piuttosto l'insuperabile magia delle emozioni».
Essendo il mondo del vino d'inesauribile complessità, chi vi si accosta con la curiosità della conoscenza, esperisce un senso di disorientamento. In Italia sono attive 310.428 aziende che coltivano vigne e 47.400 che vinificano (dati Vinitaly 2018). Andando alle etichette, i numeri si moltiplicano. Gianni Brera scriveva: «Scopri che cambiar vino non è un pericolo, bensì una necessità se non proprio un dovere». Per chi vuole iniziare o affinare questa avventura, come procedere in maniera saggia?
«Ritengo sia sempre opportuno partire dal proprio territorio. Che senso avrebbe per un toscano scoprire il Barolo, se non conosce il Brunello? Dicendo ciò, non intendo porre limiti alla legittima curiosità di gustare un vino del quale conosciamo solo il nome, ma propongo un percorso di crescita graduale, meditato e strutturato. Un viaggio e un soggiorno possono essere opportunità di apprendimento o approfondimento. Ma iniziamo dalla nostra realtà, lasciamoci coinvolgere dalla storia - e dalle storie - del nostro territorio, dalle origini dei nostri vigneti, dalle varietà degli uvaggi, dalla tipologia del terreno, dai caratteri climatici. La cultura del vino non si acquisisce soltanto con le degustazioni. È invece risultato di un'esperienza che va vissuta con metodo e intelligenza».
Anche nel panorama enologico, i meccanismi della notorietà, finiscono per oscurare tipicità poco conosciute, di cui la geografia nazionale è ricca, in ogni suo angolo. Non esistono solo le osannate eccellenze ma anche un profluvio di altre creazioni che sorprendono. Solo per fare alcuni esempi estratti da un campionario sconfinato, il Fortana del Bosco Eliceo Doc, l'Ormeasco di Pornassio Doc, il Durello della Lessinia Doc e il Cacc'e Mmitte di Lucera Doc, pur esibendo una precisa identità territoriale e bottiglie di apprezzabile qualità, sono quasi sconosciuti al pubblico di massa. Secondo lei, nella platea dei futuri degustatori, ci sarà maggior spazio per la scoperta di bottiglie non illuminate dai riflettori?
«È evidente che la molteplicità di aziende sparse nella penisola, danno vita a una serie di vini che non godono - e non potrebbero godere - della medesima gloria. Ciò non significa, tuttavia, che siano o vadano ignorati, anche perché sono espressione di tradizioni territoriali, miti e riti, che accompagnano la vita dei campi e delle cantine. Aggiungo che, sul piano della qualità - e anche dell'identità - questi vini non hanno molto da invidiare ai più celebri cru. E vanno scoperti. Sono convinto che le nuove generazioni sapranno essere più attente nei confronti dei vini delle loro terre».
Un'altra metafora di Gianni Brera appare molto attuale: «Quando la tecnica di vinificazione è eccessiva, hai l'impressione di baciare una donna troppo truccata: sempre donna è, ma andrebbe meglio al naturale».
«Questa di Brera è un'immagine suggestiva. Certo, ogni eccesso - in qualsiasi campo - finisce per alterare l'originaria natura del prodotto. Ma non esiste una regola generale. Ogni uva ha una storia a sé, e richiede interventi e tempi non estensibili. Per ogni enologo, questa è una verità scontata».
Anche per un modesto intenditore di vini è fonte di non indifferente piacere stappare una bottiglia da invecchiamento e coglierne, dopo dieci, venti anni, un'intatta fragranza, una matura freschezza che inevitabilmente fanno sognare. Questa possibilità, come noto, è legata soprattutto ai rossi. L'esperienza con i bianchi è diversa.
«La ricerca e l'applicazione della scienza in vigna e in cantina hanno permesso di individuare vitigni e territori di generare uve in grado di produrre anche vini bianchi che esaltano le proprie caratteristiche dopo un invecchiamento di vari anni. È un problema di uve, di tecnica e di tempi. E, soprattutto, di tanta cura e tanto mestiere».
Da cosa dipende la longevità di un vino?
«Soprattutto da due fattori, ossia la stagione, che deve essere equilibrata al punto giusto per consentire la produzione di uve sane e integre, e la varietà dell'uva, per garantire al vino un ottimale contenuto quanti-qualitativo di tannini, i quali costituiscono il baluardo più importante contro l'ossidazione e un precoce invecchiamento dei vini. L'elemento più importante, tuttavia, è la professionalità dell'enologo».
Nel 2010 sono state rinvenute, sui fondali del mar Baltico, a 55 metri di profondità, davanti alle coste della Finlandia, nel relitto di una nave affondata, 168 bottiglie di champagne a marchio Veuve Clicquot, Heidsieck e Juglar, databili attorno al 1830, che i test del biochimico Philippe Jeandet e di un team di enologi, hanno giudicato «perfettamente conservati, sia dal punto di vista della composizione chimica sia dell'aroma», «freschi e fruttati». Come è possibile che dopo 180 anni un vino mantenga in modo così straordinariamente invariato la sua conservazione?
«Pur non avendo avuto l'opportunità e il piacere di assaggiare quelle bottiglie e fidandomi del giudizio altrui, la cosa, anche se non comune, non mi sorprende affatto soprattutto quando si parla di champagne-spumante, prodotti il cui alto contenuto di anidride carbonica derivato dalla rifermentazione in bottiglia è un ottimo antidoto al deperimento della qualità nel tempo».
Ci indica i tre migliori vini stranieri che ha ultimamente degustato?
«Romanee-Conti Echezeaux, Fay di Stag's Leap Wine Cellars, Coche-Dury Meursault Les Rougeots».
E l'abbinamento gastronomico che le ha elargito maggior gratificazione?
«Un Nerello Mascalese dell'Etna con un cosciotto d'agnello cresciuto allo stato brado e alimentato con l'erba del vulcano».
Cosa si perde un astemio?
«D'Annunzio si dichiarava astemio, ma non era insensibile alle virtù del vino, tanto da tessere le lodi della Vernaccia di Corniglia e del Nepente di Oliena, in un celeberrimo «itinerario bacchico» scritto per il Corriere della Sera. E Leonardo giunse a sostenere che gli uomini nati dove si trovano vini buoni sono molto felici. Probabilmente l'astemio si perde un pezzo di felicità, rinunciando a uno dei piaceri più vivi, coinvolgenti e sensuali che accompagnano un buon calice».