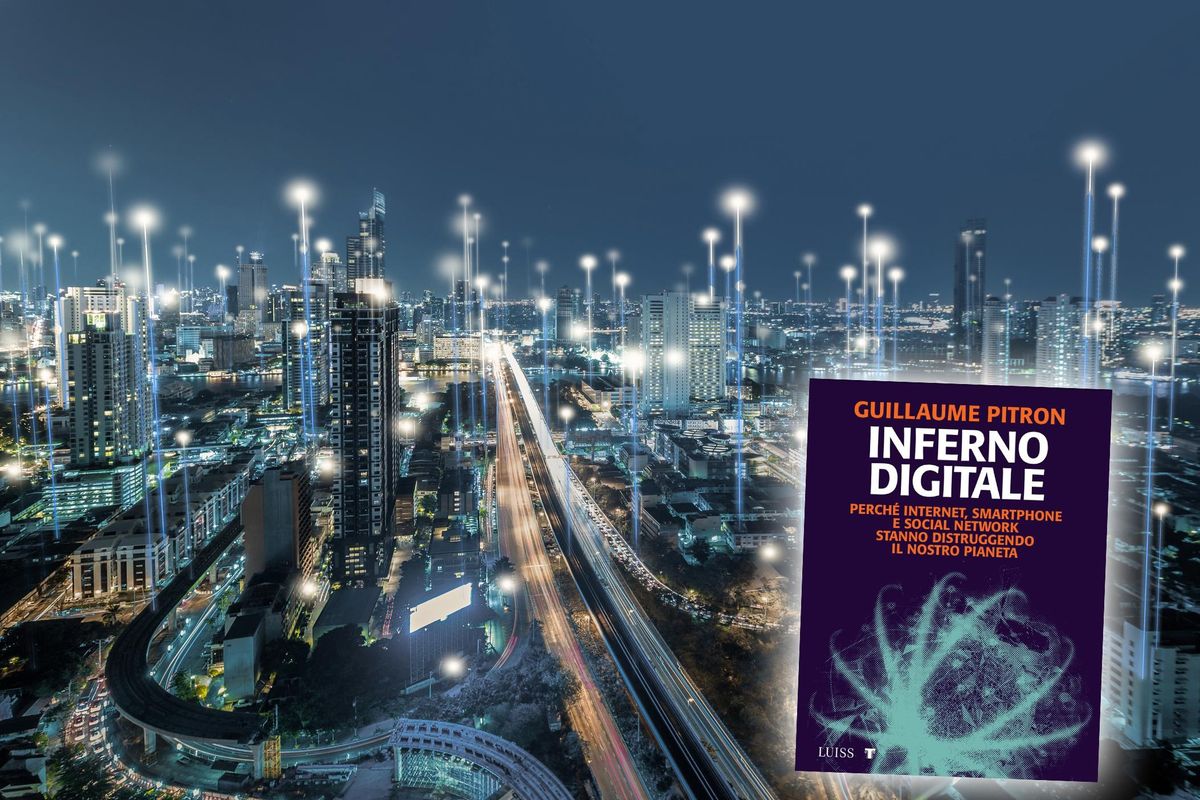2023-01-18
L’Ue mette nel mirino le nostre abitazioni. Però poi se ne frega dell’impatto digitale
Un’inchiesta di Pitron smonta la favola della rivoluzione tech a basse emissioni: «Il settore incide già il triplo della Francia». Il grottesco paradosso è perfettamente riassunto da una dichiarazione rilasciata al pluripremiato giornalista d’inchiesta francese Guillaume Pitron da una consigliera parlamentare europea: «Il Green deal (una tabella di marcia per un’Europa più sostenibile presentata nel 2019 dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen) si basa sull’idea che le tecnologie risolveranno la situazione. L’inquinamento digitale sembra essere l’ultima delle preoccupazioni delle istituzioni di Bruxelles». Il punto è tutto qui. Come abbiamo ampiamente raccontato nei mesi scorsi, è soprattutto per via della svolta «green» europea che impone di rinunciare ai combustibili fossili se il prezzo di questi ultimi è aumentato notevolmente già dal 2021. E mentre le popolazioni europee - quella italiana in particolare - pagano il prezzo dell’ideologia presunta ecologista, ecco che da Bruxelles arrivano nuove e deliranti indicazioni: si vuole che entro il 2030 tutti gli immobili residenziali entrino nella classe energetica E, e in quella D entro il 2033. Un intervento che, tra cappotti termici e pannelli solari, potrebbe comportare un costo complessivo di quasi 1.400 miliardi. Stando ai dati dell’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, in Italia su 12,2 milioni di strutture residenziali circa 9 milioni dovrebbero essere messe a norma, e in molti casi non è detto che sia possibile.Questo colossale intervento - i cui dettagli sono ancora da discutere - viene giustificato con la scusa dell’impatto ambientale. Il mantra è sempre quello: ridurre le emissioni, ridurre i consumi. Ed è qui che si arriva al tema dell’inquinamento digitale sollevato da Pitron. La grande domanda è: perché, se davvero si vuole proteggere la natura, si spinge per una potentissima azione sulle case - a costo di danneggiare brutalmente le fasce più deboli della popolazione - ma nessuno parla mai dell’impatto della cosiddetta «rivoluzione digitale», anzi svolta verde e nuova era informatica sono spesso sinonimi?Secondo i dati raccolti da Guillaume Pitron e riportati nel bellissimo libro inchiesta Inferno digitale (Luiss), «i numeri sono eloquenti: l’industria digitale mondiale consuma così tanti materiali, acqua ed energia da rendere la sua impronta ecologica tre volte quella di un Paese come la Francia o l’Inghilterra. Le tecnologie digitali consumano oggi il 10% dell’elettricità prodotta al mondo e producono quasi il 4% delle emissioni globali di CO2, ovvero poco meno del doppio dell’aviazione civile mondiale».Sono dati molto interessanti, a cui un ambientalista serio dovrebbe fare riferimento prima di impegnarsi in una battaglia ideologica. Purtroppo, soltanto in pochi sembrano tenerne conto. E fra questi pochi non ci sono le istituzioni europee. Le quali, ad esempio, insistono molto sulla necessità di trasformare le capitali del continente in smart city, anche se sull’impatto ambientale di queste ultime esistono pochissimi studi. Il primo è stato pubblicato nel 2019, e non è entusiasmante: la ricercatrice danese Kikki Lambrecht Ipsen e i suoi colleghi hanno chiarito che «lo sviluppo di soluzioni per le smart city produce, in linea di massima, un’influenza negativa sulle performance ambientali di un sistema urbano». Chiaro: con lo sviluppo tecnologico la situazione potrebbe migliorare, ma intanto questi sono gli effetti dell’ossessione digitale. E il quadro decisamente non migliora quando si vanno a esaminare le conseguenze dell’utilizzo massivo di computer e smartphone: per tenerli in attività costante serve un consumo di elettricità spaventoso. Senza contare l’impiego di energia necessario per mandare avanti i centri di raccolta dei dati e l’intera infrastruttura - molto reale e poco eterea - che sorregge il funzionamento dell’intera industria online.Sul tema dovrebbero ragionare a fondo i giovani e bellicosi ecologisti che si propongono come «eco guerrieri» pur mostrandosi ben felici di utilizzare il cellulare. Ecco che cosa scrive Pitron a questo proposito: «Uno studio inglese ha confermato che i nativi digitali saranno in futuro i primi a usare i nuovi servizi e i dispositivi proposti dalle grandi aziende del settore digitale. La “generazione clima” sarà uno dei principali attori del raddoppiamento, previsto per il 2025, del consumo di elettricità da parte del settore digitale (20% della produzione mondiale) e delle emissioni di gas a effetto serra (7,5% delle emissioni totali)». Quindi se davvero gli eco guerrieri volessero essere coerenti con la logica che amano brandire dovrebbe cospargere di vernice sé stessi e i coetanei.In ogni caso, il nodo principale è quello riguardante le istituzioni europee. Qui abbiamo riportato soltanto alcuni piccoli esempi e dati fra i tantissimi offerti da Guillaume Pitron, che sono però sufficienti a chiarire come l’inquinamento digitale sia un problema di enorme importanza, destinato per altro ad allargarsi. Domandiamo di nuovo: perché si impongono interventi brutali come quello sulle abitazioni e allo stesso tempo si sostiene la digitalizzazione totale, altamente inquinante e problematica? La risposta, al solito, è abbastanza scontata. Agire sulle case significa scaricare i costi del cambiamento di stile di vita sui singoli Stati e soprattutto sulla popolazione, specie sulle fasce più fragili. Porre un argine ai sistemi digitali significherebbe invece opporsi agli interessi di Big tech. Prendersela con gli edifici residenziali vuol dire, in sostanza, restare saldamente all’interno dei confini ideologici neoliberisti. Non è un caso che, già nel 2020, l’Economist si scagliasse contro i proprietari di case: «Un’élite di proprietari», scriveva la bibbia dei liberal, impedisce «la costruzione di grattacieli e appartamenti che l’economia moderna richiede». Se non ci fossero proprietari ma solo affittuari, proseguiva il settimanale, sarebbero facilitate le migrazioni interne agli Stati e, soprattutto, sarebbe più facile abbattere le case vecchie per sostituirle con quelle nuove «ecosostenibili», ovviamente da vendere a caro prezzo.L’obiettivo, a ben vedere, è sempre il medesimo: dovete cambiare stile di vita e impoverirvi perché altri possano beneficiarne; a voi le emissioni ridotte, agli altri i profitti aumentati.
Sanae Takaichi (Ansa)
Sta salendo la tensione tra Tokyo e Pechino. Al centro della turbolenza è emerso soprattutto un dossier: la questione di Taiwan.
content.jwplatform.com
La barca ormeggiata a Nisida è solo l’ultima incoerenza dell’aspirante governatore campano
(Totaleu)
Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura durante il Consiglio Ue Agrifish in corso a Bruxelles.