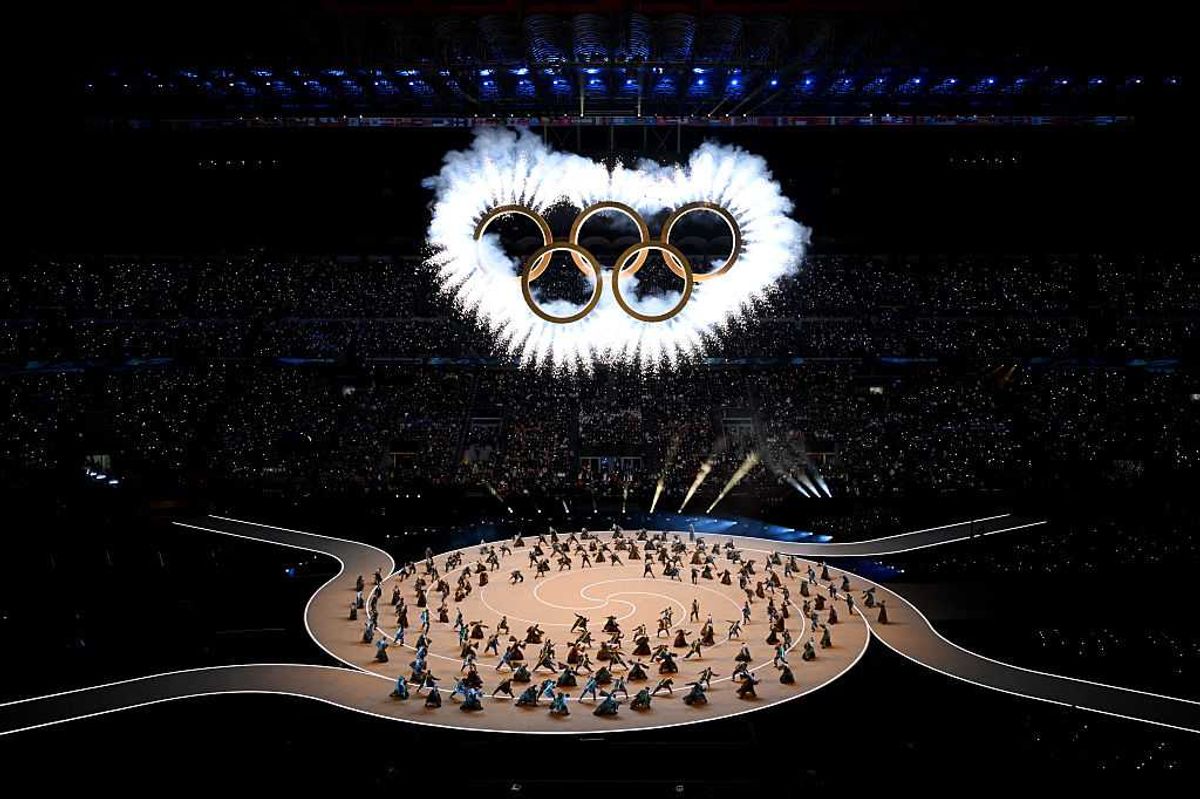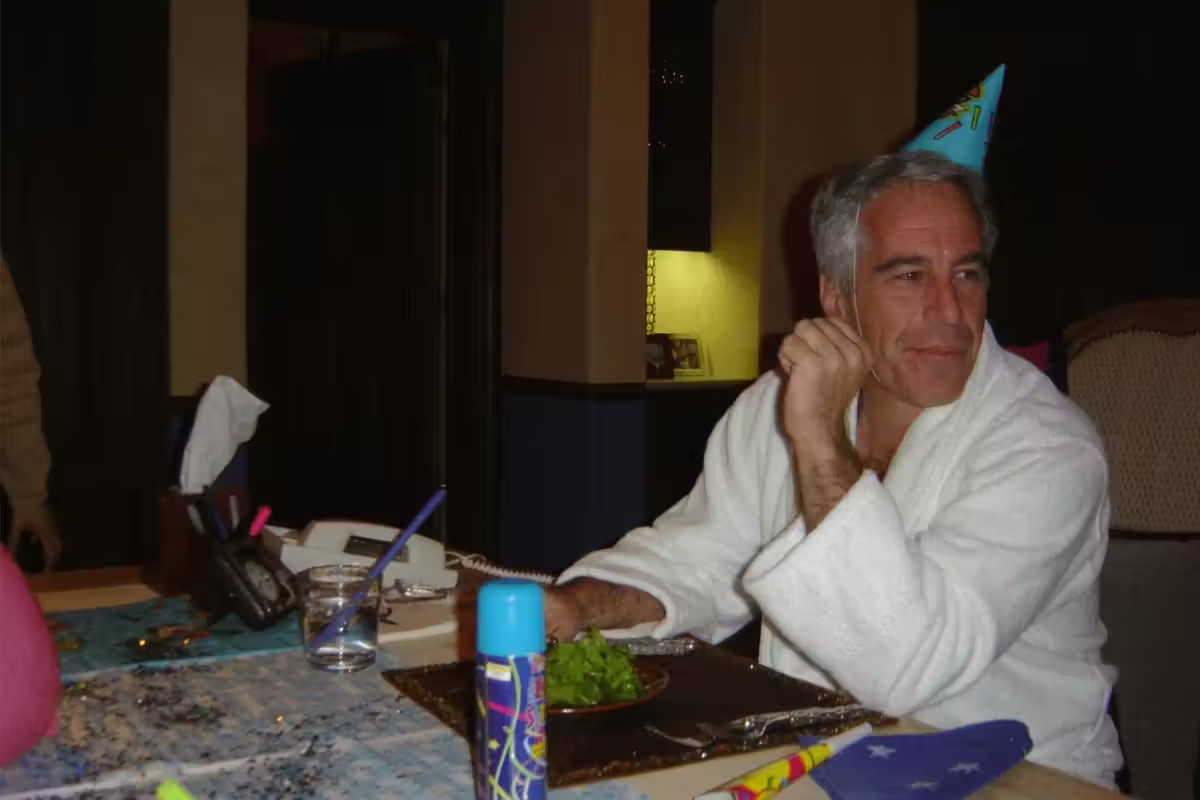Il referendum contro il green pass scelta morale per fare la cosa giusta

Di questi tempi è in corso un'iniziativa per indire un referendum abrogativo delle leggi e dei decreti legge relativi alla certificazione verde, generalmente nota come green pass. È anche in corso un vigoroso dibattito sul tema, soprattutto fra persone che sono contrarie al green pass ma esprimono perplessità o anche opposizione nei confronti del referendum. A queste persone, che considero compagni di strada e di lotta, vorrei offrire il mio parere e, come è mia abitudine (chi mi segue lo avrà capito), nell'esporlo partirò da lontano.
Quella di indire un referendum sul green pass, ed eventualmente votare per esso, è una scelta morale; dunque, per evitare di parlare senza capirsi, è opportuno innanzitutto chiarire quali siano i parametri che orientano, per ciascuno di noi, simili scelte. Nella tradizione esistono due tipi fondamentali di teorie morali, o etiche (userò i due termini in modo intercambiabile). Il primo prende il nome di teleologico, dalla parola greca «télos» che significa fine, e lo prende perché queste teorie partono identificando un fine ultimo, dell'umanità o anche dell'universo, e stabiliscono poi che in una data circostanza la scelta giusta sia quella che, meglio di tutte le alternative disponibili, ci approssima al fine ultimo. È teleologica l'etica aristotelica, per la quale il fine ultimo degli esseri umani è l'eudaimonía (variamente tradotta come felicità, fioritura o benessere) e che per Aristotele consiste nel piacere associato alla contemplazione delle verità eterne. Ed è teleologica la dottrina che domina la riflessione contemporanea, non solo in filosofia ma anche in politica, in economia e nelle scienze sociali: l'utilitarismo, fondato da Jeremy Bentham e sviluppato da autori come John Stuart Mill, Henry Sidgwick e George Edward Moore.
Per l'utilitarismo il fine ultimo è il miglior saldo fra piacere e dolore per tutti gli esseri senzienti. «Saldo» perché spesso per conseguire un piacere dobbiamo prima accettare una sofferenza ed è importante che il saldo, appunto, rimanga positivo; gli esseri senzienti, oltre agli umani, includono almeno tutti gli altri animali, quindi l'utilitarismo è una base naturale per l'animalismo. Ma l'elemento cruciale da tenere a mente, qui, è che in ogni forma di teleologismo sono le conseguenze, gli esiti di una scelta a determinarne il valore morale; per un utilitarista sarà decisivo quanto utili, vantaggiose o piacevoli siano tali conseguenze.
Il secondo tipo di teoria etica si dice deontologico e stabilisce delle norme di comportamento, decretando giuste le scelte che obbediscano alle norme, quali che ne siano le conseguenze. L'etica dei dieci comandamenti è di questo tipo: non importa se talvolta, rubando o mentendo, possiamo essere tutti più felici. Il comando divino ci impone di non rubare e non mentire; punto e basta.
Una diversa etica deontologica è quella kantiana, per cui in ogni circostanza la scelta giusta è quella prescritta dalla ragione, trascurando ogni idiosincrasia, preferenza o anche relazione affettiva. È quello che dovrebbe scegliere chiunque altro al mio posto, usando ugualmente della sua ragione. Dare un buon voto in un esame a uno studente perché ha risposto bene è una scelta razionale, che ognuno dovrebbe compiere, quindi è giusta; dare un buon voto in un esame a uno studente comunque abbia risposto (e anche se ha risposto bene) perché mi sta simpatico, o perché è amico di mio figlio, condizionerebbe la mia scelta a fattori squisitamente personali e sarebbe quindi ingiusto.
Con questo armamentario in mano, consideriamo il dibattito in corso. Le persone che esprimono perplessità o opposizione al referendum, pur essendo contrarie al green pass, formulano quasi esclusivamente tesi e argomentazioni di carattere teleologico, e anzi più precisamente utilitaristico. Facciamo qualche esempio. Se ci mettiamo a raccogliere le firme e nel breve tempo che abbiamo non ne raccogliamo abbastanza, sarà un fallimento. Se anche raccoglieremo le firme necessarie, nel frattempo le leggi che intendiamo abrogare potrebbero essere decadute per conto loro, e avremmo lavorato a vuoto. Se anche arriveremo a un referendum probabilmente lo perderemo, perché la maggioranza della popolazione approva le mosse del governo. Sono tutti ragionamenti che determinano il valore di una scelta (indire il referendum) in base alle sue conseguenze, e in particolare a quanto utili o vantaggiose siano.
Come ho spiegato, questi ragionamenti si inseriscono in una corrente di pensiero millenaria e autorevole, che merita tutto il nostro rispetto. Ma è bene che anche le idee più universalmente accettate siano dibattute; proviamo allora ad aprire un dibattito introducendo nell'argomento una diversa prospettiva, deontologica kantiana.
Una dittatura è un sistema di governo irrazionale, perché non è controllata dalla ragione ma dalle decisioni arbitrarie di uno o di pochi, che tendono a cambiare da un giorno all'altro. Quindi la ragione ci chiede di resisterle, e se possibile di osteggiarla e abbatterla. Immanuel Kant espresse l'entusiasmo della ragione per la Rivoluzione francese, che aveva abbattuto un potere assoluto e tirannico. Un referendum contro il green pass è uno strumento di resistenza contro una misura liberticida dell'emergente dittatura, quindi la ragione non potrebbe che approvarlo e considerarlo giusto. Non è l'unica forma di resistenza possibile, quindi non è l'unica scelta giusta. Sono forme di resistenza alla tirannia, quindi giuste, anche le manifestazioni di piazza in cui i cittadini esprimono il proprio dissenso e le cause legali che vengono intentate contro individui responsabili di comportamenti criminali. Ma, fra le tante, è giusta anche questa.
Un esperimento mentale può aiutarci a capire meglio. Immaginiamo di essere non nell'autunno 2021 ma nell'autunno 1938: sono state appena emanate le leggi razziali fasciste e noi abbiamo l'opportunità di indire un referendum per abrogarle. Non ci sarebbe speranza che il referendum avesse successo. Il 1938 fu l'apice del regime: l'anno della Conferenza di Monaco, in cui Benito Mussolini venne consacrato come un grande statista. Le folle oceaniche che lo applaudivano voterebbero contro il nostro referendum. Inoltre, la Scienza ufficiale (in quel caso, come nel caso attuale, è appropriata la maiuscola perché stiamo parlando di un'attività non di ricerca ma di potere), rappresentata dagli illustri cattedratici firmatari del Manifesto sulla razza (di cui ho parlato in altro articolo), ci ridicolizzerebbe e insulterebbe. Vuol dire questo che dobbiamo rinunciare a indire il referendum, a difendere con tale gesto la nostra dignità e (ciò che resta di) quella del nostro Paese? Che cosa penseremmo di noi stessi fra qualche anno se avessimo fatto questa rinuncia? Che cosa penserebbero i nostri figli e nipoti?
Riaggiorniamoci al momento attuale. Si perderà? Credo proprio di sì. Adesso come allora la maggioranza della popolazione italiana è costituita da persone inerti, indifferenti, codarde o complici del sistema. Allora ebbero quel che meritavano: una nazione in macerie e soprattutto, da un punto di vista deontologico, una coscienza in macerie. Avranno quel che meritano anche gli inerti, gli indifferenti, i codardi e i complici di adesso. Per noi, deontologicamente, l'unica cosa che conta è fare la cosa giusta.