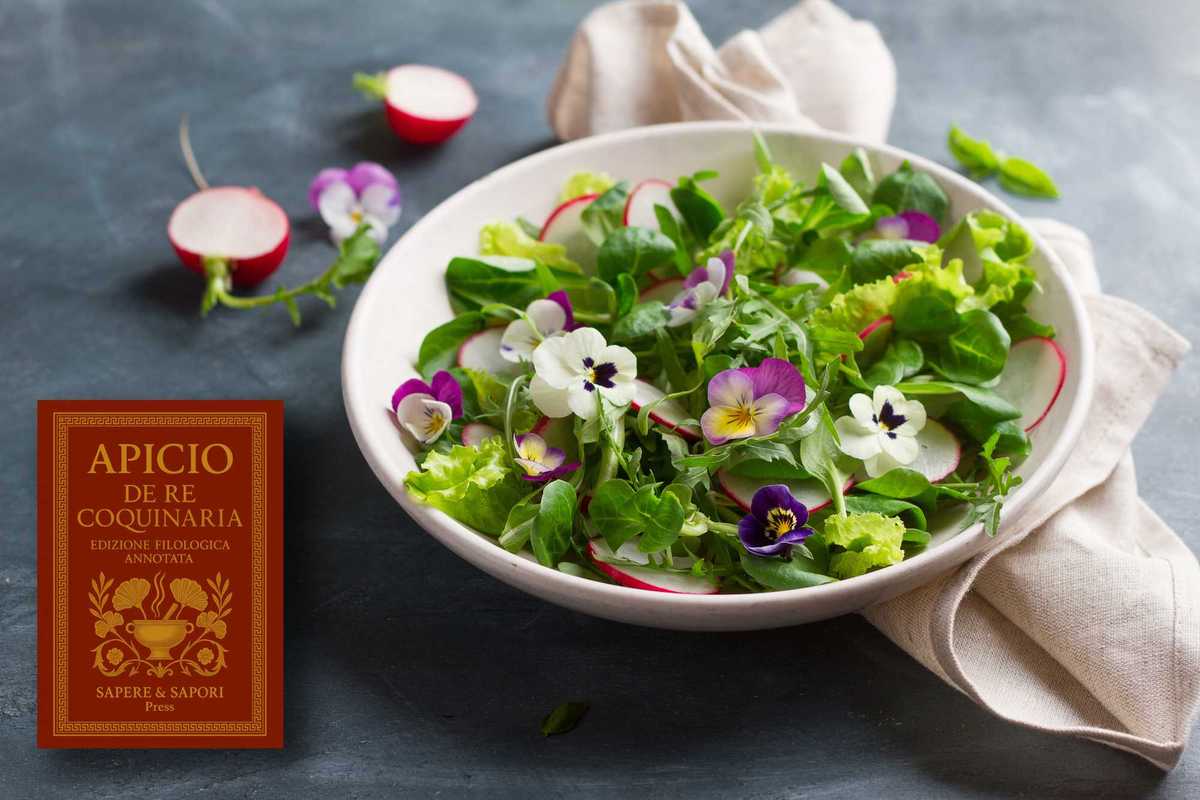Fontina. Il simbolo della Valle d’Aosta che nasce in vetta ed è grande fonte di fermenti vivi

Parliamo spesso dell’eterno duello tra ricetta tradizionale e sua rivisitazione o, più in alto nella scala del determinismo alimentare territoriale, cioè mangiare solo ciò che si produce in loco, ricetta creata dallo chef. Ma, a prescindere dalla preferenza che poi esprimiamo per la prima, per le seconde o per entrambe, tutte lecitissime, c’è un oggettivo elemento che le contraddistingue e che spiega anche perché quello che agli osservatori superficiali sembra solo un tormentone contemporaneo sia invece la semplice citazione di un elemento fondamentale: il territorio. La differenza marchiana tra ricetta tradizionale e sua rivisitazione o ricetta creata dallo chef è che la prima mescola esclusivamente ingredienti del luogo e con quelli crea il capolavoro, mentre la rivisitazione o la ricetta originale si giovano della possibilità di usare ingredienti di qualsiasi luogo del mondo (nel caso della rivisitazione, molto spesso l’innovazione consiste nel sostituire un ingrediente locale con uno equivalente ma straniero, per esempio usare il bacon negli spaghetti alla carbonara al posto del guanciale, il burro di cocco al posto del burro nel panettone).
Creare local potrebbe sembrare più facile che creare avendo a disposizione tutti gli ingredienti del globo terracqueo, ma non lo è. La ricetta non è solo quella dei piatti, è anche quella del prodotto (ugualmente esistono rivisitazioni contemporanee di prodotti tradizionali, come la famigerata fake meat, oppure nuovi prodotti come la mortadella di pollo o il Burrolì (burro di cacao, olio evo, olio di riso) dei pasticceri Luca Montersino e Fabio Ciriaci). Formaggi e salumi Dop e spesso anche Igp rappresentano perfettamente questa consustanziazione del territorio nell’alimento (diciamo spesso perché quando la materia prima non è sufficiente a soddisfare i numeri della produzione nazionale e internazionale ossia per l’export il disciplinare può prevedere il ricorso alla materia importata). Sintesi del territorio nel suo prodotto alimentare, quasi alchimia di quello nel boccone, tanto che il claim di una recente campagna pubblicitaria della nostra Fontina Dop è: «Fontina Dop. Non è della Valle d’Aosta, è la Valle d’Aosta».
In questo felice caso di determinismo alimentare territoriale, tutte le particolarissime caratteristiche del territorio montano valdostano, dei suoi animali, del tipo di allevamento, del tipo di foraggio eccetera si ritrovano nell’alimento finito. E se un alimento è il suo territorio, è giusto e bello non limitarsi a mangiare fontina (d’ora in poi la chiameremo così), ma anche conoscerne l’affascinante lavorio che si svolge sul territorio e a essa conduce.
storia ed emozione
Altri due percepiti tormentoni contemporanei del cibo sono la storia e l’emozione: quante volte abbiamo sentito dire che un piatto deve raccontare una storia che emozioni, che l’ingrediente segreto è l’emozione? Le storie emozionanti non risiedono solo nel piatto nato dalla fantasia dello chef, sono anche nelle ricette tradizionali e poi sono negli ingredienti, perciò facciamo parlare quella della fontina. Gli ingredienti della fontina sono solo tre: sale, caglio e latte intero e crudo appena munto dalle bovine di razze valdostane autoctone ossia pezzata rossa, pezzata nera e castana. Si tratta di mucche che vivono fino a 12 anni, portano avanti una sola gravidanza all’anno e producono circa 15 litri di latte al giorno, la metà della normale mucca da allevamento e un quarto di quella della frisona, che arriva fino a 60.
La pezzata rossa, introdotta dai Burgundi di Gundobaldo nel V secolo, è una produttrice di latte più prolifica, mentre la pezzata nera e la castana sono più brillanti per i su e giù dell’alpeggio (tra le due, la castana è quella dalla fisicità più prestante, è lei che, come una dinamica bad girl della fauna d’altitudine, comincia gli scontri per la gerarchia nelle mandrie). Le mungiture sono due al giorno e dopo la mungitura la mucca pascola un paio d’ore. In tanti allevamenti e in alpeggio si munge ancora a mano. Rispetto ai generali ritmi urbani o di altre produzioni alimentari anche campagnole, velocizzati come quelli di Ridolini ma con esito non piacevole - perché il comico muovendosi alla velocità della luce faceva ridere, l’ipervelocità odierna stressa e deprime -, ci troviamo di fronte a un sano «andamento lento» tipico della montagna e rispettoso del benessere animale in un modo che zittirebbe qualsiasi vegano ossesso.
Formaggio semiduro, grasso, a pasta semicotta, ad acidità naturale di fermentazione, la fontina richiede latte intero di vacca di una sola mungitura non avvenuta da oltre 2 ore, ciò che la rende un formaggio a filiera decisamente corta, una produzione a chilometro quasi letteralmente zero difficilmente superabile, giacché o quel latte è lavorato da chi lo ha munto o va consegnato a un caseificio valdostano raggiungibile in massimo due ore. La fontina è uno dei non troppi e rinomati formaggi italiani di latte crudo (altri con latte vaccino crudo sono Parmigiano reggiano Dop, Grana padano Dop, Strachitunt Dop, Caciocavallo silano Dop, con latte di pecora crudo Fiore sardo Dop). Anche il latte è frutto di una concezione produttiva valdostana virtuosamente slow e preindustriale che la fontina porta avanti: per la coltivazione del foraggio con cui si alimentano gli animali non si ricorre a fertilizzazione e concimazione chimiche, ma a rotazione dei pascoli, concimati con il letame (4 animali concimano circa 1 ettaro).
latte crudo e più sano
Per una forma da 9 chili di fontina ci vogliono 100 litri di latte appena munto (per produrre il quale ci vogliono 10 vacche). Il latte crudo, cioè non trattato termicamente a oltre 36 °C, può essere aggiunto di fermenti, del territorio anch’essi, perché si tratta di lattobacilli delle microflore valdostane selezionati e conservati presso l’Institut agricole régional di Aosta. Poi il latte si aggiunge del caglio e si fa coagulare in caldaie di rame o acciaio per 40 minuti almeno, poi si rompe la cagliata in tocchetti con l’attrezzo detto spino e si continua a scaldare, fino a 46-48 gradi: questa è la spinatura e dopo di essa si procede all’estrazione della cagliata con teli e al posizionamento nelle fascere. Le forme verranno voltate e rivoltate nelle successive 12 ore, aggiunte di una targhetta di caseina con il numero naturalmente progressivo della forma sullo scalzo, cioè il lato della forma, e infine lo stampo del Consorzio tutela fontina (Ctf) comprensivo di codice identificativo del produttore su una faccia piana della forma. Poi si sala e infine si stagiona, rivoltando, salando e spazzolando a mano, in grotte naturali per almeno tre mesi. Finita la stagionatura, il Ctf controlla autenticità e qualità e marchia.
Un po’ come è per la sfogliatella napoletana, che si è sdoppiata da sé in liscia (frolla) e riccia, anche la fontina ha la sua variante autocanonizzata, la fontina d’alpeggio. Fontina e fontina d’alpeggio sono e non sono la stessa cosa. Nel periodo invernale la Fontina Dop viene prodotta quando le bovine si trovano a fondovalle, mentre in estate, quando si spostano ad alta quota tra 1.700 e 2.700 metri, si produce Fontina Dop di alpeggio. Le mandrie salgono a fine maggio e ci restano fino a fine settembre. La transumanza verso vetta si chiama inarpa, il ritorno a valle desarpa. La permanenza si chiama monticazione e le sue date simboliche sono il 15 giugno, giorno di San Bernardo, non a caso patrono dei montanari e degli alpinisti, e il 29 settembre, giorno nel quale si festeggia San Michele.
Inarpa e desarpa sono momenti di festa per tutti i paesi del percorso e anche per le vacche più meritevoli. Durante la desarpa, infatti, si celebra la regina del latte, la mucca che ha prodotto più latte in vetta, che scende a valle con un bousquet di nastri e fiori bianchi al collo, e la regina delle corna, quella più combattiva durante l’estate (la bad cow, potremmo dire, per tornare al paragone di prima), riconoscibile per il bousquet rosso. Poiché le mucche alpeggiano circa 100 giorni l’anno, la fontina d’alpeggio è il frutto di un trimestre preciso, un periodo limitato nel tempo che concentra - ancora determinismo alimentare territoriale - quella particolare situazione spazio-temporale negli odori e sapori della forma, che è innanzitutto più cremosa di quella di fondovalle. E di aroma differente.
erba verde e fieno
Per le mucche, infatti, cambia il nutrimento e il latte e di conseguenza il formaggio raccontano questo cambiamento: erba verde di pascoli in cima ai monti in estate, fieno di prato a fondovalle la restante parte dell’anno. L’erba di alta montagna è diversa dal fieno ed è varia, cambia a seconda dell’altitudine e questo rende ogni alpeggio diverso, differenza che si concretizza - si scrive, come le frasi di una storia e di un’emozione - in note aromatiche diverse a seconda dell’alpeggio e si chiama «aroma erbaceo». Sulla produzione totale di fontina, solo il 15% è di alpeggio e si trova in commercio a partire da agosto.
La storia della trasposizione del territorio della Valle d’Aosta nella fontina non finisce qui. Il siero residuo della lavorazione della fontina si scalda a 85°, si acidifica con agra (anche detta boné, è formata da scotta, acetosella, radici di ortica e limone) e poi, con la spannarola, si raccoglie questo latticino fresco a pasta molle poco aromatico, ma molto gradevole. Si tratta della brossa, un Pat valdostano che si consuma così o che si usa per preparare un burro, poco grasso e molto apprezzato. Abbiamo detto che la fontina è la Val d’Aosta. Lo sono anche altri formaggi meno conosciuti ma sempre Dop, come il Fromadzo, considerato una sorta di versione light della fontina, tradizionalmente prodotto come alternativa alla fontina e per caseificare con meno latte e dovendo produrre burro da affioramento (il Fromadzo si screma, appunto, la fontina no).
Il primo pregio della fontina per la nostra salute deriva dall’essere di latte crudo. La forma pronta non ha lattosio, che resta per lo più nel siero e poi è nullificato dalla fermentazione. La fontina è quindi una grande fonte di fermenti lattici vivi e, pur essendo un formaggio non magro, a parità di peso presenta la stessa quota di colesterolo della carne magra, sei volte meno di un uovo intero. Fonte di calcio (nei canonici 100 grammi troviamo l’87% della razione giornaliera raccomandata), vitamina A (antiossidante utile a vista, crescita e sistema immunitario) e B2 (necessaria a rilasciare energia al corpo), la fontina ha soltano 360 calorie ogni 100 grammi.
Ecco perché fresca, fusa nel piatto il cui nome celebra la sua inconfondibile fondibilità, la fonduta, o in altri piatti del territorio valdostano che la richiedono, come gli gnocchi alla bava o la costoletta alla valdostana, non meno gustosa della costoletta alla milanese o alla bolognese, è, come si dice nei luoghi popolari, «la morte loro». Con questa frase idiomatica si vuole significare che un ingrediente o un abbinamento sono i migliori per una preparazione che risulterà talmente buona da finire subito: a volte, il determinismo alimentare territoriale è una fortuna e non una limitazione e non ce ne voglia chi vorrebbe la fontina con la bevanda detta latte di cocco, cocco che non cresce in Valle d’Aosta.