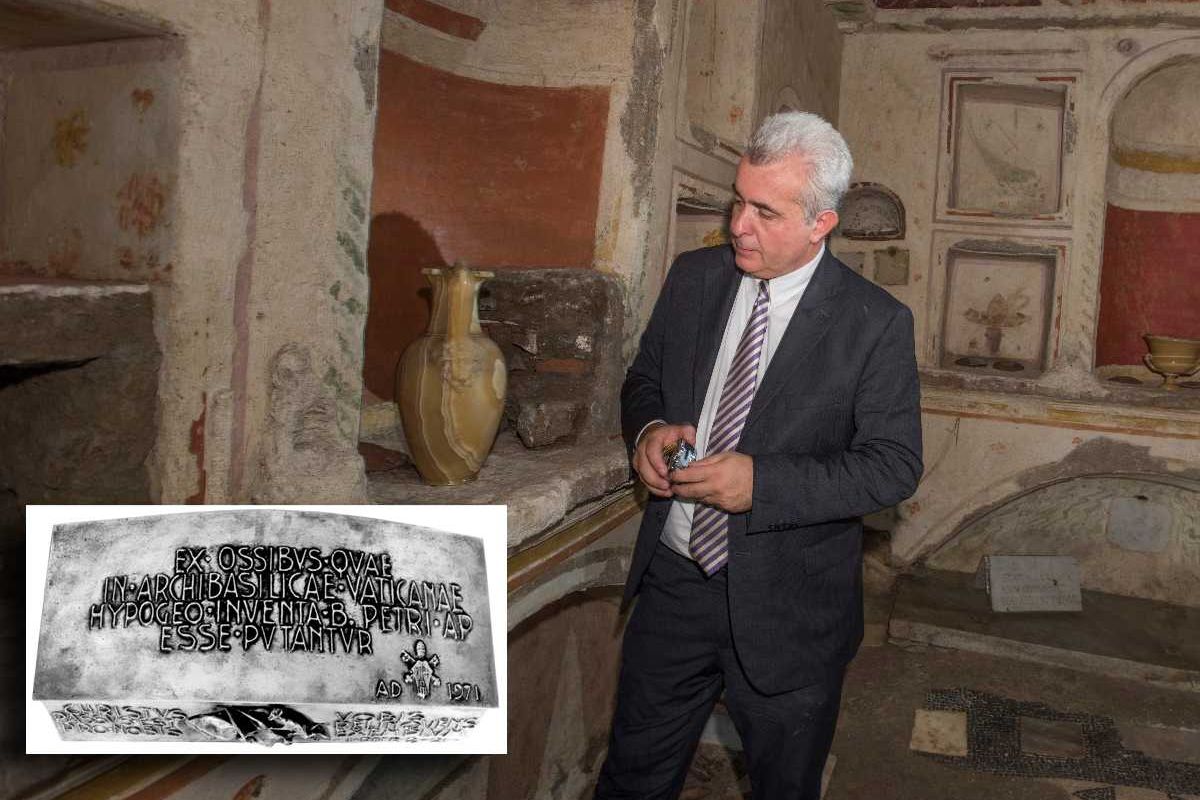«Per estrarre materie prime ci vuole una società a controllo pubblico»
- L’esperto Gianclaudio Torlizzi: «La Bce dovrebbe offrire le garanzie finanziarie. Le sanzioni a Mosca hanno aggravato la nostra dipendenza».
- L’Europa spinge per il Green deal dopo che per anni ha lasciato che la Cina acquisisse il controllo degli elementi necessari alla transizione Il risultato è il rialzo dei prezzi Eppure un’alternativa ci sarebbe: riaprire le miniere.
- Ecologisti e banche sono un ostacolo. I primi preferiscono che l’impatto ambientale lo paghino i Paesi più poveri. Le seconde «non concedono prestiti per piani contrari ai principi verdi», spiega l’analista Enrico Mariutti.
Lo speciale contiene tre articoli.
«Continuare a seguire la politica di decarbonizzazione con i criteri definiti prima del 2022, ovvero prima della guerra ucraina, vuol dire mettere a repentaglio la sicurezza economica dell’Europa. Oggi bisogna scegliere se andare avanti con i target stringenti posti dal Green deal o tutelare l’economia e l’industria europea. I due obiettivi insieme non sono possibili. Ciò non significa rinunciare alla transizione ecologica ma rivedere le tappe e soprattutto impegnare la Bce affinché sostenga i Paesi nello sforzo impegnativo e costoso di affrancarsi per l’energia e le materie prime, dalla Cina e dalla Russia». Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity, società di consulenza sulle materie prime, è stato chiamato la scorsa settimana in audizione alla commissione Affari esteri della Camera, dal Comitato permanente sull’attuazione dell’Agenda 2030, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all’approvvigionamento delle cosiddette terre rare.
È così grave la situazione dell’approvvigionamento delle materie prime?
«Temo di sì e per due motivi: i target molto sfidanti di decarbonizzazione e la guerra in Ucraina. Le sanzioni applicate dall’Europa alla Russia non solo non hanno prodotto danni rilevanti all’economia russa, ma hanno determinato una separazione delle filiere di fornitura dell’energia e dei metalli. Si sono creati due mercati paralleli delle materie prime e dell’energia. I russi per compensare le perdite dalla mancata vendita di petrolio in Occidente, hanno intensificato le esportazioni in Asia, grazie alla complicità degli armatori greci che usufruendo di condizioni vantaggiose, hanno caricato il petrolio, aggirando l’ostacolo delle sanzioni. Le sanzioni si sono tradotte in un boomerang per l’Europa che ha dovuto trovare rifornimenti altrove. Un processo analogo ha interessato i metalli e le terre rare, elementi fondamentali alla transizione ecologica. La Cina è diventato il primo importatore di alluminio russo. Questo processo ha compiuto un salto di qualità quando il 16 aprile scorso, Usa e Regno Unito hanno annunciato nuove sanzioni su rame, nichel e alluminio prodotto in Russia».
Quindi mentre il Green deal con le sue scadenze capestro andava avanti, l’Europa si privava, con le sanzioni alla Russia, delle materie prime per portarla avanti?
«È proprio così. E la Cina ne ha approfittato. Si sono creati due blocchi nell’economia mondiale perché con la guerra è venuta meno la globalizzazione e la circolazione delle materie prime. Si pone quindi un problema di carenza di energia e di metalli necessari alla transizione ecologica e di dipendenza nei confronti di Paesi che non sono più amici e concorrenti. La contrapposizione che si sta verificando è tra blocco euroatlantico e Paesi quali Cina, Iran, Russia e Nord Corea. La Cina, in particolare detiene una posizione di assoluto predominio della filiera delle terre rare e dei metalli, sul fronte dell’estrazione (giacché estrae il 70% delle terre rare mondiali) ma soprattutto sul fronte della raffinazione, di cui controlla il 90%. La Cina controlla tutta la filiera non solo dei metalli critici ma anche dei manufatti come pale eoliche, fotovoltaico, batterie elettriche. Sta cambiando il modello di business dal comparto delle costruzioni, all’export di prodotti ad alto valore aggiunto. Stando così le cose, bisogna prendere atto che il Green deal mette a repentaglio la sicurezza economica dell’Europa».
In che modo?
«L’Europa ha smesso di scavare, ha chiuso le miniere per ragioni ambientaliste ma si è data obiettivi stringenti di abbattimento delle emissioni. Se i target erano difficili da raggiungere prima della guerra in Ucraina, ora tagliando i ponti con la Russia e senza materie prime, sono quasi impossibili. L’Europa diventerà sempre più dipendente dalla Cina con la quale non possiamo chiudere perché ci sono troppi interessi in gioco».
Che fare?
«Bisogna dotare i singoli Paesi di strumenti finanziari per poter aumentare l’offerta di materie prima ma ciò non si sta facendo. La Commissione Ue ha elaborato il Critical Raw Materials Act, per ridurre la dipendenza dalla Cina. Ma oltre ad aver denunciato le criticità europee in materia, non sono stati forniti gli strumenti per mitigare la carenza di metalli. A questo punto il ruolo della Bce è cruciale».
Ma la Bce dice di accelerare la transizione ecologica.
«Dovrebbe invece offrire garanzie finanziarie per permettere agli Stati di poter effettuare gli investimenti necessari alla transizione. Colpisce che finora nessun Paese si stia attivando in modo serio per tutelarsi dal rischio che un domani la Cina possa utilizzare la leadership delle materie prime per impedire politiche commerciali europee a lei dannose. Io ho un sospetto».
Quale sospetto?
«Lo scenario è chiaro ma come mai nessuno fa niente per evitare di finire dipendenti totalmente da Pechino? Non ho prove, ma il sospetto che ci sia la volontà di non cambiare la situazione. Non vorrei che ci fosse la longa manus di Pechino, l’azione di lobby sulla Commissione Ue. Tutelare la nostra industria dovrebbe essere una priorità delle istituzioni europee, ma perché allora nessuno fa nulla?».
L’Italia cosa può fare?
«Bisognerebbe aprire un dibattito su come creare un veicolo a controllo pubblico, con la partecipazione anche di privati, che operi nell’estrazione e raffinazione dei metalli».
L'Italia ha un tesoro che non sa sfruttare
La Banca centrale europea spinge per l’accelerazione della transizione energetica, paventando disastri economici come alta inflazione e bassa produzione industriale, qualora si rallentasse la tabella di marcia del Green deal. La Commissione europea, dal canto suo, ha scoperto che l’Europa dipende troppo dalla Cina per le materie prime necessarie ad attuare la decarbonizzazione, ed esorta i Paesi a rimettersi a scavare nelle miniere. Si tratta di due posizioni che entrano in corto circuito e confermano ancora una volta come l’Europa abbia le idee poco chiare su come procedere nell’abbandono progressivo dei combustibili fossili.
Accelerare la transizione significa aumentare la domanda di materie prime e quindi spingere i prezzi al rialzo poiché i materiali sono importati dalla Cina che ne detiene il monopolio. È quella Greenflation, cioè l’inflazione da costi delle energie rinnovabili, di cui ha parlato la stessa Bce prima del Covid. L’International Energy Agency (Iea) ha stimato che la domanda di minerali per veicoli elettrici a batteria crescerà almeno di 30 volte entro il 2040. I prezzi di litio e cobalto, che sono componenti vitali in molti prodotti, dai cellulari ai monitor, alle turbine eoliche ai pannelli fotovoltaici, come pure per il settore militare con radar e laser, continuano a macinare rialzi. Basti pensare che il costo delle materie prime rappresenta il 50-70% del valore totale delle batterie al litio. Se poi la Commissione Ue chiede di ricominciare l’attività estrattiva per essere meno dipendenti dalle importazioni, sembra non ricordare che sulle miniere pendono i veti ambientalisti. Semmai si possono fare accordi con i Paesi produttori ma con un passo sempre indietro alla Cina già monopolista pure di tali partnership.
Tra le grandi società minerarie internazionali è scattata la caccia ad accaparrarsi le miniere. Il rame è la materia prima che risentirà di più nei prossimi anni di eccesso di domanda rispetto all’offerta. Dall’inizio dell’anno il prezzo di questo materiale è andato oltre i 10.000 dollari, il 16% in più in sei mesi. E in questa fase la domanda e l’offerta quasi si equivalgono. Quindi pensiamo a ciò che potrebbe succedere a breve.
Il rame è il metallo dell’elettrificazione e l’obiettivo delle emissioni zero al 2050 ha fatto correre la domanda. Le sue applicazioni spaziano dall’edilizia alle reti di produzione e trasmissione, ai veicoli elettrici, ai pannelli solari, alle turbine eoliche fino ai data center per l’intelligenza artificiale, cioè a tutto ciò che ha a che fare con le energie rinnovabili. Secondo uno studio di S&P Global del 2022, la domanda di rame è prevista crescere da 25 milioni di tonnellate metriche di oggi fino a 50 milioni entro il 2035 e fino a 53 milioni nel 2050. Al 2035 potrebbe esserci il picco nella differenza tra domanda e offerta, pari a circa 10 milioni di tonnellate metriche. Bisognerebbe quindi investire in nuove miniere. Per attivare una miniera occorrono in media circa 16 anni tra scoperta e inizio di produzione. La Cina ricopre una posizione predominante nella produzione e nella lavorazione.
Quale è la mappa dei giacimenti minerari in Europa? A causa di risorse proprie limitate, l’Europa importa materie prime dalla Cina (antimonio, bismuto, magnesio), nonché da Marocco, Russia, Turchia, Stati Uniti, Australia, Messico, Algeria, Indonesia, Brasile, Kazakistan, Nigeria, Sudafrica. Nello specifico, l’Europa importa il 100% di antimonio, bismuto, borati, magnesio, gomma naturale, niobio, fosforo, scandio, tantalio, platino, terre rare leggere e pesanti. Importa oltre il 96% di elio e l’88% di fosfati di roccia. Per il 56% delle 34 materie prime critiche censite dalla Commissione europea, la Cina ha un ruolo chiave poiché detiene il primato nella fornitura all’Unione europea.
Ma l’Europa ha comunque importanti giacimenti che andrebbero sfruttati. Secondo le stime del Centro di ricerca della Commissione Ue, il valore delle risorse minerarie europee non sfruttate alla profondità di 500-1.000 metri è stimata in circa 100 miliardi di euro. Il problema però è sempre lo stesso: la protesta delle popolazioni locali. In Francia, appena la società transalpina Imerys ha annunciato lo sfruttamento del giacimento di litio di Echassières, nel centro del Paese, si è trovata contro le comunità del posto per i contraccolpi sulla vicina foresta dei Colettes. Anche a Tréguennec, sempre in Francia, dove si trova il secondo più grande deposito di litio del Paese, la popolazione è sul piede di guerra. Stessa situazione in altri Paesi. È il caso della miniera a cielo aperto di Covas do Barroso, in Portogallo, che la britannica Savannah Resources vorrebbe inaugurare nel 2026 per creare il più grande centro d’estrazione di litio del continente. Allevatori e ambientalisti e perfino la parrocchia del posto, si sono scagliati contro il progetto, facendo causa all’azienda. Per ragioni simili, in Svezia, è bloccata da anni la miniera di Norra Karr, considerato un tesoro di terre rare. Alte concentrazioni di materie prime critiche sono segnalate anche in Austria, Repubblica ceca, Romania, Svezia, Finlandia e Spagna. Giacimenti, anche se in misura nettamente minore, sono stati individuati in Germania.
Quale è la situazione in Italia? L’industria mineraria impiega attualmente poco più di 3.000 minatori, distribuiti nei siti produttivi presenti in 14 regioni, con un’alta percentuale in Piemonte, Sardegna, Toscana e Sicilia. La multinazionale australiana Altamin Limited, fra le più attive nell’attività estrattiva in Italia, ha individuato il litio tra la provincia di Viterbo e la Toscana. Un notevole giacimento di titanio, pari a 9 milioni di tonnellate, è invece a Piampaludo, in provincia di Savona. L’area della potenziale miniera però è inserita nell’area protetta del Parco regionale del Beigua. Fra Genova e Savona si segnala anche la presenza di rame, grafite, barite e manganese.
Sulle Alpi piemontesi, nell’area di Punta Corna, si stima che ci sia una concentrazione tra le più elevate del pianeta di cobalto, oltre a manganese e grafite ma, anche in questo caso, l’attività estrattiva mal si concilierebbe con la tutela del paesaggio naturale. Cobalto anche in Friuli mentre in Veneto è presente magnesio e rame. In Trentino sono stati rinvenuti cobalto, manganese, magnesio, barite, rame; in Lombardia si segnalano rame, barite, cobalto, berillio. Nella Bergamasca, c’è un progetto di rilancio della miniera di Gorno, ricca di piombo e zinco e chiusa dall’Eni negli anni Ottanta, ma è fermo per l’opposizione delle comunità locali. La Toscana, ricca di rame, antimonio, manganese e magnesio. Nel Nord del Lazio esistono alcuni giacimenti di cobalto, manganese e barite. La barite c’è anche in Sardegna, insieme al rame e all’antimonio. L’Appennino abruzzese è ricco di giacimenti di bauxite e uno di manganese. Si trova bauxite anche nel nord della Campania e in varie zone della Puglia. In Calabria manganese, barite e grafite, in Sicilia antimonio e manganese.
Ecologisti e banche sono un ostacolo
«La transizione ecologica richiede l’apertura di più miniere ma l’attività estrattiva è considerata molto impattante dagli ambientalisti. Inoltre richiederebbe investimenti importanti e nessuna banca sarebbe disposta a concedere prestiti per progetti che sono contrari ai principi green. È un corto circuito che favorisce la Cina. Non c’è scampo. Inoltre basta considerare il simbolo della transizione energetica, cioè i pannelli fotovoltaici. Sono tutti made in China ma le aziende cinesi non consentono a nessuno di verificare come vengono prodotti, quanta CO2 è emessa. Le certificazioni sono fatte da pochi grandi gruppi che usano dati vecchi di 20 anni per misurare le emissioni. È una cosa risaputa ma nessuno dice nulla, nessuno interviene perché ci sono interessi in gioco importanti e soprattutto perché la corsa verso la decarbonizzazione impone più fotovoltaico possibile e l’industria europea non è in grado di stare al passo con la domanda». Enrico Mariutti, analista energetico e delle materie prime, fa parte di un gruppo di ricercatori e giornalisti che indaga sulle fake news della propaganda green.
La Bce chiede di accelerare la decarbonizzazione e la Commissione europea dice che bisogna allentare i vincoli di dipendenza dalla Cina, ma come si può fare se l’Europa non si rende autonoma per l’approvvigionamento di materie prime e di terre rare? «Infatti è un dibattito surreale» commenta Mariutti e sottolinea alcuni fattori che rendono molto costoso e quindi poco praticabile questo percorso. «L’industria mineraria ha bisogno di un contesto in cui la manodopera ha fame di lavoro e reddito, dove la difesa dei diritti dei lavoratori non è stringente e i vincoli ambientali non invasivi; non è questo il caso dell’Europa. Tant’è che oggi i grandi produttori di materie prime sono i Paesi in via di sviluppo che non hanno, o li hanno solo in parte, questi vincoli. Cina e India continuano a estrarre in condizioni di nessun rispetto dell’impatto ambientale. L’industria mineraria non è ecologica ed è labour intensive. Lo sanno tutti ma si fa finta di niente, continuando con un dibattito che non porta da nessuna parte. Si possono riaprire le miniere ma il prodotto avrebbe costi superiori a quelli del mercato cinese o indiano». Così l’Europa è costretta a fornirsi di materie prime e di prodotti per la transizione energetica, dai cinesi. «Il paradosso è che in questa corsa alla decarbonizzazione non si controllano nemmeno l’impatto ambientale della produzione dei pannelli solari o degli impianti eolici. Le società di certificazione, non riuscendo a visionare i vari processi produttivi dentro gli stabilimenti e siccome questi sono protetti dal segreto industriale, adottano criteri di valutazione europei e vecchi di vent’anni. Il risultato è che siamo invasi di pannelli fotovoltaici dei quali non c’è certezza sul basso impatto ambientale come emissioni di CO2, per la loro costruzione. Gli interessi in gioco sono troppo alti perché qualcuno vada a mettere il naso su cosa succede negli stabilimenti cinesi».
Mariutti poi spiega che ci sono progetti alternativi alle miniere per l’estrazione di prodotti energetici. «Nelle acque di interesse economico esclusivo dell’Europa, ci sono quantità di gas naturale che sarebbero sufficienti a soddisfare i consumi europei per secoli. La Commissione europea ha chiesto di mappare questi giacimenti di idrati di metano. Per l’estrazione però occorrono investimenti importanti e ora nessuno impiega risorse finanziarie per cercare risorse fossili. Al massimo si continua a operare dove lo sfruttamento è già in corso». Gli oceani sono ricchi di materie prime ma anche qui sono arrivati i veti ambientalisti. L’analista indica anche un altro fattore critico. «La Norvegia ha già iniziato con un progetto pilota per vedere le prospettive di questa nuova industria mineraria sotto i mari. Sulla carta queste aziende certificano che l’attività estrattiva comporta l’emissione di bassi livelli di CO2 ma sono dati che forniscono loro stessi e non monitorati da una terza società. Manca una cornice legislativa, mancano i controlli, tutto è molto opaco. Sembra fatto apposta per favorire l’industria cinese».