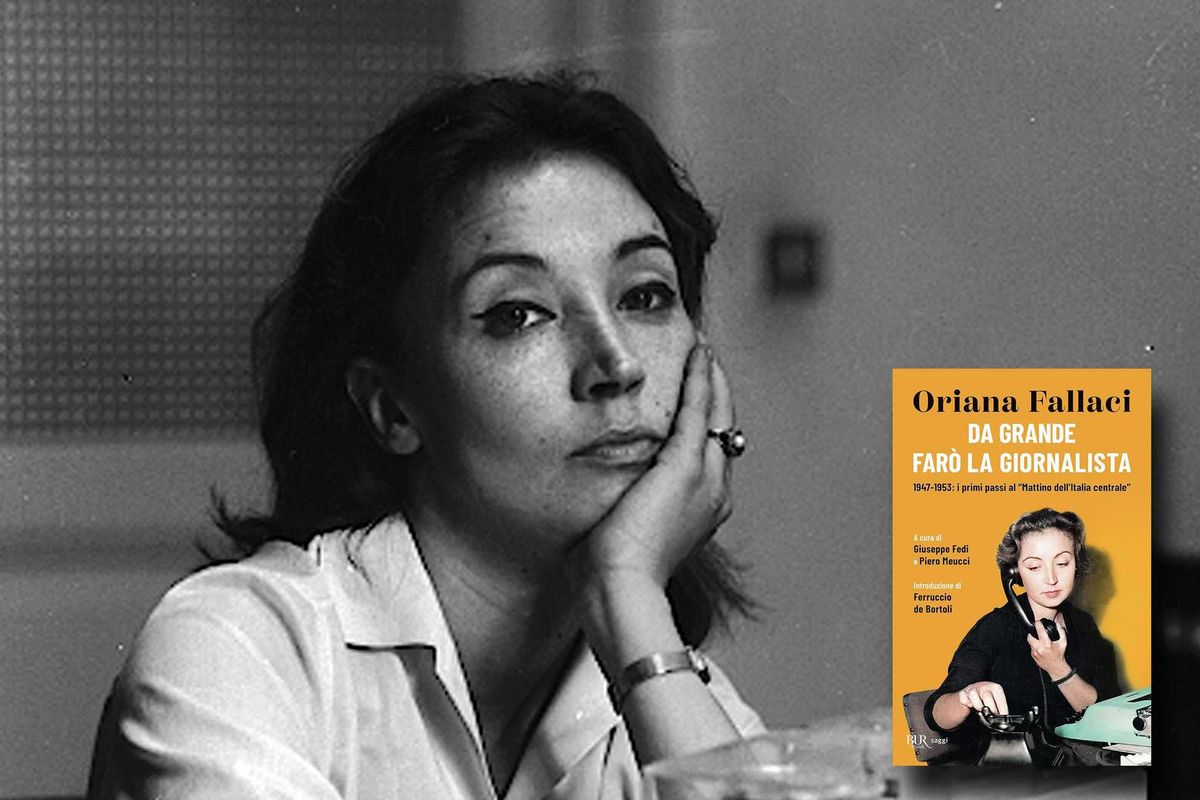Dall’energia alle questioni militari, il continente è più disunito che mai

- L'Ue non riesce a gestire le conseguenze delle proprie scelte belliche, come nella ex Jugoslavia, e le nazioni leader dipendono per il gas da russi o arabi. Non c'è coesione, quindi l'Unione va ripensata.
- L'Olanda guida un gruppo di nazioni che dissente sulla riforma dell'eurozona.
- E la Bulgaria ha affossato la Web tax di Bruxelles. Durante il suo semestre di presidenza, Sofia chiede di abbassare da 750 a 50 milioni la soglia di fatturato tassabile: «Per neutralità».
Lo speciale contiene tre articoli
L'Ue è finalmente arrivata a un bivio che la costringerà a ripensarsi. Un punto di non ritorno. Il vertice sulla crisi migratoria, più subìto che voluto da Angela Merkel, dimostrerà una volta per tutte le crepe politiche e istituzionali su cui poggia il progetto della Casa Comune, ovvero evidenzierà il fatto che nonostante il nome essa non è un'unione. Non lo è in senso prettamente tecnico dato che le competenze più importanti rimangono intergovernamentali e non lo è in senso politico in quanto nessuno Stato ha rinunciato al proprio interesse nazionale negli ultimi 60 anni di storia. La geografia e la storia sono ancora i fondamenti su cui le capitali formano le proprie politiche estere. A partire dalle guerre nella ex Jugoslavia fino ad arrivare alla Libia, passando dall'Ucraina, i Paesi membri hanno sempre dimostrato d'inseguire interessi particolari e di mancare completamente della capacità di gestione delle conseguenze dei propri atti dovendo affidarsi alla fine quasi sempre agli Usa. Nel campo energetico - politica ufficialmente comune - i Paesi mediterranei necessitano del dialogo con le capitali arabe mentre la Germania si affida a partnership con la Russia e Paesi centro europei, per non ritrovarsi stretti nella morsa tra due giganti storicamente ingombranti, chiamano in aiuto Washington per rifornirli di gas liquefatto. Nel bel mezzo della crisi migratoria scopriamo di non avere una politica d'asilo unica, di non riuscire a proteggere i confini e di mancare d'una struttura d'intelligence minima che invece funziona in ambito Nato. La tanto decantata tassa comune sui giganti del Web fallisce in quanto i piccoli Stati come il Lussemburgo, detentori di privilegi fiscali ad altri negati, si oppongono.
Gran parte dei Paesi europei ha accolto l'obbligatorietà delle istituzioni di Bruxelles solo in quanto apportatrici d'un compromesso necessario, accettabile finché utile, e in quanto la sicurezza veniva comunque garantita in ambito Nato da un membro esterno assai più forte, gli States. Nonostante l'innegabile interesse americano a costruire un sistema economico e sociale stabile sul confine con la zona comunista nel secondo dopoguerra, le comunità europee hanno avuto origine grazie alla spinta propulsiva di uomini quali De Gasperi, Adenauer e Schuman legati alla dottrina sociale cattolica e alle idee propugnate fin dal 1923 dal fondatore del movimento paneuropeo, l'aristocratico austriaco Richard Coudenhove-Kalergi. Per loro l'idea di un'Europa comune non era solo una necessità strategica abbisognante la benevolenza di Washington - che aveva ereditato da Londra il compito realpolitico d'evitare la formazione di qualunque forma d'egemonia sul Vecchio Continente - ma era anche un'idea utopica che poteva portare, grazie al principio di sussidiarietà tanto caro alla dottrina sociale, alla realizzazione di una società europea non conflittuale e consapevole della propria unicità storica. Il rifiuto francese alla Comunità di Difesa Comune nel 1954 menomò pesantemente le loro speranze, tolse la guida del progetto alla politica e passò la palla dell'integrazione alla classe dei burocrati. Questi nei successivi 50 anni hanno pressato i Paesi membri sulla via della rinuncia forzata a parte delle sovranità statali senza tuttavia pensare di compensare funzionalmente la perdita di tali prerogative.
Nonostante la sussidiarietà, cioè l'idea che i problemi vadano gestiti e risolti sempre al livello più prossimo al cittadino, lasciando ai vertici solo le competenze inesorabilmente comuni, sia uno dei principi fondamentali dei trattati europei esso non è mai stato applicato. Probabilmente la sussidiarietà risulta eccessivamente cattolica per una classe di burocrati formatasi sul pensiero federalista di Spinelli e nel laicismo giacobino d'ispirazione francese. Tutto ciò ci ha portato al paradosso massimo della moneta comune, che però non ha portato consequenzialmente - come invece pretendevano i teorici - a un governo comune e men che meno, premessa di ogni tipo di stabilità, a una società europea fiduciosa nelle proprie istituzioni. La fluidità della geopolitica post guerra fredda, che in questi anni sta ridisegnando il bilanciamento dei poteri globali, unito alla mancanza di una classe dirigente capace, non ha fatto che palesare le problematicità con cui l'Unione europea convive. Rinchiusa nella sua torre d'avorio idealista, essa non riesce ad ammettere di non essere un giocatore globale, priva com'è di capacità militari o di politiche estere comuni, ma cosa assai peggiore essa non riesce ad ammettere d'essere inconsistente poiché ha abbandonato i principi dei padri fondatori. Vogliono convincerci che è colpa dei cosiddetti populismi per non spiegarci le cause del problema. Alle prime difficoltà internazionali l'Ue ha dimostrato la sua inconsistenza politica e le pretese egemoniche di alcune capitali stanno riportando i Paesi verso un rigurgito sovranista da cui sarà arduo svincolarsi nei prossimi decenni. L'Europa del futuro prossimo dovrà rivedere il proprio modello evolutivo e probabilmente favorire, se vuole sopravvivere in attesa di tempi migliori, la formazione di blocchi politici tali da dar adito a un palesato - e non più ipocritamente negato - sistema di bilanciamento dei poteri interno all'Unione. Paesi medio piccoli, di cui Visegrad ed il Benelux rappresentano alcuni esempi, in dialogo realpolitico con i grandi Stati. Un passo indietro per riprovare, un giorno, a farne due in avanti.
Laris Gaiser
Bilancio europeo: rivolta sul piano Macron-Merkel
Nuova spaccatura all'interno dell'Unione europea. E, stavolta, nell'occhio del ciclone finisce la questione del bilancio. L'Olanda si è infatti messa a capo di una nutrita serie di Paesi (Belgio, Lussemburgo, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Estonia, Malta), per respingere il tentativo di riformare la zona euro, attraverso l'introduzione di un bilancio separato.
La proposta era stata profondamente caldeggiata dal presidente francese, Emmanuel Macron, con il benestare della cancelliera tedesca, Angela Merkel. A formalizzare l'opposizione, è stato il presidente di turno del Consiglio dei 28 ministri finanziari dell'Ecofin a Lussemburgo, il bulgaro Vladislav Goranov, che ha evidenziato le «posizioni divergenti in diversi Stati membri», tenendo comunque a precisare di approvare (non è chiaro quanto sinceramente) gli sforzi condotti da Parigi e Berlino per cercare di riformare l'Eurozona. Stando a Goranov, i ministri contrari alla proposta chiederebbero di «discutere più approfonditamente qual è il fine principale di un bilancio diverso o separato per l'eurozona». In particolare, gli Stati riottosi hanno chiesto a Mario Centano, presidente dei 19 ministri finanziari dell'Eurogruppo, di informare i capi di Stato e di governo dell'Unione - in vista del loro summit a Bruxelles previsto a fine giugno - della mancanza di una intesa per quanto concerne il progetto di bilancio franco-tedesco. Insomma, si tratta di uno schiaffo politico non indifferente, inferto a Parigi e a Berlino. Uno schiaffo doloroso che, guarda caso, non è stato granché digerito. I ministri delle finanze di Germania e Francia, Olaf Scholz e Bruno Le Maire, hanno infatti difeso la proposta che avevano presentato. In particolare, Le Maire ha usato parole di una certa durezza. «Dobbiamo trarre una lezione dalla crisi greca», ha affermato, «L'eurozona non può restare così come è ora perché sarebbe irresponsabile». Le Maire ha inoltre aggiunto che «la nostra determinazione a convincere i partner sulla necessità di andare avanti è totale» dal momento che «non possiamo lasciare ai nostri figli un'eurozona così fragile come è oggi». Scholz, dal canto suo, si è espresso in modo più cauto, sostenendo che questo sarebbe solo «il punto di partenza» per discussioni che «richiedono tempo». Come che sia, sembrerebbe che l'asse franco-tedesco non abbia alcuna intenzione di indietreggiare, puntando a ripresentare la questione al summit di fine mese, cui parteciperanno anche Emmanuel Macron e Angela Merkel. In tutto questo, il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, ha mostrato un parziale ottimismo, affermando che «per la prima volta si affrontano apertamente temi come quello della costruzione di un bilancio europeo, la fiscal capacity, le assicurazioni sui depositi», pur riconoscendo che «abbiamo registrato disaccordo» su alcune parti. L'Italia, insomma, sembrerebbe puntare a una mediazione. Una strada non esattamente facile, visto che l'Olanda non pare intenzionata a fare alcun passo indietro. Il braccio di ferro è solo all'inizio.
Stefano Graziosi
E la Bulgaria ha affossato la Web tax di Bruxelles
La tassa digitale europea deve essere rivista. Questo quanto emerge da un documento, non ancora reso pubblico, elaborato dalla Bulgaria, stato che attualmente detiene la presidenza dell'Ue. Stando al testo, l'Unione europea dovrebbe dunque prendere in considerazione l'abbassamento della soglia che colpisce le società digitali da 750 a 50 milioni di euro l'anno. Questo limite, inoltre, dovrebbe essere applicato solo alle società che operano all'interno dell'Ue. Inserire come parametro i 50 milioni di euro di fatturato annuo significa anche aumentare il bacino di società da raggiungere. Secondo Pierre Moscovici, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, la tassa digitale così come proposta dalla Commissione potrebbe «interessare 150 società».
Nella proposta originale era stato infatti stabilito di imporre una tassa del 3% a tutte quelle multinazionali digitali con un ricavato pari a 750 milioni di euro. Nel documento bulgaro la somma però è messa fra parentesi. Simbolo che si usa quando si vuole eliminare un determinato dettaglio dal testo. Il documento chiede infatti agli Stati membri di rivedere, tra le altre cose, le somme in questione. Secondo Jegerov Dmitrijegerov, sottosegretario alla Tassazione dell'Estonia - e considerato uno dei massimi esperti in materia di tassazione digitale - l'eliminare la soglia dei 750 milioni di euro è una modifica cruciale per garantire la neutralità della misura: «Si potrebbe avere un'azienda», dichiara il sottosegretario, «con un fatturato annuale di 740 milioni di euro che non paga le tasse, mentre una società da 760 milioni di euro, con un reddito imponibile di 60 milioni, che invece sarà tassata». Questo rappresenta un serio problema di neutralità fiscale. «Proprio per questo», conclude Dmitrijgerov, «accogliamo con favore la proposta di rimuovere la soglia dei 750 milioni di euro». Il documento bulgaro propone anche di «restringere l'ambito» della proposta «abbandonando» la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività su interfacce digitali «dall'elenco di servizi che possono essere tassati».
I diplomatici dell'Unione europea hanno però anche precisato come un'altra questione importante su cui si sta lavorando, è il campo di applicazione. Si vuole dunque capire se sia corretto «limitarsi ad una sola categoria di attività» oppure scegliere un insieme di elementi, ancora non meglio individuati.
Le modifiche sono necessarie anche per arrivare ad una soluzione temporanea in attesa che l'Ocse fornisca quella definiva. La soglia del 3%, era stato infatti precisato dal commissario Moscovici, doveva essere vista come uno strumento temporaneo. Rivedere la tassa digitale della Commissione è necessario anche perché senza l'accordo di tutti e 28 i paesi dell'Unione l'iniziativa fiscale non si potrà mai concretizzare. Fino ad ora paesi come Malta, Irlanda e Lussemburgo si sono opposti perché il regime proposto non andrebbe a loro favore. Queste nazioni hanno infatti adottato negli anni strategie fiscali che hanno permesso loro d'attrarre le maggiori multinazionali, facendo pagare tasse inferiori al 3%. Se si dovesse dunque uniformare il sistema fiscale, in tema di tassazione digitale, questi Paesi perderebbero il loro vantaggio competitivo a favore degli altri Stati Ue, come l'Italia. «Il supporto dei governi per la proposta di imposta sul fatturato digitale sembra diminuire man mano che si rendono conto di come questo danneggerebbe l'innovazione digitale, gli investimenti e le piccole imprese che utilizzano le piattaforme online per vendere a livello globale». Così Christian Borggreen, vicepresidente della Computer and Communications Industry Association, ha dichiarato a Bloomberg Tax.
Giorgia Pacione Di Bello