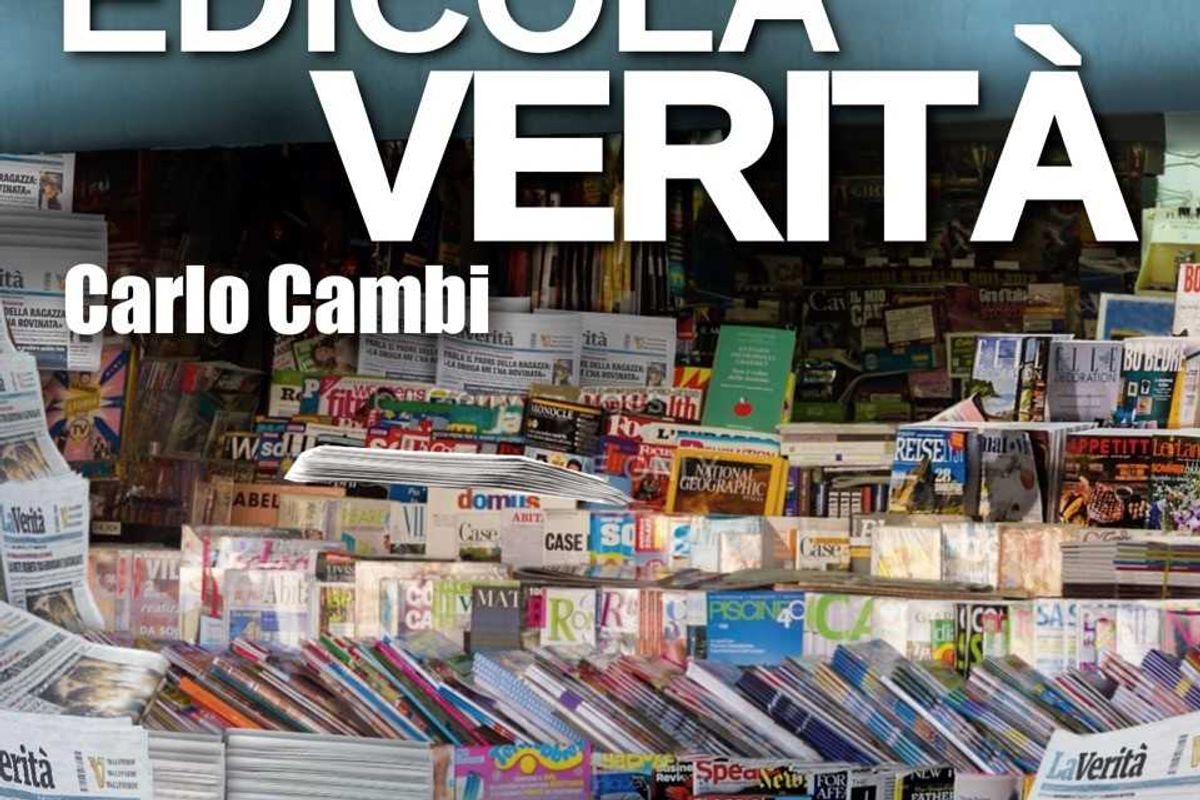A fronte di fatti come quello della donna recentemente accoltellata a Milano, senza motivo alcuno, da uno squilibrato mentale già resosi autore, in passato, di fatti analoghi e ciononostante a piede libero, è logico che ci si chieda che cosa non funzioni nel sistema che, teoricamente, dovrebbe garantire che soggetti di già riconosciuta pericolosità siano messi in condizione di non nuocere ulteriormente. La risposta è che quel sistema, originariamente rispondente a una certa logica e suscettibile, quindi, di produrre un certo grado di sicurezza, è stato progressivamente, di fatto, smantellato a colpi di interventi legislativi e di pronunce della Corte costituzionale.
Per rendersene conto è necessario anzitutto ricordare che nell’ordinamento italiano sono previste, per chi commette reati, oltre alle pene anche le misure di sicurezza personali, che sono (limitandoci alle principali): l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, per i soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia per i soggetti dichiarati, rispettivamente, totalmente o parzialmente infermi di mente; la libertà vigilata nei casi previsti specificamente dalla legge o, comunque, in ogni caso in cui vi sia stata condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno. Tali misure sono applicabili a coloro che, oltre ad aver commesso un reato, siano da considerare socialmente pericolosi, essendovi la probabilità che ne commettano altri. La loro finalità è, quindi, a differenza di quella delle pene, essenzialmente preventiva e ciò spiega il fatto che la loro durata sia determinata solo nella misura minima, potendo le stesse essere rinnovate, di volta in volta, per analoga durata finché non si ritenga che la pericolosità sociale sia cessata.
Un primo colpo al sistema fu quello assestato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 110/1974, che, per quanto ancora d’interesse, dichiarò incostituzionale l’articolo 207 del Codice penale, nella parte in cui non consentiva che la misura di sicurezza potesse essere revocata dal magistrato di sorveglianza anche prima che fosse trascorso il tempo minimo della sua durata, stabilito dalla legge, qualora, a giudizio dello stesso magistrato, la pericolosità sociale potesse dirsi cessata. In tal modo, alla previsione di legge, pur lasciata formalmente in vigore, veniva a sostituirsi, di fatto, la discrezionalità del singolo magistrato.
Un secondo e un terzo colpo furono quelli assestati ancora dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 139/1982 e 249/1983, con le quali fu stabilito che il ricovero in manicomio giudiziario e l’assegnazione a una casa di cura e custodia, pur disposti dal giudice della cognizione con sentenza divenuta esecutiva, non protessero aver luogo se non previo accertamento della persistente pericolosità sociale da parte del giudice dell’esecuzione. Il che, non essendo previsto un termine entro il quale tale accertamento debba essere effettuato, ha comportato che l’esecuzione della sentenza possa essere, di fatto, procrastinata a tempo indeterminato.
Ma un ulteriore e più grave colpo fu inferto con la legge n. 663/1986 (la cosiddetta legge Gozzini) a quello che poteva ritenersi il cardine del sistema, costituito dall’articolo 204 del Codice penale, in cui era stabilito, in sintesi, che dovesse presumersi socialmente pericoloso il soggetto nei confronti del quale la legge prevedeva come obbligatoria l’applicazione, a determinate condizioni, di una misura di sicurezza. Nonostante che la detta norma fosse stata dichiarata pienamente legittima dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 19/1966 e 68/1967, essa fu abrogata dall’articolo 31 della citata legge n. 663/1986 che la sostituì con la previsione che ogni misura di sicurezza fosse applicabile soltanto «previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa»; accertamento da farsi, quindi, a opera del giudice, per ogni singolo caso. Ciò ha comportato che si possa dichiarare qualcuno delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero ordinarne il ricovero in manicomio giudiziario per aver commesso, a causa della totale infermità di mente, un grave reato e, al tempo stesso, si possa ritenere improbabile che egli commetta ulteriori reati ed escludere, quindi, che sia socialmente pericoloso. Il che appare quanto di più contraddittorio e assurdo si possa immaginare.
Tornò poi di scena la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 253/2003, dichiarò incostituzionale la norma che prevedeva come obbligatorio, nei casi da essa indicati, il ricovero in manicomio giudiziario (divenuto, nel frattempo, «ospedale psichiatrico giudiziario»), nella parte in cui non consentiva al giudice di sostituire la detta misura con altra, non meglio identificata, tra quelle previste dalla legge, «idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente a far fronte alla sua pericolosità sociale».
Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati successivamente soppressi e sostituiti, a partire dal 2011, con le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza), la cui assoluta insufficienza rispetto alle esigenze minime della sicurezza sociale è stata adeguatamente messa in luce, su questo giornale, dal direttore Maurizio Belpietro nell’articolo comparso il 5 novembre scorso.
Come se non bastasse, è infine intervenuta la legge n. 81/2014 che, nel convertire il decreto legge n. 52/2014, ha stabilito, all’articolo 1, comma 1 quater, che i rinnovi delle misure di sicurezza per la ritenuta permanenza della pericolosità non possono andare oltre la durata della pena massima stabilita dalla legge per il reato commesso. Il che, pur se apparentemente ragionevole, è, in realtà, del tutto contrario alla logica propria delle misure di sicurezza, perché importa che le stesse debbano comunque cessare pur quando, in ipotesi, sia ancora presente e conclamata la pericolosità sociale del soggetto.
Stando così le cose, non vi è certo da stupirsi che il sistema non funzioni e che, quindi, accadano fatti come quello di Milano e come molti altri più o meno analoghi, quali ricordati nel citato articolo del direttore. E un rimedio potrà trovarsi solo a condizione che sia l’opinione pubblica, superando la tentazione dello scetticismo e/o della rassegnazione, a pretendere con forza che lo Stato adempia al primo e fondamentale dei suoi doveri: quello, cioè, di garantire nella massima misura possibile la sicurezza dei cittadini, a fronte della quale ogni altra esigenza deve ritenersi soccombente perché, quando manca la sicurezza, manca la condizione primaria della civile convivenza.
di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione