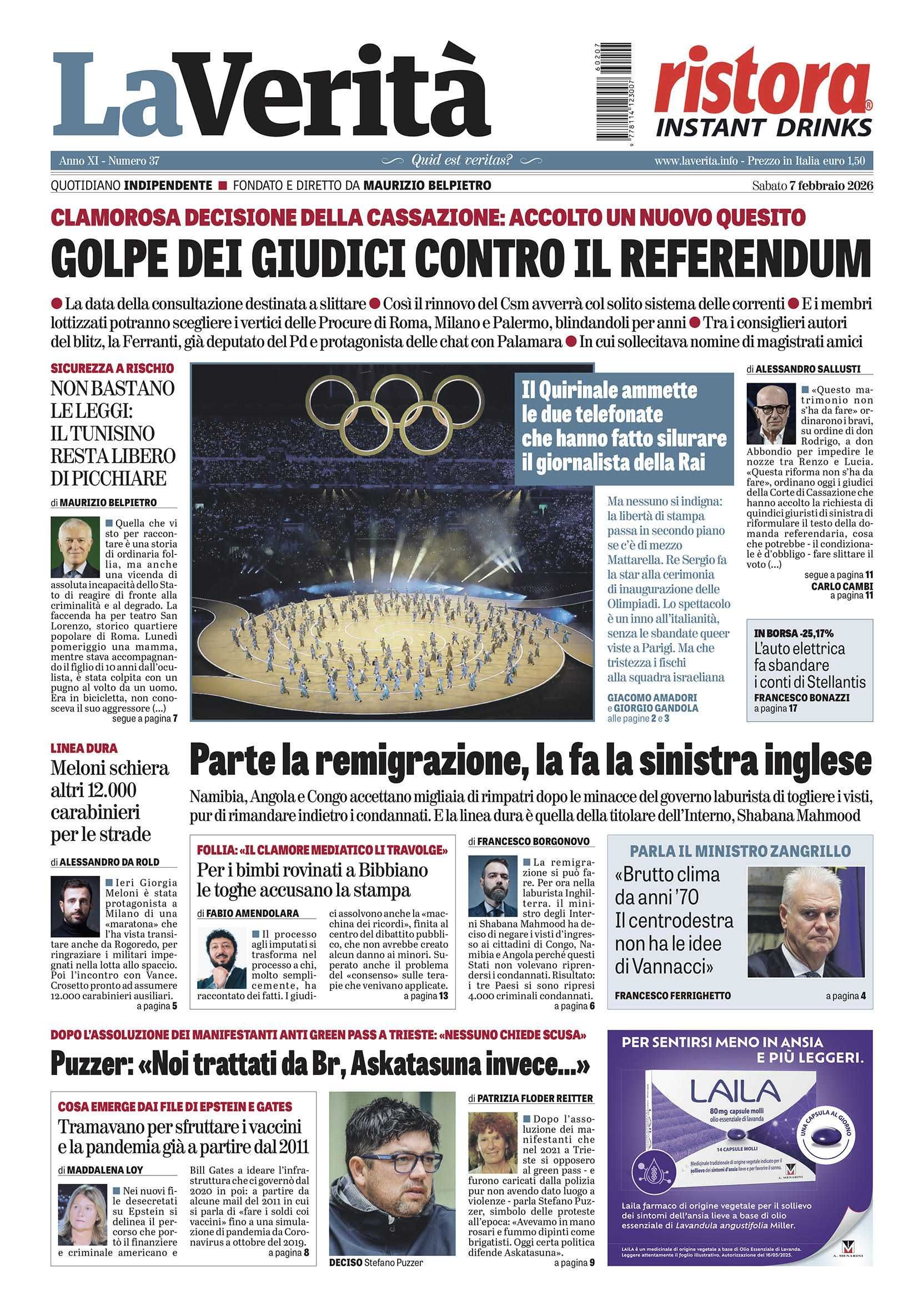True
2024-02-26
Giovane, «scorretto» e conservatore. Viaggio nel cattolicesimo africano
«L’Africa è il futuro del cattolicesimo». Non è la strampalata profezia di qualche buontempone, bensì il titolo di un pezzo uscito un anno fa sul laicissimo Le Monde a firma di Gaétan Supertino, il quale non ha che ripreso un pensiero comune: quello secondo cui la culla del cristianesimo che verrà si trova ora in quello che, dopo l’Asia, è il secondo continente del mondo e, in assoluto, quello con l’avvenire demografico più florido. Non a caso, avendo il 60% della sua popolazione di età inferiore ai 25 anni, l’Africa si è già guadagnata il titolo di «isola-Continente di Peter Pan», come notato da padre Giovanni Sale, docente di Storia della Chiesa contemporanea nella Pontificia università gregoriana di Roma; in tempi in cui quella della demografia sta diventando una legge sempre più decisiva, questo rende il continente nero un’area del pianeta che avrà sempre maggior peso.
A tal proposito, lo scorso ottobre il New York Times ha pubblicato un servizio di Declan Walsh in cui si notava come, mentre «i tassi di natalità stanno crollando nelle nazioni più ricche, creando ansia su come prendersi cura e finanziare le loro società che invecchiano, il baby boom africano continua a ritmo sostenuto, alimentando la popolazione più giovane e in più rapida crescita del pianeta». Walsh rilevava altresì come l’Africa sia demograficamente in vantaggio pure sugli altri giganti del pianeta, che - approfittando del declino dell’Occidente - si candidano ad avere un ruolo di leadership, dato che nel continente «l’età media è di 19 anni. In India, il Paese più popoloso del mondo, è di 28 anni. In Cina e negli Stati Uniti è di 38 anni». Di questo passo, entro il 2100 gli africani, che potrebbero essere più di 4 miliardi, costituiranno quasi il 40% della popolazione mondiale.
Dunque davvero da quel continente passa -e passerà - il futuro del pianeta; il punto, tornando a noi, è che in esso si gioca pure il destino del cristianesimo, i cui dati di crescita sono semplicemente impressionanti. Se infatti nel 1881 il grande missionario Daniele Comboni moriva a Khartum, in Sudan, dopo aver dato uno straordinario impulso all’evangelizzazione del continente, durante il XX secolo, la popolazione cattolica dell’Africa sub-sahariana è passata da 1,9 milioni a oltre 130 milioni - con un tasso di crescita di quasi 7%. Un ritmo sbalorditivo considerando che, a ridosso della vita di Gesù Cristo, l’allora nuova religione avanzava ogni anno del 3,5%. Ciò ha fatto sì che, se gli africani avevano iniziato il secolo scorso che erano appena dell’1% della popolazione cattolica mondiale, hanno salutato l’alba del terzo millennio essendone divenuti circa il 16%.
Un’esplosione spinta sia dalle conversioni sia dalle vocazioni. Basti dire che, se nel 1960 soltanto 2.087 seminaristi africani si preparavano per il sacerdozio, nel 2011 quel numero era salito a 27.483, con un aumento di oltre il 1.200%. Significa che mentre i seminari europei, sull’onda lunga di quel 1968 che ha contaminato anche la Chiesa - come denunciato coraggiosamente da Joseph Ratzinger - si svuotavano a ritmo crescente, in quelli africani registravano una impennata di vocazioni. Attualmente, su una popolazione mondiale di 1,36 miliardi di cattolici, gli africani sono 236 milioni, pari al 20% del totale; ma in realtà potrebbe ancora trattarsi di una sottostima, rispetto al dato effettivo. Il perché lo spiegava quasi un decennio fa il grande sociologo delle religioni Rodney Stark, che rilevava come «sul cattolicesimo africano» ci sia «un profondo mistero» perché «per molti Paesi africani le statistiche ufficiali riportano un numero molto inferiore di fedeli rispetto al numero indicato dai sondaggi Gallup».
«La spiegazione migliore cui sono riuscito ad arrivare», aggiungeva Stark per spiegare detto «mistero», «è che la crescita» dei cattolici in Africa abbia «superato a tal punto la capacità dei preti locali di stare al passo con le celebrazioni di vitale importanza come battesimi, cresime e confessioni, che hanno finito col trascurare di tenere aggiornati gli archivi» (The Triumph of Faith, 2015). Questa crescita continua e perfino difficile da registrare ha portato il World Christian Database a prevedere che, se oggi l’Africa ospita come si diceva il 20% dei cattolici del mondo, entro il 2050 ne avrà il 32%: uno su tre.
Ora, per quanto possa apparire già notevole, la forza del cristianesimo che va diffondendosi nel continente nero più che nei numeri è nell’ardore della fede. «I cattolici africani non stanno semplicemente crescendo di numero», ha osservato Stan Chu Ilo, docente ricercatore di cristianesimo mondiale e studi africani presso il Center for World Catholicism and Intercultural Theology della DePaul University di Chicago, «stanno reinventando e reinterpretando il cristianesimo. Lo stanno infondendo con un nuovo linguaggio e vitalità spirituale attraverso modi unici di adorare Dio». Rispetto alla dottrina, molti si sono resi conto dell’attenzione alla morale della Chiesa africana solo alla luce della sua recente opposizione al documento Fiducia Supplicans sulle benedizioni delle coppie irregolari, omosessuali incluse, ma in realtà è una sua caratteristica da tempo e non riducibile ad alcuni suoi esponenti conservatori, il più noto dei quali è senza dubbio il cardinale Robert Sarah.
Non per nulla, in un articolo del febbraio 2023 sul settimanale Mail & Guardian, Russell Pollitt, direttore dell’Istituto dei gesuiti del Sud Africa, avvisava: «I vescovi africani saranno d’accordo con Francesco su diverse questioni che spesso affronta: povertà, cura dell’ambiente, ingiustizia sociale, corruzione e guerra. Tuttavia, molti di questi prelati si opporranno e resteranno fermi contro le istanze progressiste di Francesco. Ciò è particolarmente chiaro quando si tratta di questioni come l’omosessualità, la struttura della chiesa e il ruolo delle donne». Un ammonimento che, con la pubblicazione di Fiducia Supplicans appunto, si è rivelato quanto mai fondato; non è finita. Un altro tratto della giovane Chiesa d’Africa - forse il più significativo - è quello di essere, oltre che povera ed ancorata alla dottrina, martire. A differenza delle comunità cattoliche occidentali, pronte alle «aperture» su rivendicazioni Lgbt, divorziati risposati, ecc. - ma ridotte al lumicino in chiese desertificate - le comunità africane che tengono il punto sulla morale sono infatti pure quelle nel mirino del fondamentalismo islamico, e che testimoniano la fede col sangue.
L’esempio più lampante è la Nigeria, Paese nel mondo dove, secondo Open Doors, è stata massacrata la grandissima parte dei cristiani morti uccisi nel 2023 - 4.118 su 4.998 -, nonché quello col maggior numero di cristiani rapiti - 3.300 su 3.906 - e che ha visto attacchi a qualcosa come 750 chiese: in pratica, più di due al giorno. Numeri sconvolgenti, ma che potrebbero ancora esser sottostime. Secondo l’International Society for civil liberties and rule of law (Intersociety), infatti, i cristiani nigeriani uccisi lo scorso anno sarebbero addirittura oltre 8.000 (8.222); per questo Crux ha scritto che «in Nigeria c’è un “genocidio silenzioso” contro i cristiani».
Eppure, secondo i dati del Center for applied research in the apostolate (Cara) della Georgetown University, la Nigeria è pure il Paese dove i cristiani vanno più a Messa in tutto il pianeta, con un incredibile 94% di cattolici adulti che dichiara di parteciparvi almeno una volta la settimana. Con buona pace delle gerarchie ecclesiastiche che ancora guardano a Berlino, Parigi o a Washington, il cristianesimo del futuro - ma forse già del presente - è dunque quello d’Africa: povero, in crescita, giovanissimo e pronto al martirio. Ex Africa semper aliquid novi, diceva già Plinio il Vecchio, «dall’Africa c’è sempre qualcosa di nuovo». 2.000 anni dopo resta più vero che mai, specie per la Chiesa.
«Le stragi islamiche non svuotano le chiese»
Tra i tanti in Italia, che a livello politico e non solo, da qualche tempo si occupano del tema dell’Africa, di fatto pochi possono vantarne - specie con riferimento ad uno stato chiave come Nigeria - la conoscenza diretta di Emmanuele Di Leo. Classe 1979, romano, fondatore e Presidente dell’organizzazione umanitaria, Steadfast (www.steadfast.ngo), Di Leo si reca difatti regolarmente in quello che da molti osservatori è ritenuto il «Continente del futuro» e, proprio per questo, La Verità l’ha contattato.
Di Leo, cosa ricorda del suo primo viaggio in Nigeria?
«Ci sono stato frequentemente, sono arrivato ad andarci fino a sette volte l’anno, ma ricordo bene il primo impatto con quel Paese. Era il 2011, compresi con una domanda futile al mio interlocutore che l’approccio che avrei dovuto avere con l’Africa non doveva essere occidentale, dovevo rimodulare il mio stile di vita su quello africano, ricominciando come un bambino a conoscere una nuova cultura per potermi integrare. La domanda che feci - ero appena arrivato ed era circa mezzogiorno - fu: “Ma qui a che ora si mangia?”. Mi fu prontamente risposto: “Ecco la prima regola qui in Africa: si mangia quando hai fame e c’è cibo”. Fu per me una gran lezione».
Perché?
«Sentii che dovevo dismettere i panni dell’occidentale che dall’alto della sua cultura si pone sul piedistallo, dando tutto per scontato. Perché non sempre è così. Come dal punto di vista valoriale, al contrario ad oggi sono proprio gli africani a detenere la difesa di alcuni valori, come la famiglia e il senso di comunità».
Come Steadfast che attività promuovete?
«Stiamo finalmente realizzando, dopo nove anni di fatiche - compreso il Covid - anche per ottenere i permessi necessari, un politecnico universitario, poi abbiamo un piccolo ospedale con 20 posti letto, due scuole, tre orfanotrofi con circa 800 bambini. Pilastro fondamentale della nostra azione è l’educazione. Vogliamo offrire ai ragazzi dei villaggi, scuole di primo grado, di secondo grado e università, così da garantir loro una professionalità completa per cambiare i territori in cui vivono, e poi c’erano le officine metalmeccaniche».
C’erano?
«Sì, perché queste officine, per realizzare le quali avevamo anche portato in Italia per un congruo periodo di formazione professionale 70 giovani nigeriani, nel 2019 sono state completamente distrutte dai pastori fulani, che, come Attila, dove passano lasciano macerie e distruzione».
Chi sono i fulani?
«Sono un’etnia nomade di pastori musulmani, nascono in Medio Oriente e hanno iniziato ad attecchire nel nord della Nigeria ed in altri Paesi africani. Si muovono con la scusa del cambiamento climatico, con la chiara intenzione di “fulanizzare” tutta la Nigeria. Evidente mira espansionistica per avere un loro Stato, nello specifico ricco di materie prime - diamanti, oro, rame, legname, eccetera - e privo di cristiani».
Eppure, nonostante le minacce e spesso le carneficine compiute dagli estremisti islamici, i cristiani nigeriani sono quelli che, nel mondo, vanno più a messa. Una lezione per la fede spesso stanca dell’Occidente?
«Assolutamente sì. Ricollegandomi alla prima volta che ho messo piede in Africa, una delle cose che mi ha sempre colpito della scala valoriale della vita di un nigeriano è che, prima di ogni cosa, viene Dio. Nel 2018 ho poi assistito ad evento che mi ha colpito molto. Mi avevano portato a conoscere un giovane sacerdote molto in gamba, padre Mbaka - le sue omelie, pensi, vengono ascoltate in città e nei villaggi, ad alto volume -, a uno dei due eventi che organizza ogni settimana, uno la domenica mattina e l’altro il giovedì, è una veglia notturna. Sono rimasto impressionato: avrò avuto davanti a me 40.000 persone, la maggior parte giovani che, circondando un altare con il Santissimo esposto per tutta la notte, formavano una sorta di palazzetto dello sport. Si pregava, si parlava di attualità, si cantava. Insomma, era una sorta di “rave cristiano”».
C’è quindi una fede ardente da quelle parti.
«Le messe durano tre o quattro ore e lì l’offertorio è molto essenziale e pratico, c’è sì chi porge denaro ma pure, per dirle, chi porta la gallina o una capra. Ognuno offre quel che può».
A proposito di Africa, che cosa pensa del piano Mattei?
«Ne sono un sostenitore convinto. Se da un lato l’Occidente si è storicamente posto sul piedistallo rispetto all’Africa, peraltro con esiti tutt’altro che felici - basti vedere ai risultati fallimentari della Francia in Sahel, dove la destabilizzazione è evidente -, dall’altro ora è in atto un cambiamento di visione nei confronti del nostro Paese. L’aspettativa è altissima, c’è una grande speranza da parte dei governi, anche se poi è normale, come abbiamo visto nella conferenza Italia-Africa, che ci sia anche un sentimento di timore di fronte al rischio dell’ennesima colonizzazione. Ma se Giorgia Meloni continua sulla strada intrapresa, di un lavoro alla pari, non predatorio, ma cooperativo per costruire un’Africa nuova - ma anche un’Europa nuova, perché l’Africa può dare molto all’Europa - sarà la chiave vincente. Sono quasi convinto che da qui a 10 anni questa politica estera farà sì che l’Italia sarà in collaborazione feconda con la maggior parte dei Paesi africani».
Cosa risponde a chi dice che il piano Mattei sarebbe una sorta di scatola vuota?
«Chi dice questo è il classico venditore di fumo e non conosce la materia, perché questo è un piano mastodontico ed epocale che ha bisogno di tempo. Chiaro, non è qualcosa di semplice da realizzarsi, ma a me non sembra affatto vuoto, anzi; né mi pare che il premier Meloni si muova in modo inconcludente, tutt’altro, come per esempio insegnano gli accordi sul gas con l’Algeria. Di questo passo, sullo scacchiere europeo l’Italia potrebbe diventare la nuova Germania».
Pio XII già denunciava la propaganda atea degli ex colonizzatori
Se da una parte è indubbio, numeri alla mano, come l’Africa abbia oggi già in grembo il cristianesimo del futuro, dall’altra sarebbe storicamente sbagliato immaginare il legame tra questo grande continente e la Chiesa come qualcosa di nuovo. Anche se in pochi lo sanno, infatti, degli oltre 200 pontefici susseguitisi dopo san Pietro, la Chiesa - peraltro quella dei primi secoli - ha già avuto non uno, bensì tre papi africani. Si tratta di san Vittore I (189-201), san Milziade (311-314) e Gelasio I (492-496). Lo stesso Agostino d’Ippona (354-430), santo d’importanza eccezionale per i cristiani, nacque com’è noto a Tagaste, città africana, e, precisamente, algerina.
Tutte queste figure, a ben vedere, dicono molto del rilievo che, fin dalla fine del secondo secolo, la Chiesa africana doveva avere per Roma. Prima con i Vandali e a seguire, poi, con l’invasione musulmana, per il grande continente a sud del Mediterraneo venne però un periodo di grande eclissi, che lo portò a lungo fuori dai radar della latinità e della cristianità. Il rapporto tra Roma e l’Africa si è riallacciato dapprima grazie all’infaticabile opera dei missionari e poi con la progressiva organizzazione dell’episcopato africano, con gli stessi pontefici, specie dopo la Seconda Guerra Mondiale, che sono tornati ad occuparsi direttamente della terra africana, vista come un tesoro per tutta la Chiesa cattolica.
Basti vedere cosa scriveva nella sua lettera enciclica Fidei Donum del 21 aprile 1957 papa Eugenio Pacelli, allorquando sottolineava che «l’espansione della Chiesa in Africa durante gli ultimi decenni ha da essere senza dubbio, per i cristiani, motivo di gioia e di fierezza» non senza denunciare - con straordinario anticipo sui tempi - quella che oggi si potrebbe chiamare una colonizzazione ideologica da parte dell’Occidente. «In molte regioni dell’Africa», scriveva infatti sempre Pio XII, «vengono diffusi i germi di turbolenze dai seguaci del “materialismo” ateo, i quali attizzano le passioni, eccitano l’odio d’un popolo contro l’altro, sfruttano alcune tristi condizioni per sedurre gli spiriti con fallaci miraggi per seminare la ribellione nei cuori».
Un evento significativo nel riallacciare i rapporti tra Roma e l’Africa avvenne poi nel marzo del 1960, quando papa Giovanni XXIII elevò il tanzaniano Laurean Rugambwa a primo cardinale africano della storia contemporanea. Il 31 luglio 1969, nella celebrazione eucaristica a conclusione del Symposium dei vescovi dell’Africa, rilevanti furono inoltre le parole di papa Paolo VI, che disse: «La Chiesa africana ha davanti a sé un compito originale ed immenso: essa deve rivolgersi come una “madre e maestra” a tutti i figli di questa terra del sole». Questa «terra del sole» entrò anche nel cuore di Karol Wojtyla, il quale in Africa fece numerosissimi apostolici, toccando ben 41 dei 56 Stati - cinque per due volte, e due per tre volte - che compongono l’immenso continente da oltre 1,2 miliardi di abitanti.
Prima di papa Francesco - che lo scorso anno ha compiuto un pellegrinaggio di pace nella Repubblica democratica del Congo e in sud Sudan -, del grande continente si è occupato anche Benedetto XVI, che nell’omelia tenuta domenica 4 ottobre 2009 ha affermato che «l’Africa rappresenta un immenso “polmone” spirituale, per un’umanità che appare in crisi di fede e di speranza». Le dimensioni di questo «“polmone” spirituale», come mettono in luce gli indicatori demografici, risultano davvero già oggi notevoli; e in futuro lo saranno ancor di più.
Continua a leggereRiduci
Sacerdoti e battezzati crescono a ritmi sbalorditivi, al punto che nel 2050 un fedele su tre vivrà nel continente. E a differenza della vecchia Europa, la loro fede resta ancorata alla dottrina, come mostra l’opposizione (trasversale) alle benedizioni delle coppie gay.Il fondatore dell’associazione Steadfast Emmanuele Di Leo: «In Nigeria le messe durano tre o quattro ore, ho visto anche veglie notturne durante la settimana partecipate da migliaia di ragazzi. Col piano Mattei finalmente l’Europa tratta i suoi interlocutori da pari a pari».Da Pio XII in poi i papi del Novecento «riscoprirono» la «terra del sole». Wojtyla viaggiò in 41 dei 56 Stati.Lo speciale contiene tre articoli.«L’Africa è il futuro del cattolicesimo». Non è la strampalata profezia di qualche buontempone, bensì il titolo di un pezzo uscito un anno fa sul laicissimo Le Monde a firma di Gaétan Supertino, il quale non ha che ripreso un pensiero comune: quello secondo cui la culla del cristianesimo che verrà si trova ora in quello che, dopo l’Asia, è il secondo continente del mondo e, in assoluto, quello con l’avvenire demografico più florido. Non a caso, avendo il 60% della sua popolazione di età inferiore ai 25 anni, l’Africa si è già guadagnata il titolo di «isola-Continente di Peter Pan», come notato da padre Giovanni Sale, docente di Storia della Chiesa contemporanea nella Pontificia università gregoriana di Roma; in tempi in cui quella della demografia sta diventando una legge sempre più decisiva, questo rende il continente nero un’area del pianeta che avrà sempre maggior peso. A tal proposito, lo scorso ottobre il New York Times ha pubblicato un servizio di Declan Walsh in cui si notava come, mentre «i tassi di natalità stanno crollando nelle nazioni più ricche, creando ansia su come prendersi cura e finanziare le loro società che invecchiano, il baby boom africano continua a ritmo sostenuto, alimentando la popolazione più giovane e in più rapida crescita del pianeta». Walsh rilevava altresì come l’Africa sia demograficamente in vantaggio pure sugli altri giganti del pianeta, che - approfittando del declino dell’Occidente - si candidano ad avere un ruolo di leadership, dato che nel continente «l’età media è di 19 anni. In India, il Paese più popoloso del mondo, è di 28 anni. In Cina e negli Stati Uniti è di 38 anni». Di questo passo, entro il 2100 gli africani, che potrebbero essere più di 4 miliardi, costituiranno quasi il 40% della popolazione mondiale. Dunque davvero da quel continente passa -e passerà - il futuro del pianeta; il punto, tornando a noi, è che in esso si gioca pure il destino del cristianesimo, i cui dati di crescita sono semplicemente impressionanti. Se infatti nel 1881 il grande missionario Daniele Comboni moriva a Khartum, in Sudan, dopo aver dato uno straordinario impulso all’evangelizzazione del continente, durante il XX secolo, la popolazione cattolica dell’Africa sub-sahariana è passata da 1,9 milioni a oltre 130 milioni - con un tasso di crescita di quasi 7%. Un ritmo sbalorditivo considerando che, a ridosso della vita di Gesù Cristo, l’allora nuova religione avanzava ogni anno del 3,5%. Ciò ha fatto sì che, se gli africani avevano iniziato il secolo scorso che erano appena dell’1% della popolazione cattolica mondiale, hanno salutato l’alba del terzo millennio essendone divenuti circa il 16%. Un’esplosione spinta sia dalle conversioni sia dalle vocazioni. Basti dire che, se nel 1960 soltanto 2.087 seminaristi africani si preparavano per il sacerdozio, nel 2011 quel numero era salito a 27.483, con un aumento di oltre il 1.200%. Significa che mentre i seminari europei, sull’onda lunga di quel 1968 che ha contaminato anche la Chiesa - come denunciato coraggiosamente da Joseph Ratzinger - si svuotavano a ritmo crescente, in quelli africani registravano una impennata di vocazioni. Attualmente, su una popolazione mondiale di 1,36 miliardi di cattolici, gli africani sono 236 milioni, pari al 20% del totale; ma in realtà potrebbe ancora trattarsi di una sottostima, rispetto al dato effettivo. Il perché lo spiegava quasi un decennio fa il grande sociologo delle religioni Rodney Stark, che rilevava come «sul cattolicesimo africano» ci sia «un profondo mistero» perché «per molti Paesi africani le statistiche ufficiali riportano un numero molto inferiore di fedeli rispetto al numero indicato dai sondaggi Gallup».«La spiegazione migliore cui sono riuscito ad arrivare», aggiungeva Stark per spiegare detto «mistero», «è che la crescita» dei cattolici in Africa abbia «superato a tal punto la capacità dei preti locali di stare al passo con le celebrazioni di vitale importanza come battesimi, cresime e confessioni, che hanno finito col trascurare di tenere aggiornati gli archivi» (The Triumph of Faith, 2015). Questa crescita continua e perfino difficile da registrare ha portato il World Christian Database a prevedere che, se oggi l’Africa ospita come si diceva il 20% dei cattolici del mondo, entro il 2050 ne avrà il 32%: uno su tre. Ora, per quanto possa apparire già notevole, la forza del cristianesimo che va diffondendosi nel continente nero più che nei numeri è nell’ardore della fede. «I cattolici africani non stanno semplicemente crescendo di numero», ha osservato Stan Chu Ilo, docente ricercatore di cristianesimo mondiale e studi africani presso il Center for World Catholicism and Intercultural Theology della DePaul University di Chicago, «stanno reinventando e reinterpretando il cristianesimo. Lo stanno infondendo con un nuovo linguaggio e vitalità spirituale attraverso modi unici di adorare Dio». Rispetto alla dottrina, molti si sono resi conto dell’attenzione alla morale della Chiesa africana solo alla luce della sua recente opposizione al documento Fiducia Supplicans sulle benedizioni delle coppie irregolari, omosessuali incluse, ma in realtà è una sua caratteristica da tempo e non riducibile ad alcuni suoi esponenti conservatori, il più noto dei quali è senza dubbio il cardinale Robert Sarah.Non per nulla, in un articolo del febbraio 2023 sul settimanale Mail & Guardian, Russell Pollitt, direttore dell’Istituto dei gesuiti del Sud Africa, avvisava: «I vescovi africani saranno d’accordo con Francesco su diverse questioni che spesso affronta: povertà, cura dell’ambiente, ingiustizia sociale, corruzione e guerra. Tuttavia, molti di questi prelati si opporranno e resteranno fermi contro le istanze progressiste di Francesco. Ciò è particolarmente chiaro quando si tratta di questioni come l’omosessualità, la struttura della chiesa e il ruolo delle donne». Un ammonimento che, con la pubblicazione di Fiducia Supplicans appunto, si è rivelato quanto mai fondato; non è finita. Un altro tratto della giovane Chiesa d’Africa - forse il più significativo - è quello di essere, oltre che povera ed ancorata alla dottrina, martire. A differenza delle comunità cattoliche occidentali, pronte alle «aperture» su rivendicazioni Lgbt, divorziati risposati, ecc. - ma ridotte al lumicino in chiese desertificate - le comunità africane che tengono il punto sulla morale sono infatti pure quelle nel mirino del fondamentalismo islamico, e che testimoniano la fede col sangue.L’esempio più lampante è la Nigeria, Paese nel mondo dove, secondo Open Doors, è stata massacrata la grandissima parte dei cristiani morti uccisi nel 2023 - 4.118 su 4.998 -, nonché quello col maggior numero di cristiani rapiti - 3.300 su 3.906 - e che ha visto attacchi a qualcosa come 750 chiese: in pratica, più di due al giorno. Numeri sconvolgenti, ma che potrebbero ancora esser sottostime. Secondo l’International Society for civil liberties and rule of law (Intersociety), infatti, i cristiani nigeriani uccisi lo scorso anno sarebbero addirittura oltre 8.000 (8.222); per questo Crux ha scritto che «in Nigeria c’è un “genocidio silenzioso” contro i cristiani».Eppure, secondo i dati del Center for applied research in the apostolate (Cara) della Georgetown University, la Nigeria è pure il Paese dove i cristiani vanno più a Messa in tutto il pianeta, con un incredibile 94% di cattolici adulti che dichiara di parteciparvi almeno una volta la settimana. Con buona pace delle gerarchie ecclesiastiche che ancora guardano a Berlino, Parigi o a Washington, il cristianesimo del futuro - ma forse già del presente - è dunque quello d’Africa: povero, in crescita, giovanissimo e pronto al martirio. Ex Africa semper aliquid novi, diceva già Plinio il Vecchio, «dall’Africa c’è sempre qualcosa di nuovo». 2.000 anni dopo resta più vero che mai, specie per la Chiesa.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/cattolicesimo-africa-futuro-2667364704.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="le-stragi-islamiche-non-svuotano-le-chiese" data-post-id="2667364704" data-published-at="1708948209" data-use-pagination="False"> «Le stragi islamiche non svuotano le chiese» Tra i tanti in Italia, che a livello politico e non solo, da qualche tempo si occupano del tema dell’Africa, di fatto pochi possono vantarne - specie con riferimento ad uno stato chiave come Nigeria - la conoscenza diretta di Emmanuele Di Leo. Classe 1979, romano, fondatore e Presidente dell’organizzazione umanitaria, Steadfast (www.steadfast.ngo), Di Leo si reca difatti regolarmente in quello che da molti osservatori è ritenuto il «Continente del futuro» e, proprio per questo, La Verità l’ha contattato. Di Leo, cosa ricorda del suo primo viaggio in Nigeria? «Ci sono stato frequentemente, sono arrivato ad andarci fino a sette volte l’anno, ma ricordo bene il primo impatto con quel Paese. Era il 2011, compresi con una domanda futile al mio interlocutore che l’approccio che avrei dovuto avere con l’Africa non doveva essere occidentale, dovevo rimodulare il mio stile di vita su quello africano, ricominciando come un bambino a conoscere una nuova cultura per potermi integrare. La domanda che feci - ero appena arrivato ed era circa mezzogiorno - fu: “Ma qui a che ora si mangia?”. Mi fu prontamente risposto: “Ecco la prima regola qui in Africa: si mangia quando hai fame e c’è cibo”. Fu per me una gran lezione». Perché? «Sentii che dovevo dismettere i panni dell’occidentale che dall’alto della sua cultura si pone sul piedistallo, dando tutto per scontato. Perché non sempre è così. Come dal punto di vista valoriale, al contrario ad oggi sono proprio gli africani a detenere la difesa di alcuni valori, come la famiglia e il senso di comunità». Come Steadfast che attività promuovete? «Stiamo finalmente realizzando, dopo nove anni di fatiche - compreso il Covid - anche per ottenere i permessi necessari, un politecnico universitario, poi abbiamo un piccolo ospedale con 20 posti letto, due scuole, tre orfanotrofi con circa 800 bambini. Pilastro fondamentale della nostra azione è l’educazione. Vogliamo offrire ai ragazzi dei villaggi, scuole di primo grado, di secondo grado e università, così da garantir loro una professionalità completa per cambiare i territori in cui vivono, e poi c’erano le officine metalmeccaniche». C’erano? «Sì, perché queste officine, per realizzare le quali avevamo anche portato in Italia per un congruo periodo di formazione professionale 70 giovani nigeriani, nel 2019 sono state completamente distrutte dai pastori fulani, che, come Attila, dove passano lasciano macerie e distruzione». Chi sono i fulani? «Sono un’etnia nomade di pastori musulmani, nascono in Medio Oriente e hanno iniziato ad attecchire nel nord della Nigeria ed in altri Paesi africani. Si muovono con la scusa del cambiamento climatico, con la chiara intenzione di “fulanizzare” tutta la Nigeria. Evidente mira espansionistica per avere un loro Stato, nello specifico ricco di materie prime - diamanti, oro, rame, legname, eccetera - e privo di cristiani». Eppure, nonostante le minacce e spesso le carneficine compiute dagli estremisti islamici, i cristiani nigeriani sono quelli che, nel mondo, vanno più a messa. Una lezione per la fede spesso stanca dell’Occidente? «Assolutamente sì. Ricollegandomi alla prima volta che ho messo piede in Africa, una delle cose che mi ha sempre colpito della scala valoriale della vita di un nigeriano è che, prima di ogni cosa, viene Dio. Nel 2018 ho poi assistito ad evento che mi ha colpito molto. Mi avevano portato a conoscere un giovane sacerdote molto in gamba, padre Mbaka - le sue omelie, pensi, vengono ascoltate in città e nei villaggi, ad alto volume -, a uno dei due eventi che organizza ogni settimana, uno la domenica mattina e l’altro il giovedì, è una veglia notturna. Sono rimasto impressionato: avrò avuto davanti a me 40.000 persone, la maggior parte giovani che, circondando un altare con il Santissimo esposto per tutta la notte, formavano una sorta di palazzetto dello sport. Si pregava, si parlava di attualità, si cantava. Insomma, era una sorta di “rave cristiano”». C’è quindi una fede ardente da quelle parti. «Le messe durano tre o quattro ore e lì l’offertorio è molto essenziale e pratico, c’è sì chi porge denaro ma pure, per dirle, chi porta la gallina o una capra. Ognuno offre quel che può». A proposito di Africa, che cosa pensa del piano Mattei? «Ne sono un sostenitore convinto. Se da un lato l’Occidente si è storicamente posto sul piedistallo rispetto all’Africa, peraltro con esiti tutt’altro che felici - basti vedere ai risultati fallimentari della Francia in Sahel, dove la destabilizzazione è evidente -, dall’altro ora è in atto un cambiamento di visione nei confronti del nostro Paese. L’aspettativa è altissima, c’è una grande speranza da parte dei governi, anche se poi è normale, come abbiamo visto nella conferenza Italia-Africa, che ci sia anche un sentimento di timore di fronte al rischio dell’ennesima colonizzazione. Ma se Giorgia Meloni continua sulla strada intrapresa, di un lavoro alla pari, non predatorio, ma cooperativo per costruire un’Africa nuova - ma anche un’Europa nuova, perché l’Africa può dare molto all’Europa - sarà la chiave vincente. Sono quasi convinto che da qui a 10 anni questa politica estera farà sì che l’Italia sarà in collaborazione feconda con la maggior parte dei Paesi africani». Cosa risponde a chi dice che il piano Mattei sarebbe una sorta di scatola vuota? «Chi dice questo è il classico venditore di fumo e non conosce la materia, perché questo è un piano mastodontico ed epocale che ha bisogno di tempo. Chiaro, non è qualcosa di semplice da realizzarsi, ma a me non sembra affatto vuoto, anzi; né mi pare che il premier Meloni si muova in modo inconcludente, tutt’altro, come per esempio insegnano gli accordi sul gas con l’Algeria. Di questo passo, sullo scacchiere europeo l’Italia potrebbe diventare la nuova Germania». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/cattolicesimo-africa-futuro-2667364704.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="pio-xii-gia-denunciava-la-propaganda-atea-degli-ex-colonizzatori" data-post-id="2667364704" data-published-at="1708948209" data-use-pagination="False"> Pio XII già denunciava la propaganda atea degli ex colonizzatori Se da una parte è indubbio, numeri alla mano, come l’Africa abbia oggi già in grembo il cristianesimo del futuro, dall’altra sarebbe storicamente sbagliato immaginare il legame tra questo grande continente e la Chiesa come qualcosa di nuovo. Anche se in pochi lo sanno, infatti, degli oltre 200 pontefici susseguitisi dopo san Pietro, la Chiesa - peraltro quella dei primi secoli - ha già avuto non uno, bensì tre papi africani. Si tratta di san Vittore I (189-201), san Milziade (311-314) e Gelasio I (492-496). Lo stesso Agostino d’Ippona (354-430), santo d’importanza eccezionale per i cristiani, nacque com’è noto a Tagaste, città africana, e, precisamente, algerina. Tutte queste figure, a ben vedere, dicono molto del rilievo che, fin dalla fine del secondo secolo, la Chiesa africana doveva avere per Roma. Prima con i Vandali e a seguire, poi, con l’invasione musulmana, per il grande continente a sud del Mediterraneo venne però un periodo di grande eclissi, che lo portò a lungo fuori dai radar della latinità e della cristianità. Il rapporto tra Roma e l’Africa si è riallacciato dapprima grazie all’infaticabile opera dei missionari e poi con la progressiva organizzazione dell’episcopato africano, con gli stessi pontefici, specie dopo la Seconda Guerra Mondiale, che sono tornati ad occuparsi direttamente della terra africana, vista come un tesoro per tutta la Chiesa cattolica. Basti vedere cosa scriveva nella sua lettera enciclica Fidei Donum del 21 aprile 1957 papa Eugenio Pacelli, allorquando sottolineava che «l’espansione della Chiesa in Africa durante gli ultimi decenni ha da essere senza dubbio, per i cristiani, motivo di gioia e di fierezza» non senza denunciare - con straordinario anticipo sui tempi - quella che oggi si potrebbe chiamare una colonizzazione ideologica da parte dell’Occidente. «In molte regioni dell’Africa», scriveva infatti sempre Pio XII, «vengono diffusi i germi di turbolenze dai seguaci del “materialismo” ateo, i quali attizzano le passioni, eccitano l’odio d’un popolo contro l’altro, sfruttano alcune tristi condizioni per sedurre gli spiriti con fallaci miraggi per seminare la ribellione nei cuori». Un evento significativo nel riallacciare i rapporti tra Roma e l’Africa avvenne poi nel marzo del 1960, quando papa Giovanni XXIII elevò il tanzaniano Laurean Rugambwa a primo cardinale africano della storia contemporanea. Il 31 luglio 1969, nella celebrazione eucaristica a conclusione del Symposium dei vescovi dell’Africa, rilevanti furono inoltre le parole di papa Paolo VI, che disse: «La Chiesa africana ha davanti a sé un compito originale ed immenso: essa deve rivolgersi come una “madre e maestra” a tutti i figli di questa terra del sole». Questa «terra del sole» entrò anche nel cuore di Karol Wojtyla, il quale in Africa fece numerosissimi apostolici, toccando ben 41 dei 56 Stati - cinque per due volte, e due per tre volte - che compongono l’immenso continente da oltre 1,2 miliardi di abitanti. Prima di papa Francesco - che lo scorso anno ha compiuto un pellegrinaggio di pace nella Repubblica democratica del Congo e in sud Sudan -, del grande continente si è occupato anche Benedetto XVI, che nell’omelia tenuta domenica 4 ottobre 2009 ha affermato che «l’Africa rappresenta un immenso “polmone” spirituale, per un’umanità che appare in crisi di fede e di speranza». Le dimensioni di questo «“polmone” spirituale», come mettono in luce gli indicatori demografici, risultano davvero già oggi notevoli; e in futuro lo saranno ancor di più.
iStock
Verdura antica e di poco costo («tre palanche al mazz»), il ramolaccio un tempo era assai più diffuso. Poi, come accade ai poveri in un Paese diventato ricco, il ramolaccio è finito ai margini della società orticola che mira più ai consumi nei supermercati che al bene prezioso della biodiversità.
Originario dell’Est dell’Europa, conosciuto già da Egizi, Greci e Romani che lo apprezzavano per le notevoli proprietà salutari, il ramolaccio invernale, Raphanus sativus, è un ravanello superdotato, di colore nero. Ci sono diverse varietà di Raphanus, differenti tra loro per forma, colore e sapore: piccole, grandi, giganti, allungate, tonde, a candela, rosse, gialle, nere. A noi, qui, interessa il niger, nero, bello grassoccio, rotondo come l’«O» di Giotto, ma con il codino. È molto bello da vedere. Anche se è un ortaggio piuttosto sconosciuto e poco coltivato, capita ancora di adocchiarlo sui banchi del mercato cittadino o in uno dei vari mercatini della terra o in un negozio di ortofrutta il cui proprietario sia particolarmente sensibile alla biodiversità. Quando, pulito dalla terra e ben lavato, si taglia a fette, il forte contrasto che oppone la scorza corvina dalla polpa candida è uno spettacolo. Notte e giorno. Neve e carbone. Corpo scuro, anima candida.
Il ramolaccio invernale è decisamente piccante e questo, presso il consumatore italiano, non depone purtroppo a suo favore. Ma è un ortaggio che fa un monte di bene e si presta a molti usi in cucina: tagliato a striscioline o a fettine sottili in carpaccio o abbinato ad altre verdure crude; cucinato come i crauti; adoperato come ingrediente per salse piccanti; conservato sotto aceto. È utilizzato anche per zuppe e pare impossibile come una radice così acre, così spicy, riesca a trasformarsi in deliziosa e morbida vellutata.
Nella civiltà contadina era famoso come rimedio naturale antitosse e antinfiammatorio per le vie respiratorie. Qualche nonna avanti con gli anni lo consiglia ancora. E non solo lei, come vedremo più sotto. Una ricetta popolare suggerisce di scavare la rapa, farcirla di zucchero o miele e lasciarla riposare per 24 ore: si ottiene così uno sciroppo naturale espettorante. Il ramolaccio invernale è noto anche per la sua capacità di drenare le tossine e stimolare la produzione di bile, migliorando la digestione dei grassi. Per questo la tradizione popolare consiglia di consumarlo dopo pasti abbondanti. Il consiglio vale anche per chi eccede con il vino. Il medico di Alessandro Magno, il pitagorico Androcide, ne consigliava l’uso al suo poco docile paziente, grande condottiero e grande bevitore, per evitare le conseguenze dannose dell’uso eccessivo del «sangue della terra». Pare che l’antico medico vissuto a cavallo tra il quarto e il terzo secolo avanti Cristo, si basasse sull’osservazione che la vite si ritraeva o non fruttava bene se piantata accanto alle coltivazioni di rafani. È Plinio il Vecchio che ci racconta l’episodio. Il suggerimento di Androcide deve funzionare se dopo 2.000 e passa anni è arrivato fino alla soglia dei nostri giorni, fino all’altroieri. Nelle osterie dei nostri nonni era facile trovare una terrina di rapanelli sul bancone di mescita come rimedio popolare contro gli effetti dell’eccesso di vino. L’usanza si basava, appunto, sull’antica convinzione che i rapanelli, grazie alle loro proprietà rinfrescanti e depurative, potessero aiutare a mitigare i postumi di una sbornia o comunque favorire il benessere dopo aver tracannato parecchio.
Oltre alle proprietà medicinali, i Romani apprezzavano le qualità alimentari del ramolaccio invernale: lo dimostrano gli scritti di Columella e dello stesso Plinio, ma anche i moderni studi storici sulle risorse alimentari delle popolazioni vesuviane compiuti, tra gli altri, da Annamaria Ciarallo, compianta archeologa e botanica, autrice di numerosi libri sul «verde» pompeiano mediante la ricostruzione degli horti in base ai calchi delle radici.
Pare che i Romani facessero anche un terribile uso improprio - almeno quando Roma viveva tempi più casti e castigati moralmente - del ramolaccio. Una legge non scritta, ma crudelmente applicata, permetteva al marito tradito, in caso di flagrante adulterio, di sodomizzare con la radice piccante di un raphanus (la storia non ne specifica la varietà, ma sicuramente non era un rapanello) l’amante della moglie colto in fallo.
Durante il Medioevo il raphanus, probabilmente per la sua piccantezza, era considerato simbolo della lite. Aveva, quindi, valore negativo ma si poteva neutralizzarlo e consumare benissimo l’ortaggio purché, prima di mangiarlo, lo si benedicesse.
Come detto, il ramolaccio invernale ha stretti legami di parentela con il ravanello (Raphanus Sativus): appartengono entrambi alla famiglia delle Brassicaceae. Il niger rispetto al cuginetto rosso ha foglie e radici molto più grandi e resiste bene al freddo. L’apparato fogliare può raggiungere i 30 cm di altezza; la radice può arrivare anche al mezzo chilo. Ci sono diversi tipi di ramolaccio invernale nero: rotondi, conici e allungati a cilindro, di grosso o medio calibro.
Per la buona presenza di vitamine e la lunga conservabilità, veniva stivato in botti sulle navi per combattere lo scorbuto, terribile malattia che affliggeva i marinai causata dalla prolungata carenza di vitamina C. A confermare i rimedi della nonna a base di ramolaccio, ci sono le attestazioni degli studiosi moderni: il raphanus stimola l’appetito, la tonicità dell’apparato respiratorio e l’attivazione delle cellule epatiche; è diuretico, antiallergico. Il ravanello nero, in particolare, è utile nel curare bronchiti, tosse convulsa, reumatismi, malattie dell’apparato genito-urinario e coliche epatiche. A quanto pare fa bene anche ai giovani che patiscono la stanchezza. Mangiare ramolacci sotto esami o nei periodi di stress scolastico o di cambio di stagione, aiuta l’organismo a tener duro. A ulteriore conferma delle virtù salutari del ramolaccio nero c’è anche un modo di dire lituano che corrisponde al nostro «sano come un pesce». Nel Paese baltico, per descrivere lo stato di ottima salute di un individuo, dicono: «È sano come un ravanello nero».
Concludiamo suggerendo il più semplice dei modi di mangiare il Raphanus sativus niger: la sua preparazione al carpaccio. Per due persone basteranno due ramolacci invernali neri di media grossezza. Dopo averli lavati - se si vuole togliere un po’ di piccantezza basta lavarli ancora sotto acqua corrente - e sbucciati (volendo si può tenere anche la buccia nera, che fa un bell’effetto, ma in questo caso si deve strofinare ben bene il rafano per togliere tutta la terra), si affettano a rondelle sottili e si stendono su un piatto di portata. A questo punto si usa il sale q.b. sul carpaccio in modo che faccia perdere all’ortaggio acqua e piccantezza. Buttata l’acqua in eccesso e benedetto il ramolaccio con una emulsione di olio d’oliva extravergine buono (due terzi), aceto balsamico (un terzo), senape e un pizzichino di pepe, il carpaccio è pronto. È un buon abbinamento per i piatti di carne.
Continua a leggereRiduci
Ovs
Sotto la sua guida, Ovs ha superato la logica della semplice insegna per evolversi in una piattaforma di marche, capace di coniugare accessibilità, qualità e identità. Una svolta costruita nel tempo, investendo su persone, stile, organizzazione e innovazione operativa, senza mai perdere di vista la sostenibilità economica per valorizzare ogni brand del gruppo, da Upim a Croff, da Stefanel a Goldenpoint. In un settore attraversato da forti discontinuità, Beraldo ha dimostrato che la crescita non è il frutto di scorciatoie, ma di una gestione coerente e di lungo periodo. È da questa traiettoria che prende le mosse questa chiacchierata con La Verità, in cui l’amministratore delegato racconta i risultati, le scelte e le priorità future di un gruppo che continua a crescere controcorrente.
In un mercato definito ancora debole, Ovs ha chiuso il 2025 con vendite in crescita del 7% e un Ebitda atteso a +11%. Che cosa vi ha permesso di fare meglio del mercato?
«Negli ultimi anni abbiamo lavorato per trasformare Ovs da semplice insegna a piattaforma di marche. Oggi il cliente non entra solo per cercare un prezzo o un prodotto funzionale, ma perché si riconosce in un’identità: Piombo, Les Copains, Altavia, B.Angel sono trattate come vere marche, con uno stile, una comunicazione e una relazione emotiva con il consumatore. A questo si aggiunge un forte lavoro sul prodotto: qualità dei materiali, attenzione ai fit, chiarezza di assortimento. È questa combinazione che ci consente di crescere più del mercato».
Tutte le insegne crescono anche nel perimetro like-for-like. È un segnale strutturale?
«In Italia il mercato non offre spinte strutturali: la crescita è il risultato di scelte molto mirate. Se cresciamo trimestre dopo trimestre è perché la progettualità messa in campo viene premiata dai clienti. Non è un automatismo, è una conquista continua».
Donna e Beauty sono indicati come i segmenti più dinamici. Perché?
«Nel womenswear cresciamo perché siamo migliorati molto rispetto al passato. Il mercato donna è fermo, ma è grande, e stiamo guadagnando quote grazie al rafforzamento del prodotto e del team stile. Nel beauty, invece, cresciamo anche perché il mercato è strutturalmente in espansione, trainato dalla skincare, e intercetta una domanda legata alla cura di sé. Ovs è diventata una destinazione riconosciuta anche per questa categoria».
Ci sono segmenti più in difficoltà?
«Se il segmento «donna» cresce leggermente e quello «uomo» rimane stabile, la fascia «kids» è in calo. La nostra risposta è duplice: da un lato riduciamo la dipendenza dal bambino grazie alla crescita della donna; dall’altro difendiamo il kidswear puntando sulla qualità, soprattutto nel neonato, dove cresciamo nonostante il mercato in contrazione».
L’apertura del primo negozio diretto in India ha dato segnali molto positivi. È l’inizio di una strategia più ampia?
«Sì. Dopo un primo tentativo in joint venture, abbiamo deciso di investire direttamente creando una filiale e un team locale. Il primo negozio sta performando molto bene e abbiamo già acquisito la location per il secondo, a Mumbai. I primi mesi confermano che l’India è pronta per un progetto strategico di Ovs».
L’Ebitda cresce nonostante l’inflazione sui costi. Quanto conta l’efficienza operativa?
«È fondamentale, ma non può sostituire il valore del prodotto. L’efficienza è una leva, ma la crescita nasce dalla capacità di offrire qualità, design e identità di marca a prezzi accessibili».
La generazione di cassa è aumentata di oltre il 20%. Come la utilizzerete?
«In modo equilibrato: investimenti, remunerazione degli azionisti e rafforzamento della struttura finanziaria. La solidità raggiunta ci consente di sostenere lo sviluppo e riconoscere il valore creato».
Parlate di innovazione digitale nelle operations. Qual è il progetto chiave?
«Non esiste un singolo progetto, ma molti interventi diffusi: logistica, previsione della domanda, distribuzione in-season e post-distribuzione. Grazie ad algoritmi avanzati possiamo riallocare i prodotti in tempo reale tra i negozi, migliorando l’efficienza e riducendo gli sprechi».
Quanto sono centrali dati e Intelligenza artificiale?
«Sono centrali soprattutto nella gestione delle scorte. L’Ia applicata ai dati ci consente di capire perché un prodotto funziona in un punto vendita e non in un altro e di intervenire in modo sempre più mirato. È utilizzata anche nei contenuti, nelle immagini e nella personalizzazione dell’esperienza cliente».
Quanto incide il fattore cambio, in particolare il dollaro?
«Molto. Chi opera nel segmento dei prezzi accessibili ed è attento alla qualità deve produrre fuori dai mercati maturi. Gran parte degli acquisti è denominata in dollari, quindi il cambio incide direttamente su costi e competitività».
Goldenpoint cresce del 10% nei primi sette mesi di consolidamento. Che ruolo avrà?
«Goldenpoint è uno dei pilastri della crescita futura. È un marchio noto, con buone posizioni retail e poca concorrenza strutturata. Siamo intervenuti sul ringiovanimento del prodotto, soprattutto in intimo e leggings, abbiamo visto una risposta immediata del mercato. Dove il prodotto è stato rinnovato, la crescita è stata evidente. Il lavoro continuerà».
Guardando al 2026, una sola priorità strategica?
«Crescita, redditività e rafforzamento del posizionamento di lungo periodo. Sono obiettivi interconnessi, non alternativi».
Continua a leggereRiduci
I risultati dell’ultima semestrale registrano ricavi per 74,3 miliardi di euro e perdite nette per 2,3 miliardi. L’utile operativo adjusted è stato di 500 milioni, il cash flow delle attività industriali è andato in negativo per 2,3 miliardi, mentre le consegne sono scese del 6% rispetto al medesimo periodo del 2024. Non è che le aspettative fossero molto migliori, ma Stellantis ha spiegato che anche per il 2026 sospenderà le previsioni, oltre a sospendere i dividendi. Qui gli analisti si aspettavano una cedola simbolica, ma non lo zero assoluto.
Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha voluto fare pulizia e ha deciso di mettere a bilancio 22,5 miliardi di oneri di ristrutturazione. Di questi, ben 14 sono per rimettersi in carreggiata negli Stati Uniti, dove la dottrina Trump, che ha tolto gli incentivi all’elettrico e penalizza le delocalizzazioni dei colossi dell’auto, ha già portato Ford e Gm a «riconvertirsi» alle benzine e a riportare in patria le produzioni spostate in Messico e in Canada. Negli Stati Uniti, primo mercato di sbocco del gruppo, le consegne di Stellantis sono scese del 25% su base annua. Mentre in Europa, c’è stato un calo un calo del 6%, spiegato con problemi nella transizione dei vari modelli. Vanno bene, invece, i mercati di Medio Oriente e Africa (+30% entrambi) e il Sud America, che cresce del 20%.
Filosa però vede una ripresa del mercato, con le consegne cresciute del 9% nel terzo trimestre del 2025 e il portafoglio ordini Usa in forte ripresa (+150% nel 2025 sul 2024). Del resto Stellantis ha investito 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti, proprio per adattarsi alle politiche di Donald Trump, e altri 10 miliardi in Europa, dove nell’ultimo anno ha lanciato dieci modelli nuovi.
Sono numeri che sembrano confermare la strategia per la quale è stato scelto, a metà dello scorso anno, un manager come Filosa: focalizzarsi sugli Usa e tenere le posizioni in Europa, ma chiarendo ai governi e a Bruxelles che, senza incentivi e regole certe, salta tutto. Il manager è stato esplicito anche ieri: «La principale differenza tra il mercato americano e quello europeo sta proprio nella regolamentazione. Noi continueremo a investire in Ue, ma potremmo fare di più ed è difficile, perché le regole imposte non sono chiare e penalizzano le case europee». Case europee, va ricordato, che però si sono già ampiamente tutelate con il ricorso a Pechino. I tedeschi di Audi, Volkswagen e Mercedes montano già componenti cinesi e Vw andrà in Cina a costruire auto, mentre chiude stabilimenti in Germania. Quanto a Stellantis, ha varato una joint venture con i cinesi di Leapmotor, che stanno invadendo il mercato italiano usando la rete vendite ex Fiat e con modelli clamorosamente simili (ma elettrici).
Filosa ha anche puntato il dito su «criticità pregresse» e su una «sovrastima del ritmo della transizione ecologica». E ha spiegato che in passato, «abbiamo tagliato costi in maniera eccessiva, licenziando ad esempio molti ingegneri che invece ci aiutano a sviluppare prodotti innovativi». Tanto che lui ha fatto subito assumere 2.000 ingegneri, ovviamente in gran parte negli Stati Uniti. Al netto della normale enfasi sugli errori dei predecessori, va ricordato che Tavares ha lasciato la guida di Stellantis il 3 dicembre 2024 con una liquidazione di quasi 80 milioni di euro e dopo aver riempito la famiglia Agnelli-Elkann di dividendi. Da allora il gruppo è stato gestito dal presidente John Elkann, che poi ha nominato Filosa il 28 maggio 2025. Elkann, che attraverso Exor controlla il 14% di Stellantis, oggi deve accettare una cura da cavallo che richiede un grosso sforzo negli Stati Uniti. Lo fa dopo aver puntato tutto su Trump, dal quale è andato in visita lo scorso primo aprile. Ora lo scherzetto anti elettrico del presidente Usa costa a Stellantis 14 miliardi negli Usa, il tutto dopo che negli anni scorsi la stessa Stellantis era stata tra le case automobilistiche più favorevoli alla transizione ecologica. Dalla nascita di Stellantis (2021) a oggi, Exor ha incassato cedole per oltre 2 miliardi, mentre nei quattro anni di Tavares (2021-2024) sono stati prodotti 55 miliardi di utili e distribuiti in totale 14 miliardi di dividendi. Per Exor (ieri -2,3% ad Amsterdam), questa semestrale è una brutta notizia, anche se molto meno di un tempo. A fine settembre, con il titolo poco sopra gli 8 euro, il valore netto di Stellantis era di 3,8 miliardi e pesava per il 10% sugli asset totali dei Exor. Oggi, con l’azione scesa a 6,2 euro, la capitalizzazione di mercato è sprofondata a 18,1 miliardi e si è dimezzata in un solo anno. Servirebbe forse un aumento di capitale, per Stellantis, ma per ora si è optato per un bond da 5 miliardi, perché i grandi soci non si vogliono diluirsi. Anche questo non deve essere piaciuto molto, in Borsa. Intanto, sembra avverarsi sempre più la profezia consegnata a Ferragosto a un settimanale portoghese da Tavares: «Alla fine l’auto la faranno solo gli Usa e la Cina». Dimenticò di dire che gli ha dato una bella mano.
Continua a leggereRiduci
iStock
Il consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2023/970 del Parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023, sulla trasparenza salariale che mira a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, tramite la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Secondo il ministro del Lavoro, Marina Calderone, il provvedimento «rafforza gli strumenti per rendere effettiva la parità salariale. Il testo potrà arricchirsi nel passaggio parlamentare e gli ulteriori confronti con le parti sociali, perché la valorizzazione del talento di tutte e di tutti è una condizione essenziale per un mondo del lavoro moderno e inclusivo».
L’obiettivo è eliminare il divario salariale di genere (gender pay gap) attraverso una maggiore trasparenza e strumenti di tutela. Si applica a datori di lavoro pubblici e privati e riguarda, salvo alcune esclusioni, i lavoratori subordinati (inclusi dirigenti e contratti a termine), estendendosi per alcuni aspetti anche ai candidati durante la fase di selezione. Secondo dati Eurostat del 2023 le donne guadagnano in media il 12% in meno rispetto agli uomini. Peraltro, questo divario ha ripercussioni trasformandosi in un gap pensionistico rilevante (oltre il 26% in media Ue secondo dati Eurostat del 2024). Se quindi il punto di partenza è condivisibile, quello che fa discutere sono gli strumenti e il rischio di indesiderati effetti collaterali. In base alle nuove norme i datori di lavoro avranno l’obbligo di fornire alle persone in cerca di occupazione informazioni sulla retribuzione iniziale e sulla fascia retributiva dei posti vacanti pubblicati. Ai datori di lavoro è fatto divieto di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti professionali. Ma soprattutto, una volta assunti, i lavoratori avranno il diritto di chiedere ai loro datori di lavoro, informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie che svolgono analoghe attività o di pari valore. Potranno anche essere richiesti i criteri utilizzati per determinare la progressione retributiva e di carriera che devono essere, dice la direttiva Ue, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Le imprese con più di 500 dipendenti dovranno riferire annualmente all’autorità nazionale competente, sul divario retributivo di genere all’interno. Per le imprese tra 100 e 250 dipendenti questa comunicazione avverrà ogni tre anni. Quando l’organico è sotto i 100 dipendenti non c’è obbligo di comunicazione. Se dovesse emergere un divario retributivo superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi e neutri dal punto di vista del genere, le imprese saranno obbligate a intervenire svolgendo una valutazione delle retribuzioni con i sindacati. I dipendenti che dovessero aver subito discriminazioni retributive potranno avere un risarcimento, compresi gli stipendi arretrati e i relativi bonus.
Questo significa un aggravio organizzativo importante per l’azienda che potrebbe dover fronteggiare una raffica di contestazioni. E soprattutto si apre il tema delle risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo della parità salariale. Sarà interessante vedere se anche i contratti collettivi dovranno tenere conto del fatto che i rinnovi dovranno essere modulati per colmare il divario esistente. Al tempo stesso c’è il rischio che si scateni un vespaio di invidie e gelosie mettendo uomini e donne l’uno contro l’altro nella gestione degli incrementi salariali aziendali.
Per quelle aziende tenute alla comunicazione, nel caso emerga una differenza del livello retributivo tra uomini e donne pari o superiore al 5%, il datore di lavoro avrebbe sei mesi di tempo per rimediare.
Il tema è capire come dare le giuste risposte a una questione sulla quale tutti sono d’accordo in termini di principio ma che andrà gestita con attenzione ed equilibrio. C’è insomma da evitare il rischio di «eccesso di reazione», tema che si è posto all’attenzione in questi giorni con la notizia riportata dal New York Times secondo cui le iniziative dell’azienda Nike a favore della diversità potrebbero aver rappresentato una discriminazione a danno dei lavoratori bianchi. La Enoc (la commissione americana per le pari opportunità) sta indagando su «accuse sistemiche di discriminazione razziale intenzionale legate ai programmi di diversità, equità e inclusione «nei confronti dei dipendenti bianchi del gruppo di abbigliamento sportivo».
Continua a leggereRiduci