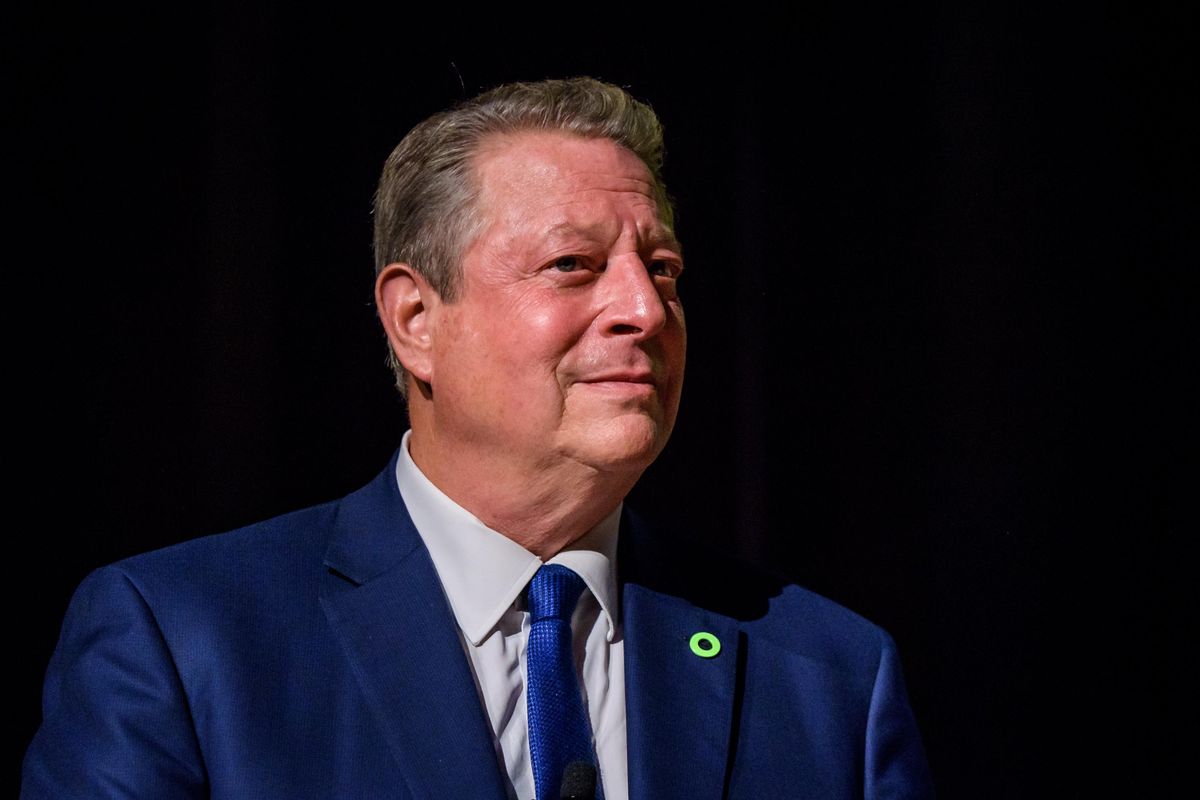È pericoloso lasciare i coniugi Moretti in libertà, perché potrebbero fuggire. Lo pensano gli avvocati delle famiglie delle vittime che, per provare a mitigare l’enorme dolore, chiedono giustizia. E, in effetti, fuggire non sarebbe una novità, almeno per Jessica Maric, titolare del locale Le Constellation insieme al marito Jacques Moretti, a quanto pare ripresa da due telecamere di sorveglianza in quella notte di orrore mentre si allontanava dal locale che andava a fuoco con la cassa sottobraccio, lasciando dietro di sé le grida di aiuto dei ragazzini a cui aveva spillato 100 euro per il biglietto di ingresso. Un particolare quasi osceno, se fosse confermato. Mentre quello che non ha bisogno di conferme è il fatto che lei, là sotto, a tentare di salvare i giovani intrappolati tra le fiamme, non c’era.
A denunciare la mollezza del sistema giudiziario svizzero a fronte di una tragedia immane, che ha ucciso, bruciandoli vivi, 40 giovanissimi e ne ha feriti gravemente altri 116, ustionandoli così in profondità che molti ancora lottano tra la vita e la morte, sono i legali che assistono le vittime e le famiglie del rogo di capodanno a Le Constellation di Crans-Montana. «È un rischio aver lasciato i gestori del Costellation in libertà. Immaginate cosa succederebbe per le vittime se queste persone lasciassero la Svizzera e non si potesse avere il processo che è dovuto ai genitori e alle famiglie delle vittime», ha dichiarato l’avvocato Sébastien Fanti, alla tv svizzera Rts. I due risultano indagati per omicidio colposo e lesioni colpose ma, alla luce di quello che sta emergendo, «si parla potenzialmente di lesioni personali gravi, intenzionali, con dolo eventuale», aggiunge un altro avvocato delle famiglie, Alain Mancaluso che, insieme al collega Romain Jordan, si dice «scioccato» anche del fatto che che «i legali siano esclusi dalle audizioni» e non possano partecipare alle prime fasi delle indagini.
Eppure, la decisione di non arrestare i due gestori è stata confermata, anche ieri, dalla procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud: «In questa fase non ci sono indicazioni di un rischio di fuga, di collusione o recidiva. Ma la situazione viene valutata costantemente», ha ribadito, mentre, per quanto riguarda l’esclusione dei legali, Pilloud si è giustificata sostenendo che serve ad «evitare fughe di notizie dato il carattere mediatico del dossier».
Eppure, che fosse pericoloso accendere candele pirotecniche in quel seminterrato, i gestori non potevano ignorarlo: a dimostrarlo c’è il video che, ormai da giorni è stato diffuso, sul Capodanno 2020 quando uno dei camerieri, davanti a una scena del tutto simile a quella che ha dato via al rogo una settimana fa (cioè qualcuno che, sollevando le candele durate la festa, avvicinava le scintille al soffitto) gridava: «Attenti alla schiuma!». Ma torniamo a Jessica, la quarantenne di origini corse che insieme al marito - noto alla giustizia per truffa, sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona - in pochi anni, dal nulla, ha costruito un impero nel settore della ristorazione nella piccola e costosissima Crans-Montana.
A quanto risulta, le telecamere di sorveglianza l’avrebbero immortalata mentre lasciava in tutta fretta il luogo della tragedia stringendo tra le mani la cassa del locale mentre il figlio, capo staff di Le Constellation, sarebbe stato ripreso mentre tentava di sfondare dall’interno i pannelli di plexiglass che chiudevano la veranda. Se le indiscrezioni sulla sua condotta si rivelassero vere, sarebbe un ennesimo elemento che aggiunge orrore alla tragedia. Comunque sia, da quella notte infernale Jessica è uscita illesa, solo con una piccola bruciatura al braccio. E si capisce bene il motivo: non c’è traccia di lei nelle immagini che riprendono gli ultimi istanti di vita di tante vittime imprigionate nel sotterraneo, non ha incitato quei giovani quasi incantati dalle fiamme al soffitto a scappare né la si intravede all’esterno a tentare di far uscire chi era rimasto intrappolato, come invece era suo dovere.
Nei prossimi giorni, l’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado si recherà a Sion e incontrerà le autorità del Canton Vallese «per acquisire informazioni sulle indagini», ha spiegato. Intanto dall’ospedale Niguarda dove sono ricoverati 11 pazienti, arrivano notizie contrastanti: «La situazione rimane stabile con lievi accenni di miglioramento per alcuni di loro», ma «rimangono critiche le condizioni di tre persone a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni».
E nel dolore straziante di chi è rimasto, c’è ancora una famiglia che stenta a credere a quanto è accaduto. Sono i genitori di Emanuele Galeppini, 17 anni, che ancora non sanno cosa ha causato la morte del loro figlio, perché il suo corpo non era ustionato come si aspettavano ma perfettamente integro. «Non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio», ha fatto sapere il legale della famiglia, «vogliono sapere com’è morto. Abbiamo chiesto alla autorità svizzere spiegazioni ma non ci hanno nemmeno risposto».
Musica, lacrime e rabbia durante i quattro funerali dei ragazzi morti nel rogo
Fiori bianchi, note struggenti, tanti abbracci e tante lacrime. Ieri in Italia l’ultimo doloroso saluto alle giovani vittime di Capodanno nel devastante rogo de Le Constellation di Crans-Montana.A Milano, dove il sindaco Beppe Sala aveva proclamato il lutto cittadino, si sono svolti i funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi in due basiliche simbolo della città. La cerimonia funebre di Chiara in Santa Maria delle Grazie, quella di Achille in Sant’Ambrogio. «Oggi non siamo qui a cercare spiegazioni o colpe, ci sarà tempo anche per questo ma non è oggi», ha detto monsignor Alberto Torriani, arcivescovo di Crotone, rivolgendosi a papà Andrea Costanzo, mamma Giovanna, e ai fratelli Camilla, Elena e Luca. «Noi siamo stati abbracciati da tutta Italia, abbiamo tutti sete di verità e che queste cose non succedano mai più», ha detto il padre Andrea che, al termine delle esequie in un breve colloquio con il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha affermato: «Il presidente Meloni è stata umana e attenta nei nostri confronti. Siccome non ho mai avuto la possibilità di stringerle la mano, vorrei parlare con lei ed essere rassicurato che non ci siano omissioni. Le indagini vanno effettuate con scrupolo. Serve giustizia. Visto che le nostre istituzioni si sono dimostrate molto serie, sono convinto che il presidente sia con noi. Non sono un tecnico ma vorrei che l’Italia si costituisse parte civile». Un mazzo di rose bianche, un lungo applauso e le note di Perdutamente di Achille Lauro, fuori dalla Basilica di Sant’Ambrogio, per i funerali di Achille Barosi. Il nonno Osvaldo ha voluto ringraziare i poliziotti che avevano formato un cordone a protezione del carro ed ha aggiunto: «L’unica cosa che posso dire è che ci vuole solamente tanta fede e tanto amore ed essere vicini, è l’unica medicina che possiamo avere gratis per non cercare di sprofondare nella disperazione». Nella Capitale, oltre ai parenti e agli amici, per l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti nella basilica di San Pietro e Paolo all’Eur c’erano anche i ministri dello Sport e della Salute, Andrea Abodi e Orazio Schillaci, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sulla bara, accanto alla foto di Riccardo, la corona di fiori firmata «Ma, papà e Matilde», la sorella di 14 anni che quella tragica notte ha scavato tra le macerie alla ricerca del fratello. Dal pulpito la mamma ha ricordato: «Riccardo aveva un cuore grande, tenero e gentile, dietro la sua ironia e l’irrequietezza nascondeva una profonda sensibilità. Ci ha fatto faticare, ma era buono». «La vostra presenza qui oggi è il segno di quanto Riccardo ha fatto nella sua breve vita donandosi con generosità», ha detto in lacrime il papà Massimo. Uscendo dalla chiesa i genitori hanno sottolineato: «Non proviamo rabbia, solo dolore, ma vogliamo che sia fatta giustizia». «Condividere questo dolore con altre persone ti dà la forza», ha aggiunto la mamma, che ha ringraziato il presidente Meloni che è stata vicina anche a livello personale a tutti i genitori».«Il primo gennaio hai perso la vita e io l’ho persa con te, a differenza tua io vivrò con un vuoto incolmabile ma tu no», ha detto, con voce rotta dal pianto, Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni durante il funerale a Bologna. La passione per la musica univa Giovanni a don Stefano Greco, amico di famiglia e catechista del sedicenne, che proprio dagli spartiti ha iniziato il suo discorso parlando dell’Incompiuta di Schubert: «È perfetta e struggente perché incompleta. Giovanni è la nostra Incompiuta». A Lugano sono state celebrate le esequie di Sofia Prosperi, l’italosvizzera di 15 anni studentessa dell’International School di Fino Mornasco, nel Comasco. Chiesa gremita di ragazzi con una rosa bianca in mano per la messa celebrata dal vescovo Alain de Raemy. Oggi a Boccadasse, a Genova, si terrà in forma strettamente privata il funerale di Emanuele Galeppini, il giovane campione di golf.