True
2023-09-19
Gas e ora l’idrogeno. Gli acquisti comuni Ue uccidono il mercato
iStock
Dopo aver rivelato l’intenzione di rendere strutturale il meccanismo di acquisti congiunti di gas sulla piattaforma AggregatEU, la commissione europea, a quanto risulta, sarebbe intenzionata ad allargare il meccanismo anche a biogas e all’idrogeno. Vi sarebbe già un documento in questo senso, trasmesso dalla commissione al Parlamento europeo.
L’idrogeno, sulla carta, dovrebbe avere un ruolo preminente nelle strategie di decarbonizzazione messe in pista dall’Unione europea, a patto che sia prodotto utilizzando fonti rinnovabili. Il che significa che sarà necessario installare capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non solo per sostituire l’attuale generazione a base di gas e carbone, ma anche per produrre idrogeno. Si stima sarà necessaria una produzione aggiuntiva di energia elettrica da fonte rinnovabile pari al 30% del totale, solo per produrre idrogeno. La produzione di idrogeno, dal punto di vista energetico, è altamente inefficiente.
Bisognerebbe chiedersi perché si è giunti a negare in radice l’essenza del mercato interno, vero totem dell’Unione europea, inventando un meccanismo di aggregazione della domanda e di una piattaforma con cui gli operatori vendono il gas. Il meccanismo di acquisto congiunti inventato dalla Commissione a guida Ursula von der Leyen doveva essere temporaneo ed era stato pensato soprattutto per aiutare Berlino dopo che i due gasdotti Nord Stream, che portavano in Germania il gas direttamente dalla Russia, sono stati resi inutilizzabili. Ma nei giorni scorsi si è saputo che la Commissione punta a rendere il meccanismo stabile, ed ora a questo si aggiungerebbe la piattaforma stabile per l’acquisto congiunto di idrogeno.
In barba al principio della concorrenza e del mercato interno fortemente competitivo, il totem dell’Unione europea.
Qualcuno si è spinto a dire recentemente che il meccanismo di acquisti congiunti è servito a contenere le quotazioni record del gas sui mercati finanziari nel momento più difficile della tempesta dei prezzi dell’energia. Questo è semplicemente falso, un po’ come l’oro di Bologna. Le quotazioni del gas hanno avuto il loro picco nell’agosto 2022, a seguito della folle corsa a riempire gli stoccaggi scatenata dalla Germania in crisi di gas, mentre la Ue lanciava il suo schizofrenico programma RepoweEU. Questo sanciva la rinuncia al gas russo mentre tutta Europa ne era ancora pienamente dipendente. Dal settembre 2022 i prezzi del gas sono calati in maniera abbastanza regolare, ma questo andamento non ha nulla a che fare né con il price cap (chi se lo ricorda?) né, tantomeno, con il meccanismo di acquisti congiunti. La piattaforma ha infatti emesso il primo bando per la richiesta di offerte il 25 aprile 2023, quando le quotazioni del gas erano già tornate attorno a 30 euro al megawattora, cioè dieci volte in meno rispetto al picco di agosto 2022. I quantitativi transati, poi, sono minimi rispetto al volume totale dei consumi europei. Sin qui la piattaforma ha lanciato due gare, una terza è prevista per il 3 ottobre prossimo, una quarta per dicembre. Nelle prime due gare, 91 acquirenti hanno espresso una richiesta di 27,5 miliardi di metri cubi. Contro i circa 400 miliardi di consumo totale annuale della Ue. Oltretutto gli operatori che vendono gas ai consumatori raramente ne sono anche produttori. Eliminata dal mercato occidentale Gazprom, ci sono Shell, Eni, la norvegese Equinor e pochissimi altri. Il resto del gas è algerino, ancora russo, azero, e poi c’è tanto Gnl, che arriva dagli Usa, dal Qatar e ancora dalla Russia.
Quindi, il gas che arriva in vendita sulla piattaforma spesso è già di seconda o di terza mano, cioè a prezzi non bassi. In più, la domanda partecipa alla piattaforma in forma di aggregazione, curata dai venditori a clienti finali, oppure vi accedono i grandissimi consumatori. Se la partecipazione alla piattaforma di acquisti congiunti fosse davvero vantaggiosa, non si vede il motivo per cui un piccolo fornitore che non partecipa al meccanismo debba pagare il gas di più di un altro che invece partecipa. La concorrenza diventa una parola vuota, si creano delle discriminazioni tra consumatori. In barba ai trattati e a tutta la filosofia d’accatto sul mercato fortemente competitivo, sul divieto di aiuti di Stato, sulle distorsioni della concorrenza e tutto l’armamentario ideologico unionista. L’idrogeno, poi, al momento è soprattutto una grande incognita. Vi sono faraonici progetti e piani di sviluppo che mostrano grafici con crescite «esponenziali» nella produzione di H2. Entro il 2030, l’Ue ha l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva annuale di circa 20 milioni di tonnellate. Ad oggi, però, produrre idrogeno su larga scala è antieconomico. Dunque, ancora una volta, l’Unione, con le sue politiche dissennate, mette l’intero sistema energetico continentale in crisi, per poi trovare soluzioni che peggiorano ulteriormente la situazione.
In fondo, anche in questo caso il mantra europeista si ripete: l’Europa non funziona? Ci vuole più Europa!
Caro bollette per aiutare il clima? Sì, solo se l’aumento è sotto il 2%
I fatti hanno la testa dura, pare abbia detto Lenin. In estrema sintesi, è ciò che dice anche l’ultimo rapporto annuale sul mondo dell’energia pubblicato da Bain & Company, prestigiosa società di consulenza americana, partner strategico del World economic forum ed entusiasta aderente alla cosiddetta agenda di Davos.
L’analisi di Bain è strutturata come una indagine condotta tra oltre 600 alti dirigenti di 125 aziende dei settori dell’energia e delle risorse naturali in 46 paesi e si nutre anche di altre indagini condotte tra i consumatori di tutto il mondo. Il campione è dunque molto significativo.
Cosa dice il rapporto? Tre cose. La prima è che per raggiungere il net zero (cioè emissioni zero di CO2) al 2050, gli investimenti infrastrutturali annuali in energia verde dovrebbero essere triplicati, rispetto alle cifre di adesso.
La seconda è che tale necessità di investimenti è ben lontana dall’essere soddisfatta: il settore minerario, ad esempio, reinvestirà nella crescita solo il 44% del capitale, in calo rispetto al 56% dell’anno precedente. Il settore del petrolio e gas reinvestirà solo il 43% del capitale, in calo rispetto al 58% del 2018.
Il terzo concetto chiave nello studio di Bain, per noi il più rilevante, è che sebbene i consumatori si dicano preoccupati per il cambiamento climatico, nella maggior parte dei casi si dichiarano non disposti a pagare bollette più onerose per contribuire alla risoluzione del problema. Per dirlo con i numeri, secondo un sondaggio di Bain del febbraio 2023, solo il 30% dei consumatori accetterebbe un aumento del 2% della bolletta per fronteggiare il cambiamento climatico.
Decisamente un pessimo risultato per le politiche green, soprattutto europee. Secondo Bain, per quasi l’80% dei manager intervistati gli ostacoli maggiori alla transizione energetica sono «la mancanza di chiarezza regolatoria e la quasi nulla disponibilità da parte dei clienti a pagare un premio per partecipare attivamente a un percorso green».
Al di là del costo del capitale, in aumento, il problema diventa il rientro degli investimenti, visto che i consumatori non sembrano disposti a concedere ritorni significativi agli investitori. Infatti, il rapporto di Bain riporta un dato interessante. Per ogni miliardo di euro investito in una iniziativa «emissioni zero», con un costo del capitale del 5%, considerati tasse ed ammortamenti, assumendo 20 anni di vita utile, sono necessari 108 milioni di euro all’anno di ricavo, al netto delle spese operative. Cioè, servono ricavi per 108 milioni l’anno solo per ripagare il debito, ammortizzare l’investimento e avere un ritorno finanziario. A questo andrebbero aggiunti i costi operativi. Ciò significa che, per rientrare dell’investimento, l’energia deve costare di più, altrimenti l’iniziativa non si giustifica economicamente. Se i tassi aumentano, aumentano anche i ricavi necessari, e dunque il prezzo dell’energia.
Peccato però che queste cifre siano proibitive, soprattutto se si guardano i risultati del sondaggio di Bain. Il 70% dei consumatori europei non è disposto a sostenere un aumento delle bollette, neppure di un misero 2%, per sostenere il green deal. Solo il 15% sarebbe disposto a sostenere un aumento del 10%. Il 60% dei consumatori, invece, vedrebbe di buon occhio una tassa sulle famiglie più ricche, suggerendo in qualche modo che per pagare la transizione agli investitori privati sia necessario un riequilibrio fiscale. Va detto però che la strada di un aumento delle tasse appare improponibile. In primis perché la transizione energetica costerà cifre talmente gigantesche che non c’è al mondo sistema fiscale che possa adeguarvisi. In secondo luogo, la pressione fiscale sulle persone fisiche, almeno in Italia, è già soffocante. In terzo luogo, sono ben pochi i contribuenti che ricadrebbero nella fattispecie. A meno di passare direttamente all’esproprio, non proletario ma ecologico.
La narrazione green, insomma, si schianta ogni giorno contro il muro della realtà. La propaganda sul cambiamento climatico genera ansia ma non farà aprire il portafoglio di chi fa già fatica ad arrivare alla fine del mese.
Continua a leggereRiduci
La Commissione vuole estendere lo schema nato con la guerra ad altri derivati. Salterà la concorrenza e servirà più energia.Caro bollette: il 30% dei consumatori interpellati accetta un sacrificio minimo. L’eco-ansia non esiste.Lo speciale contiene due articoli.Dopo aver rivelato l’intenzione di rendere strutturale il meccanismo di acquisti congiunti di gas sulla piattaforma AggregatEU, la commissione europea, a quanto risulta, sarebbe intenzionata ad allargare il meccanismo anche a biogas e all’idrogeno. Vi sarebbe già un documento in questo senso, trasmesso dalla commissione al Parlamento europeo.L’idrogeno, sulla carta, dovrebbe avere un ruolo preminente nelle strategie di decarbonizzazione messe in pista dall’Unione europea, a patto che sia prodotto utilizzando fonti rinnovabili. Il che significa che sarà necessario installare capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non solo per sostituire l’attuale generazione a base di gas e carbone, ma anche per produrre idrogeno. Si stima sarà necessaria una produzione aggiuntiva di energia elettrica da fonte rinnovabile pari al 30% del totale, solo per produrre idrogeno. La produzione di idrogeno, dal punto di vista energetico, è altamente inefficiente.Bisognerebbe chiedersi perché si è giunti a negare in radice l’essenza del mercato interno, vero totem dell’Unione europea, inventando un meccanismo di aggregazione della domanda e di una piattaforma con cui gli operatori vendono il gas. Il meccanismo di acquisto congiunti inventato dalla Commissione a guida Ursula von der Leyen doveva essere temporaneo ed era stato pensato soprattutto per aiutare Berlino dopo che i due gasdotti Nord Stream, che portavano in Germania il gas direttamente dalla Russia, sono stati resi inutilizzabili. Ma nei giorni scorsi si è saputo che la Commissione punta a rendere il meccanismo stabile, ed ora a questo si aggiungerebbe la piattaforma stabile per l’acquisto congiunto di idrogeno. In barba al principio della concorrenza e del mercato interno fortemente competitivo, il totem dell’Unione europea.Qualcuno si è spinto a dire recentemente che il meccanismo di acquisti congiunti è servito a contenere le quotazioni record del gas sui mercati finanziari nel momento più difficile della tempesta dei prezzi dell’energia. Questo è semplicemente falso, un po’ come l’oro di Bologna. Le quotazioni del gas hanno avuto il loro picco nell’agosto 2022, a seguito della folle corsa a riempire gli stoccaggi scatenata dalla Germania in crisi di gas, mentre la Ue lanciava il suo schizofrenico programma RepoweEU. Questo sanciva la rinuncia al gas russo mentre tutta Europa ne era ancora pienamente dipendente. Dal settembre 2022 i prezzi del gas sono calati in maniera abbastanza regolare, ma questo andamento non ha nulla a che fare né con il price cap (chi se lo ricorda?) né, tantomeno, con il meccanismo di acquisti congiunti. La piattaforma ha infatti emesso il primo bando per la richiesta di offerte il 25 aprile 2023, quando le quotazioni del gas erano già tornate attorno a 30 euro al megawattora, cioè dieci volte in meno rispetto al picco di agosto 2022. I quantitativi transati, poi, sono minimi rispetto al volume totale dei consumi europei. Sin qui la piattaforma ha lanciato due gare, una terza è prevista per il 3 ottobre prossimo, una quarta per dicembre. Nelle prime due gare, 91 acquirenti hanno espresso una richiesta di 27,5 miliardi di metri cubi. Contro i circa 400 miliardi di consumo totale annuale della Ue. Oltretutto gli operatori che vendono gas ai consumatori raramente ne sono anche produttori. Eliminata dal mercato occidentale Gazprom, ci sono Shell, Eni, la norvegese Equinor e pochissimi altri. Il resto del gas è algerino, ancora russo, azero, e poi c’è tanto Gnl, che arriva dagli Usa, dal Qatar e ancora dalla Russia. Quindi, il gas che arriva in vendita sulla piattaforma spesso è già di seconda o di terza mano, cioè a prezzi non bassi. In più, la domanda partecipa alla piattaforma in forma di aggregazione, curata dai venditori a clienti finali, oppure vi accedono i grandissimi consumatori. Se la partecipazione alla piattaforma di acquisti congiunti fosse davvero vantaggiosa, non si vede il motivo per cui un piccolo fornitore che non partecipa al meccanismo debba pagare il gas di più di un altro che invece partecipa. La concorrenza diventa una parola vuota, si creano delle discriminazioni tra consumatori. In barba ai trattati e a tutta la filosofia d’accatto sul mercato fortemente competitivo, sul divieto di aiuti di Stato, sulle distorsioni della concorrenza e tutto l’armamentario ideologico unionista. L’idrogeno, poi, al momento è soprattutto una grande incognita. Vi sono faraonici progetti e piani di sviluppo che mostrano grafici con crescite «esponenziali» nella produzione di H2. Entro il 2030, l’Ue ha l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva annuale di circa 20 milioni di tonnellate. Ad oggi, però, produrre idrogeno su larga scala è antieconomico. Dunque, ancora una volta, l’Unione, con le sue politiche dissennate, mette l’intero sistema energetico continentale in crisi, per poi trovare soluzioni che peggiorano ulteriormente la situazione.In fondo, anche in questo caso il mantra europeista si ripete: l’Europa non funziona? Ci vuole più Europa!<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/acquisti-comuni-ue-uccidono-mercato-2665618730.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="caro-bollette-per-aiutare-il-clima-si-solo-se-laumento-e-sotto-il-2" data-post-id="2665618730" data-published-at="1695113376" data-use-pagination="False"> Caro bollette per aiutare il clima? Sì, solo se l’aumento è sotto il 2% I fatti hanno la testa dura, pare abbia detto Lenin. In estrema sintesi, è ciò che dice anche l’ultimo rapporto annuale sul mondo dell’energia pubblicato da Bain & Company, prestigiosa società di consulenza americana, partner strategico del World economic forum ed entusiasta aderente alla cosiddetta agenda di Davos. L’analisi di Bain è strutturata come una indagine condotta tra oltre 600 alti dirigenti di 125 aziende dei settori dell’energia e delle risorse naturali in 46 paesi e si nutre anche di altre indagini condotte tra i consumatori di tutto il mondo. Il campione è dunque molto significativo. Cosa dice il rapporto? Tre cose. La prima è che per raggiungere il net zero (cioè emissioni zero di CO2) al 2050, gli investimenti infrastrutturali annuali in energia verde dovrebbero essere triplicati, rispetto alle cifre di adesso. La seconda è che tale necessità di investimenti è ben lontana dall’essere soddisfatta: il settore minerario, ad esempio, reinvestirà nella crescita solo il 44% del capitale, in calo rispetto al 56% dell’anno precedente. Il settore del petrolio e gas reinvestirà solo il 43% del capitale, in calo rispetto al 58% del 2018. Il terzo concetto chiave nello studio di Bain, per noi il più rilevante, è che sebbene i consumatori si dicano preoccupati per il cambiamento climatico, nella maggior parte dei casi si dichiarano non disposti a pagare bollette più onerose per contribuire alla risoluzione del problema. Per dirlo con i numeri, secondo un sondaggio di Bain del febbraio 2023, solo il 30% dei consumatori accetterebbe un aumento del 2% della bolletta per fronteggiare il cambiamento climatico. Decisamente un pessimo risultato per le politiche green, soprattutto europee. Secondo Bain, per quasi l’80% dei manager intervistati gli ostacoli maggiori alla transizione energetica sono «la mancanza di chiarezza regolatoria e la quasi nulla disponibilità da parte dei clienti a pagare un premio per partecipare attivamente a un percorso green». Al di là del costo del capitale, in aumento, il problema diventa il rientro degli investimenti, visto che i consumatori non sembrano disposti a concedere ritorni significativi agli investitori. Infatti, il rapporto di Bain riporta un dato interessante. Per ogni miliardo di euro investito in una iniziativa «emissioni zero», con un costo del capitale del 5%, considerati tasse ed ammortamenti, assumendo 20 anni di vita utile, sono necessari 108 milioni di euro all’anno di ricavo, al netto delle spese operative. Cioè, servono ricavi per 108 milioni l’anno solo per ripagare il debito, ammortizzare l’investimento e avere un ritorno finanziario. A questo andrebbero aggiunti i costi operativi. Ciò significa che, per rientrare dell’investimento, l’energia deve costare di più, altrimenti l’iniziativa non si giustifica economicamente. Se i tassi aumentano, aumentano anche i ricavi necessari, e dunque il prezzo dell’energia. Peccato però che queste cifre siano proibitive, soprattutto se si guardano i risultati del sondaggio di Bain. Il 70% dei consumatori europei non è disposto a sostenere un aumento delle bollette, neppure di un misero 2%, per sostenere il green deal. Solo il 15% sarebbe disposto a sostenere un aumento del 10%. Il 60% dei consumatori, invece, vedrebbe di buon occhio una tassa sulle famiglie più ricche, suggerendo in qualche modo che per pagare la transizione agli investitori privati sia necessario un riequilibrio fiscale. Va detto però che la strada di un aumento delle tasse appare improponibile. In primis perché la transizione energetica costerà cifre talmente gigantesche che non c’è al mondo sistema fiscale che possa adeguarvisi. In secondo luogo, la pressione fiscale sulle persone fisiche, almeno in Italia, è già soffocante. In terzo luogo, sono ben pochi i contribuenti che ricadrebbero nella fattispecie. A meno di passare direttamente all’esproprio, non proletario ma ecologico. La narrazione green, insomma, si schianta ogni giorno contro il muro della realtà. La propaganda sul cambiamento climatico genera ansia ma non farà aprire il portafoglio di chi fa già fatica ad arrivare alla fine del mese.
iStock
Esempio. L’interista grida al compagno opposto di tifo: «Sporco milanista!», accusandolo di essere negativo in quanto milanista e l’essere milanista è talmente negativo da necessitare di un rafforzativo negativo, che può essere «brutto», «disgraziato», «infame», «vigliacco» e così via, fino a «sporco». La sporcizia emblematizza la negatività tanto quanto la bruttezza estetica, le tribolazioni esistenziali, l’attitudine a fare la spia, la viltà e quindi, agli occhi dell’interista, essere milanista è una colpa tanto grave da poter essere rafforzata da un ulteriore stigma accusatorio. Anche la spiegazione della combinazione «sporco» più «caratteristica odiata» non univoca, ma doppia, regge. Il doppio insulto, scollegato rispetto al precedente, «Sei sporco e milanista», comunque si basa sull’attribuzione di un giudizio morale negativo all’essere sporco e, anche se solo simbolica, di un valore negativo ovvero un disvalore al portatore di sporcizia. Insomma, è più che assodato: se volete offendere qualcuno dategli dello sporco, simbolico o reale. Essere tacciati di pulizia, invece, vuol dire essere puri: «Your clothes are clean and your mind is productive» cantava Paul Weller con gli Style Council in quella che è - faremo una confessione pulita - una delle canzoni d’amore preferite di chi scrive, Speak like a child. Ancora, «Hai il cuore pulito come appena nevicato» cantava Eugenio Finardi nella canzone Patrizia. I proverbi traboccano di trionfi della pulizia: «Chi è pulito è bello», non sempre è vero, è pieno il mondo di racchioni puliti, tuttavia si può pensare che anche se non sono belli da guardare sono, almeno, puliti. Un altro: «La pulizia costa poco e molto vale»: verissimo. Un altro ancora: «Non importa che l’abito sia fino, purché sia pulito». Qui concordiamo: un brutto vestito pulito è certamente migliore di uno bello ma sporco.
Ci sono però dei casi in cui il polo positivo rappresentato dal pulito porta con sé qualcosa di negativo. Accade quando l’esercizio della pulizia non è virtuoso come sarebbe se fosse equilibrato, ma è un’attività ansiosa e ossessiva determinata dalla nevrosi di cui si è lievemente o del tutto ammalati. Dopo che la tv inglese ha dedicato loro un programma tv che in lingua originale si intitolava Obsessive Compulsive Cleaners e che in Italia è stato tradotto come Malati di pulito, li conosciamo popolarmente con questa denominazione. Da un punto di vista psichiatrico, il termine tecnico non è però «malati di pulito», che fa il verso ad altre frasi costruite sulla specificazione dell’oggetto della mania come, per esempio, «morti di fama» per intendere, un po’ simpaticamente, quelli che per arrivare al successo venderebbero anche la madre. I rupofobici soffrono molto, da un certo punto di vista, e no, non sono persone bizzarre che come una ha la passione degli scacchi, be‘ quelli ce l’hanno dei mocio lavapavimenti. No. Quelli sono semplici appassionati pulitori. I veri e propri rupofobici sono sofferenti portatori di una sorta di condanna, di una coazione a ripetere una prassi «igienizzante» che non basta mai e che il giorno dopo ricomincerà di nuovo. Sono i Sisifo del disinfettante: ogni giorno maneggiano la pezzetta imbibita di detergente per pulire con tutte le loro forze per poi... ricominciare uguale il giorno dopo. E quello dopo ancora e così via, sempre uguale, per l’eternità. A meno che un trattamento psicoterapeutico non interrompa il ciclo. Ciò che li guida, infatti, a pulire come instancabili ossessionati non è l’effettiva ed oggettiva condizione igienica di, per esempio, la casa. Il rupofobico non pulisce i pavimenti una volta a settimana, è capace di pulirli una volta ogni ora. O del proprio corpo. Il rupofobico non si lava le mani dopo essere andato in bagno, se le lava anche più volte di continuo, continuamente, per tranquillizzarsi, non perché le abbia davvero sporche. La parola rupofobia deriva dall’unione della parola greca rùpos che vuol dire sporcizia, sudiciume e fobia da phobos che significa paura. Attualmente la rupofobia è considerata da alcuni un disturbo d’ansia, da altri un disturbo ossessivo compulsivo. Va detto che alcuni considerano tutti i disturbi ossessivo compulsivi forme d’ansia e altri no, li considerano questioni psicopatologiche diverse. I gradi di afflizione di questa fobia possono essere diversi e andare da una leggera ansia all’idea di toccare qualcosa di sporco al disagio che porta a pensare continuamente allo sporco e a come evitarlo. Nel caso della «semplice» ansia, non si pensa continuamente allo sporco e l’ansia sopraggiunge solo se ci si trova in una situazione non percepita come igienica. Oppure, nella vita quotidiana che naturalmente contempla anche un rapporto continuo con la pulizia propria, della propria casa e, in generale, dei luoghi frequentati fuori casa, si opta sempre per azioni di controllo dell’eventuale sporco: si va dal lavarsi ben bene e con compiacimento le mani quando necessario all’evitare con compiacimento che tranquillizza ed evita l’ansia di bere il caffè nelle tazzine del bar chiedendolo in bicchiere usa e getta, dallo sgridare la persona che prende la frutta e la verdura al supermercato senza guanti come se stesse facendo chissà che di chissà quanto grave all’evitare di toccare cani o gatti considerandoli fonti di sporcizia, dall’iniziare a pulire appena arrivati a casa dal lavoro con una dedizione e un vigore eccessivi al non sopportare l’idea di accumulare i piatti durante una cena con ospiti e dunque all’andare a lavarli, abbandonando la tavola, dopo ogni portata, dal costringere tutti gli abitanti della casa, per primi sé stessi, a lasciare le scarpe fuori per «igiene» all’evitare di andare al ristorante perché nessuno lì impone ai clienti di togliersele e quel pavimento è una miniera a cielo aperto di sozzume. Si parla, insomma, sempre di eccessiva attenzione a non «sporcarsi», a non sporcare, a non trovarsi in mezzo allo sporco, a non far vivere a lungo lo sporco se crearlo è inevitabile, ma comunque non siamo ancora nel campo dell’ossessione, quanto piuttosto in quello del controllo, non simpatico nemmeno questo, ma comunque un filo meno disagevole, per sé e per gli altri, del disturbo ossessivo compulsivo. L’idea di controllare lo sporco che ci può essere addosso e intorno a noi, respingendolo con vigore e compiacimento ci identifica e tranquillizza il rupofobico ansioso.
Nel caso del disturbo ossessivo compulsivo, invece, la paura irrazionale dello sporco diventa un’ossessione. Il rupofobico ossessivo è un ossessivo-compulsivo la cui ossessione è la sporcizia e la cui compulsione è pulire e pulire e pulire per allontanare l’ossessione. Il disturbo ossessivo-compulsivo è un disturbo psicopatologico cronico e invalidante che si configura come una incontrollata manifestazione nella mente di chi ne soffre di ossessioni e conseguenti compulsioni percepite da chi soffre di Doc, questo l’acronimo, come unica possibilità risolutiva (ovviamente così non è, anzi è più o meno il contrario). Le ossessioni sono pensieri e impulsi involontari, che procurano disagio a chi le vive nella sua mente. Le compulsioni, complementari alle ossessioni, non sono pensieri ma azioni percepite come idonee a evitare che si presenti o almeno a diminuire o eliminare l’angoscia derivante dalle ossessioni. In tutti i casi, comunque, sia che si manifesti con ansia, sia che si palesi come un disturbo ossessivo compulsivo, la rupofobia è una paura irrazionale e patologica dello sporco. Il rupofobico può avere attacchi di ansia e attacchi di panico anche solo pensando allo sporco e si calma pulendo. Il rupofobico può evitare i luoghi molto frequentati, dal bar alla spiaggia passando per i mezzi pubblici, perché disgustato dall’idea di stanziare in luoghi non puliti come vorrebbe lui. Può creare rituali di pulizia e di difesa dallo sporco, non solo in casa, lavando continuamente sé stesso e gli ambienti domestici, ma può esportarli anche fuori di casa. Si pensi a chi, dopo il Covid, andava in giro con guanti e masherine, anche doppi, anche guidando in auto da solo. Un equilibrato rifiuto dello sporco è corretto, un’esagerazione cela un problema.
Continua a leggereRiduci
Thea Louise Stjernesund e Sara Hector omaggiano Federica Brignone dopo la prova dello slalom gigante femminile (Getty Images)
Si sono concluse ieri, con la maestosa cerimonia dell'Arena di Verona, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Un successo per l'Italia sotto tutti i punti di vista: non solo sportivo, con il quarto posto nel medagliere e ogni record precedente spazzato via, ma anche logistico, organizzativo, economico e se vogliamo anche politico. Ma è stata soprattutto l'Olimpiade degli atleti, delle imprese, delle gioie e, talvolta, dei dolori. Dei gesti di fairplay e delle storie dietro ogni medaglia. Momenti indimenticabili che rimangono nella storia.
Tra i fotogrammi più belli lasciati in eredità da Milano-Cortina 2026, impossibile non cominciare da Federica Brignone. La Tigre di La Salle si è presentata a questi Giochi con mille incognite, dubbi e preoccupazioni legate alle sue condizioni fisiche, dopo il grave infortunio subito il 3 aprile 2025 - a meno di un anno dall'appuntamento a cinque cerchi - durante una gara di gigante ai campionati italiani Assoluti all'Alpe Lusia nelle Dolomiti. Quel giorno la diagnosi fu tremenda: frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone della gamba sinistra con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Le lacrime, l'operazione, la riabilitazione, un secondo intervento e il tempo che scorreva inesorabilmente come un countdown verso l'inizio dell'Olimpiade casalinga, quella che ogni atleta sogna di vivere da protagonista, a maggior ragione se coltiva legittime ambizioni di medaglia per pedigree e talento. Quel talento unito alla tenacia e alla fiducia in se stessa, ma anche alla pazienza e a un'incredibile forza mentale, che hanno permesso a Federica Brignone non solo di presentarsi ai blocchi di partenza di Milano-Cortina, ma anche di farlo da assoluta regina delle nevi, con i due magnifici ori conquistati nello slalom gigante e nel supergigante di quella domenica 15 febbraio che entra di diritto nella storia dello sport azzurro.
Un po' come era successo nel 2021, quando il 1° agosto, anche quel giorno era domenica, ai Giochi di Tokyo arrivarono nel giro di 16 minuti le due incredibili medaglie d'oro vinte da Gianmarco Tamberi nel salto in alto e da Marcell Jacobs nei 100 metri. Otto giorni fa, invece, a Milano-Cortina è andata esattamente così: alle 14.28 Federica Brignone conquista il secondo oro della sua Olimpiade. Alle 14:59 la coppia dello snowboard cross formata da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva vince l'argento. Alle 15:15 una leggendaria Lisa Vittozzi sale sul gradino più alto del podio nell'inseguimento del biathlon. 47 minuti di pura adrenalina e goduria sportiva per i nostri colori.
A proposito del biathlon, dalla disciplina che riunisce lo sci di fondo con il tiro a segno con la carabina, è arrivato uno dei momenti più belli e apprezzati, caratterizzato da un enorme gesto di fairplay. Durante una prova che vedeva impegnata proprio Lisa Vittozzi, l'avversaria francese Julia Simon ha perso un bastoncino e dargliene uno di scorta è stato proprio il coach azzurro a bordo pista. E che dire dell'arrivo fianco a fianco, tra gli applausi, ad Anterselva di due colossi biathlon come l'italiana Dorothea Wierer e la tedesca Franziska Preuss, giunte all'ultima danza sulla neve. Sempre nell'inseguimento del biathlon, ma al maschile, toccante ed emozionate è stato il momento in cui il francese Emilien Jacquelin, dopo aver tagliato il traguardo al terzo posto e aver conquistato la medaglia di bronzo, ha dedicato il successo a Marco Pantani indicando l'orecchino che gli era stato regalato dalla mamma del Pirata e la bandana che porta in segno di omaggio al ciclista scomparso nel 2004. Nella mass start, invece, scena pazzesca quella che ci hanno regalato l'italiano Nicola Romanin, il francese Fabien Claude e l'americano Campbell Wright. Questi ultimi due, fuori dalla zona medaglia e nelle ultime posizioni, si fermano a pochi metri dal traguardo per aspettare l'azzurro. I tre si allineano, confabulano un paio di secondi e danno vita a uno sprint con una volata sul rettilineo finale per evitare l'ultima posizione.
 Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)
Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)
Tra le emozioni intense vissute a Milano-Cortina c'è senz'altro quella vissuta da Federico Tomasoni che dopo l'argento conquistata a Livigno nello ski cross ha mostrato il sole disegnato sul suo casco e dedicato la medaglia a Matilde Lorenzi, la sua fidanzata scomparsa il 28 ottobre 2024 dopo una terribile caduta sugli sci.
Storie di sport che si intrecciano a momenti di vita che ognuno di noi può sentire più o meno vicino e farci vivere l'evento oltre la pura competizione sportiva. Come per esempio il primo oro nella storia dei Giochi invernali per il Brasile conquistato da Lucas Braathen e l'emozione dello sciatore appena finita la gara nella telefonata in vivavoce con una leggenda mondiale di questo sport come Alberto Tomba che si congratula e lui che si commuove. Nello sport, il momento che separa un'atleta da un trionfo a una sconfitta può essere invisibile, incalcolabile, ed è quel preciso istante in cui si realizza di non avercela fatta. È quanto è accaduto ad Atle Lei MCGrath. Lo sciatore norvegese, nella prima manche dello slalom maschile, si trovava a condurre in testa davanti a tutti. Aveva la medaglia d'oro praticamente in pugno. Poi sul più bello si è trovato a fare i conti con un errore che gli è costato quattro anni di duro lavoro e sacrifici: l'inforcata, l'uscita fuori pista e il sogno che svanisce mentre tutto il mondo ti osserva e una reazione tanto impulsiva quanto significativa: l'urlo, il lancio al cielo dei bastoncini, i parastinchi slacciati e la camminata solitaria veso il bosco per trovare un rifugio lontano dalle telecamere e fare i conti con se stesso. «Volevo prendermi un po' di tempo per me» - ha raccontato dopo la gara - «Non conosco nessun altro sport in cui ci sia una distanza così breve tra la cosa più bella che puoi realizzare e la cosa peggiore che puoi vivere». Lo stesso ha vissuto il fenomeno mondiale del pattinaggio artistico, Ilia Malinin. L'americano di origini uzbeke, si era presentato come favorito assoluto ma nella finale olimpica non ha performato come avrebbe potuto e voluto e ha chiuso con un deludente e inaspettato ottavo posto. Un flop che lo straordinario pubblico del Forum di Assago ha saputo mitigare con una calorosa standing ovation durante l'esibizione al Galà del 21 febbraio e a cui il fenomeno del salto quadruplo ha risposto con le lacrime. Emozionante anche la vittoria di Elana Meyers-Taylor che alla quinta partecipazione ai Giochi e all'età di 41 anni ha vinto la medaglia d'oro nel mono-bob e ha festeggiato abbracciando i suoi due bimbi, nati entrambi sordi prematuri e uno con la sindrome di Down, ai quali ha comunicato attraverso il linguaggio dei segni la frase: «La mamma ha vinto».
Tra i momenti più divertenti e suggestivi nell'album dei ricordi di Milano-Cortina 2026 va inserito senza alcun dubbio Nazgul. Il bellissimo cane lupo che ha invaso la pista di Tesero durante la gara di qualificazioni dello sprint femminile a squadre e ha tagliato il traguardo davanti agli sguardi increduli e divertiti degli spettatori e delle atlete.
Continua a leggereRiduci
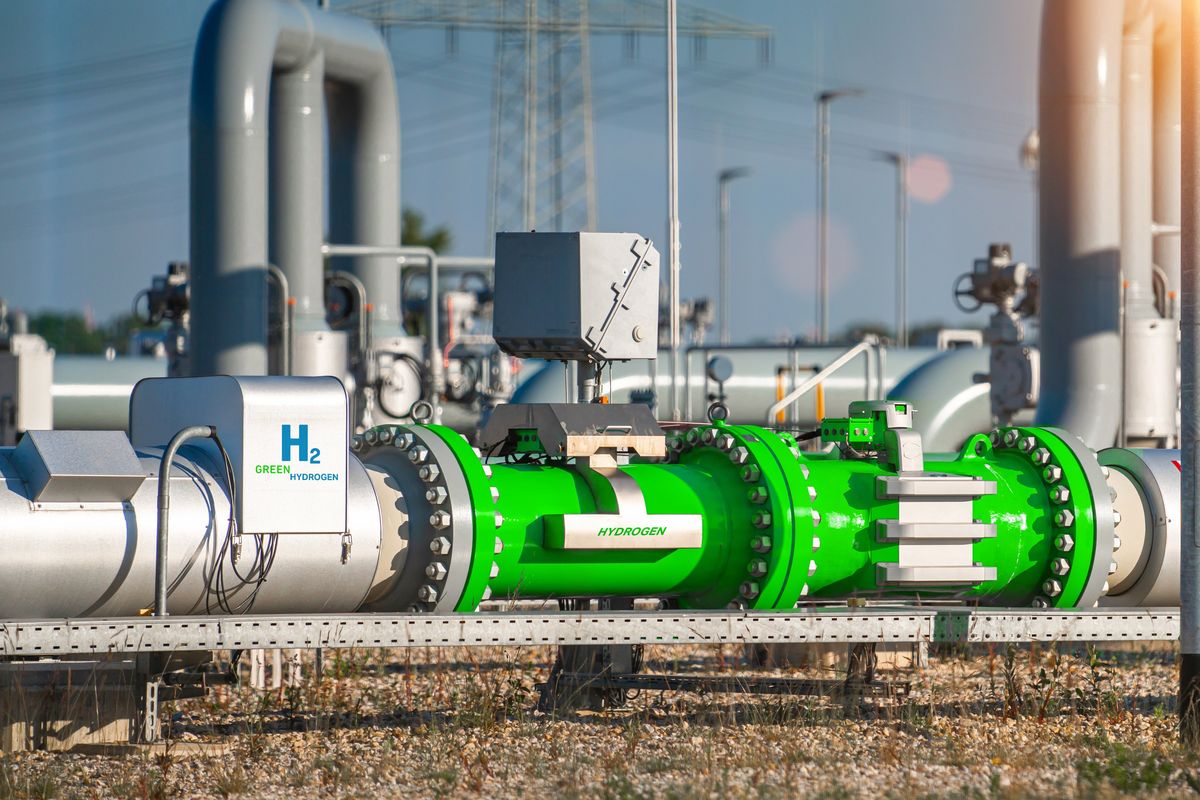




 Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)
Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)

