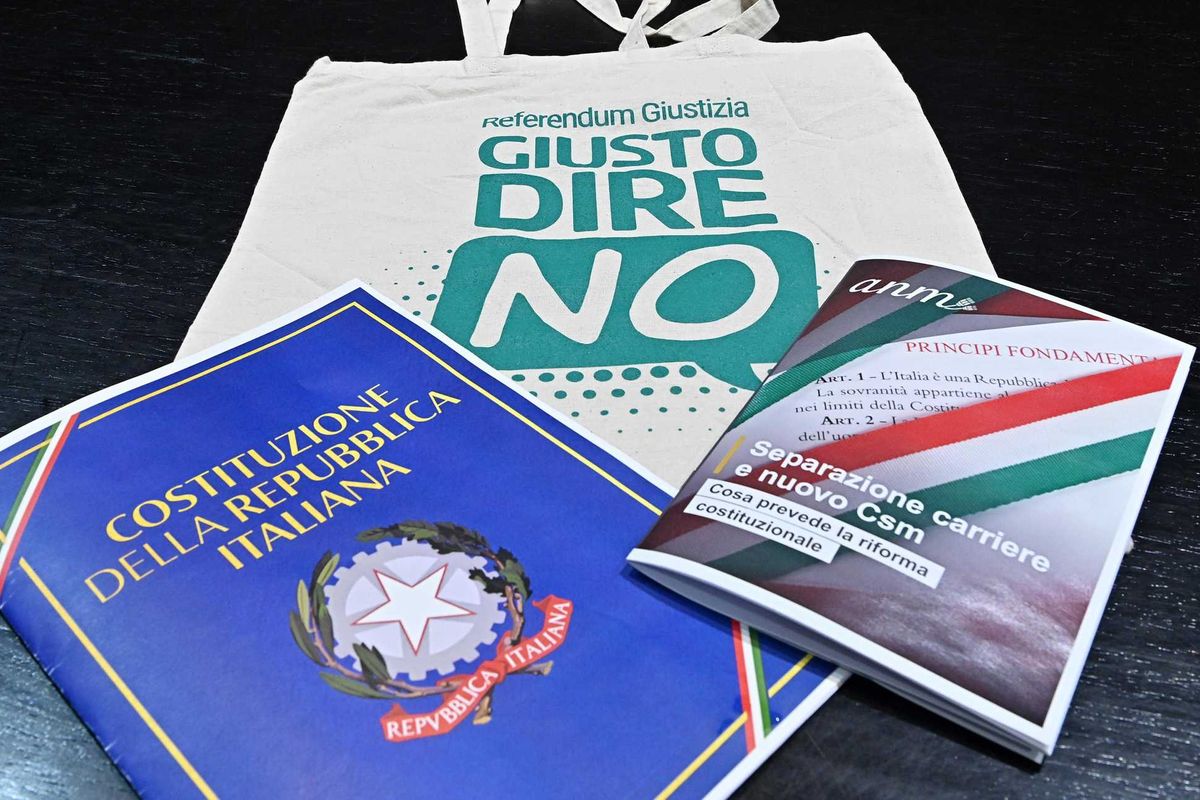Zitto zitto, il Mef tocca il grande tabù. Perché la Bce non finanzia il deficit?

Per il ministro dell'Economia Giovanni Tria è giunto il momento di affrontare «il tabù della monetizzazione del debito così recuperando strumenti di politica macroeconomica», oggi non disponibili nell'eurozona. Tradotto significa finanziare il deficit di uno Stato con moneta emessa dalla Bce. Apparentemente niente di rivoluzionario: sostanzialmente, sì.
Il bilancio aggregato delle tre banche centrali più importanti al mondo (Usa, eurozona e Giappone) infatti, nel 2008 era pari a circa 4.000 miliardi di dollari. Dopo dieci anni, superava i 15.000, avvicinandosi a una cifra pari a quattro volte quella di partenza grazie ai titoli di Stato acquistati con moneta «stampata», anzi creata con il click di un computer con cui le banche centrali accreditano il conto corrente che il governo tiene aperto presso di loro. Ma questa è la regola solo per Giappone e Stati Uniti. Nell'eurozona questa prassi è esplicitamente vietata dai trattati che invece prevedono che la Bce possa solo acquistare titoli di Stato già in circolazione. Con il solito click viene cioè accreditato il conto delle banche che vendono a Francoforte Btp o Bund, non quello del governo. Sostanzialmente la stessa cosa, non fosse che la Bce - istituzione condivisa fra i Paesi dell'eurozona - deve comprensibilmente porre un limite a tale prassi.
Ne traiamo subito tre conclusioni. Primo: l'emissione di nuova base monetaria (volgarmente detta «stampa di denaro») non è una prerogativa dei Paesi in via di sviluppo o «meno virtuosi», visto che di questa facoltà si sono avvalse le più accreditate banche centrali del mondo. Secondo: gli effetti sull'inflazione sono stati pressoché nulli, con ciò smontando il solito luogo comune in virtù del quale quanto maggiore è la quantità di moneta in circolazione tanto più aumenteranno i prezzi. I quali in realtà crescono soltanto se i consumatori spendono e acquistano beni in misura maggiore rispetto a quanto le imprese sono in grado di offrire. Terzo: condividere la banca centrale limita la flessibilità monetaria.
Apparentemente i debiti pubblici sono quindi già monetizzati o monetizzabili. E la proposta di Tria sembrerebbe innocua o inutile, ma solo a seconda dei punti di vista. Infatti fino a che la moneta immessa non viene spesa - visto che le banche dell'eurozona tengono depositati a Francoforte quasi 70 miliardi di euro (contro i circa 100 milioni che avevano nel 2011) - l'inondazione di liquidità finisce per dimostrarsi inutile. Le banche prestano soldi - semplificando - se l'economia funziona. E perché ciò avvenga gli Stati devono poter far deficit (spendere più di quanto incassano) per lasciare nel settore privato (famiglie e imprese) quei soldi che alimentano l'economia. Qui vengono alla luce tutti i difetti genetici dell'eurozona. Si può immettere denaro perché le banche lo prestino e perché i privati si indebitino. Ma gli Stati non possono diminuire le tasse o aumentare la spesa pubblica, con ciò impedendo che il reddito dei privati cresca. Più debito e meno reddito nella ricerca ossessiva di abbassare il debito pubblico, ma scordandosi che il debito pubblico è la ricchezza dei privati. Il patrimonio degli italiani è uno dei più alti al mondo secondo Bankitalia. Circa 10.000 miliardi: dato paragonabile solo a quello del Giappone, la cui crescita annuale è stata nei giorni scorsi certificata in oltre il 2% e che da decenni ricorre alla monetizzazione del debito con la Bank of Japan che acquista titoli di Stato emessi da Tokyo per finanziare il deficit.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: debito pubblico giapponese è sì cresciuto dal 100% dei primi anni 90 al 250% di oggi, ma il debito privato (che è ciò che più conta) è diminuito dal 290% al 230%. I disoccupati sono meno di due milioni su 130 milioni di abitanti: noi ne abbiamo quasi tre milioni con meno della metà degli abitanti. Ecco perché la ricetta invocata da Tria sarebbe veramente rivoluzionaria.
Rimane da chiedersi se esista un limite alla spesa in deficit e alla sua monetizzazione. La risposta è sì, ma non è il 3% di Maastricht né il pareggio di bilancio, ma i circa sei milioni di disoccupati effettivi presenti in Italia (ai tre milioni vanno aggiunti altrettanti non iscritti alla disoccupazione). Se fossero un milione e non sei, la spesa in deficit e la moneta immessa potrebbero far lievitare i prezzi. Ma è un timore che oggi purtroppo non ci tocca.