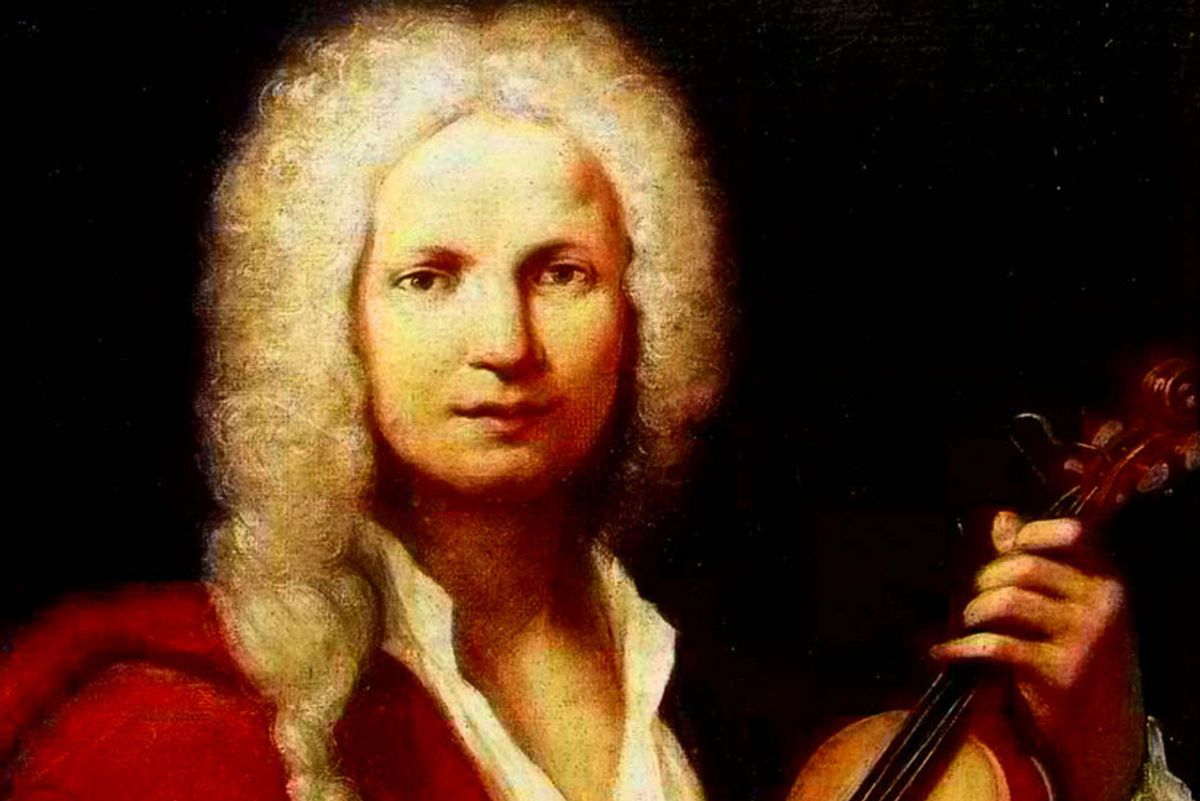
Fu forse a Mantova che Vivaldi incontrò per la prima volta Anna Giraud (Girò), il contralto che divenne prima sua allieva, poi prima donna e infine, con grave scandalo, sua compagna stabile. Vivaldi ne aveva una stima incommensurabile, la riteneva indispensabile per i propri allestimenti operistici - «Far l'opera senza la Girò non è possibile» - e modellava i suoi lavori sulle doti di lei. Fu appunto l'intimo rapporto personale con la Girò a scatenare l'avversione del cardinale Ruffo nei confronti del compositore. In contrasto con taluni tratti assai liberi della sua condotta di vita mondana, troviamo in Vivaldi un'altra caratteristica: la religiosità, così argutamente descritta da Goldoni. Ce ne dà conferma Gerber il quale giunse a dire che il maestro col passar degli anni divenne bigotto al punto di deporre il rosario unicamente quando si metteva a comporre.
L'incontro di Goldoni con Vivaldi è estremamente interessante. Goldoni aveva ricevuto incarico di ritoccare il libretto dell'opera Griselda di Zeno e renderlo conforme al gusto del compositore.
Si recò a trovarlo nella sua abitazione: «Lo trovai circondato di musica e col Breviario in mano. Si leva, si fa il segno della croce per lungo e per largo, mette il suo Breviario da banda, e mi fa il complimento ordinario: “Qual è il motivo, Signore, che mi procura il piacere di vedervi?». Il musicista accolse Goldoni distrattamente e alla fine gli diede carta e penna perché gli dimostrasse quanto valeva.
«L'abate ridendosi di me presentami il dramma, mi dà carta e calamaio, riprende il suo Breviario, e passeggiando recita i suoi Inni e i suoi Salmi. Io rileggo la scena che già mi era nota; fo l'epilogo di ciò che il musico desiderava e in meno di un quarto d'ora stendo sulla carta un'aria di otto versi divisa in due parti. Chiamo il prete e gli fo vedere la mia composizione. Vivaldi legge, raggrinza la fronte, rilegge, fa gridi di gioia, getta via il suo Breviario e chiama Madamigella Girau. Ella viene. “Ah - disse egli - questo è un uomo raro, un poeta eccellente; leggete quest'aria: è questo Signore che l'ha fatta qui, senza muoversi, in meno di un quarto d'ora. Ah Signore vi domando perdono", e mi abbraccia, e mi protesta che non si servirà mai d'altro poeta che di me e mi ordina altri cambiamenti. Rimane sempre contento di me e l'opera riesce mirabilmente».
Vivaldi, come creatore, appartiene al tipo dell'artista precoce e rapido nel lavoro, quali furono poi Pergolesi, Mozart, Schubert e Mendelssohn. Ai suoi tempi, l'editoria e il commercio di opere musicali erano ancora assai poco sviluppati, e i maestri di cappella dovevano provvedere prevalentemente di propria mano agli enormi bisogni di musiche richieste dalla carica che ricoprivano. La capacità di produrre con rapidità e in abbondanza era perciò un requisito professionale indispensabile e sottinteso e, per questo, era posseduto da molti contemporanei di Vivaldi.
Veramente eccezionale deve essere stata la sveltezza con la quale Vivaldi lavorava, se egli riuscì a destare stupore in un'epoca così ricca di musicisti rapidi e fecondi. Egli pareva divertirsi ad esercitare il proprio mestiere in maniera così spiccia. E se ne vantava. Il 29 agosto 1739 Charles de Brosses scrisse all'amico ·de Blancey riguardo a Vivaldi: «È un vecchio che ha una prodigiosa furia di composizione. L'ho sentito vantarsi di comporre un concerto, con tutte le sue parti, in tempo minore di quel che non occorrerebbe a un copista per copiarlo». La rapidità creativa e, per conseguenza, l'enorme numero di opere dei compositori barocchi, dipendevano da cause diverse e svariate. Contrariamente ai pubblici moderni, abituati ad ascoltare musiche composte entro un arco di tempo di tre, quattrocento anni, il pubblico di Vivaldi viveva di prime esecuzioni. Se Bach continuò a comporre una o due Cantate a settimana per tanti anni, è perché la gente tutte le domeniche e gli altri giorni festivi voleva ascoltare qualcosa di nuovo.
Il dover produrre incessantemente era assai gravoso per un compositore. Ciò spiega la debolezza di alcuni lavori vivaldiani, evidentemente di routine, vale a dire scritti tanto per poterli consegnare ed eseguire entro il termine prefisso. La capacità di scrivere rapidamente era anche e soprattutto richiesta nel mondo operistico dei secoli XVII e XVIII. L'impresario predisponeva una stagione a lunga scadenza e, prevedendo per ogni opera un dato numero di esecuzioni, il cartellone risultava completo. Ma se un'opera inaspettatamente cadeva, bisognava trovare il modo di sostituirla al più presto. Vivaldi fu più volte chiamato a salvare situazioni disperate: «Musica del Vivaldi fatta in 5 giorni», leggiamo sull'autografo dell'opera Tito Manlio. Molti suoi manoscritti rispecchiano la fretta. Ludwig Landshoff, nella prefazione all'op P 228 da lui edita, descrive l'impressione riportata dallo studio di quella partitura: «Vivaldi, quando scriveva, era come un ossesso. Con l'accrescersi della foga creativa, la sua già estrosa grafia si faceva di pagina in pagina più fluente e volante: evidentemente la penna stentava a tener dietro al prorompere irrefrenabile delle idee».
Anche se è vero che spesso Vivaldi compose rapidamente, un riesame degli autografi torinesi ha messo in luce che egli correggeva molte cose e non era dunque così acritico di fronte alle sue creazioni come sostenevano alcuni contemporanei. Anche dal punto di vista quantitativo, la produzione di Vivaldi, se la si confronta con quella di Bach, Telemann, Haendel, Haydn e Mozart, stava entro limiti, per i tempi, assolutamente normali; il numero globale delle sue opere non ci autorizza a classificarlo un compositore esageratamente prolifico. I maestri del secolo XVIII scrivevano fuori da ogni prospettiva storica, le opere dei loro predecessori erano già scomparse dalla circolazione oppure passavano già per antiquate e quindi raramente erano eseguite. Poche o nulle erano le possibilità di confronto sia per gli autori che il pubblico. Haydn e Mozart furono i primi compositori le cui opere fossero ancora note e ascoltate quando, verso la fine del secolo, andava formandosi qualcosa come un repertorio in una prospettiva storica. Vivaldi, cresciuto in un'epoca di enorme e sempre crescente consumo musicale, venne a trovarsi in una situazione professionale e con una tecnica perfettamente concordanti con le abitudini della società in cui viveva, e di cui poteva soddisfare le esigenze musicali con l'abbondanza della produzione.
Sua principale caratteristica non è l'aver scritto molto, bensì l'alta qualità di almeno una parte delle sue opere che egli, compatibilmente con il tempo e le circostanze, non si stancava di limare in una costante ricerca di perfezione.
Le Quattro Stagioni di Vivaldi sono una delle opere popolari più amate della letteratura musicale di ogni tempo. Si tratta di un grande affresco musicale che rimanda alla pittura veneziana del 1700 Canaletto, Guardi, Tintoretto. È uno dei primi esempi di musica figurativa.
Che cosa significa musica figurativa? Per musica figurativa si intendono composizioni ispirate da fatti diversi dalla musica. In questo caso è una descrizione delle stagioni dell'anno accompagnate da sonetti che ne indicano le varie fasi. Suggeriscono paesaggi e atmosfere dai colori e situazioni ogni volta differenti. I temi ricorrenti sono il cinguettio degli uccelli, lo scorrere dei ruscelli, le tempeste estive, le nevicate invernali, e i toni caldi dell'autunno. Vivaldi un giorno fece una passeggiata per la campagna mantovana, annotando su un taccuino le sensazioni che la natura gli suggeriva. Rientrando a casa quella sera tradusse le sue annotazioni in versi e in musica.
Vivaldi ha aperto nuove strade che hanno reso possibile a molti compositori nuove evoluzioni di linguaggio e di struttura. Bach apprezzava moltissimo le composizioni di Vivaldi e ne trascrisse alcune per clavicembalo ed altri strumenti.






