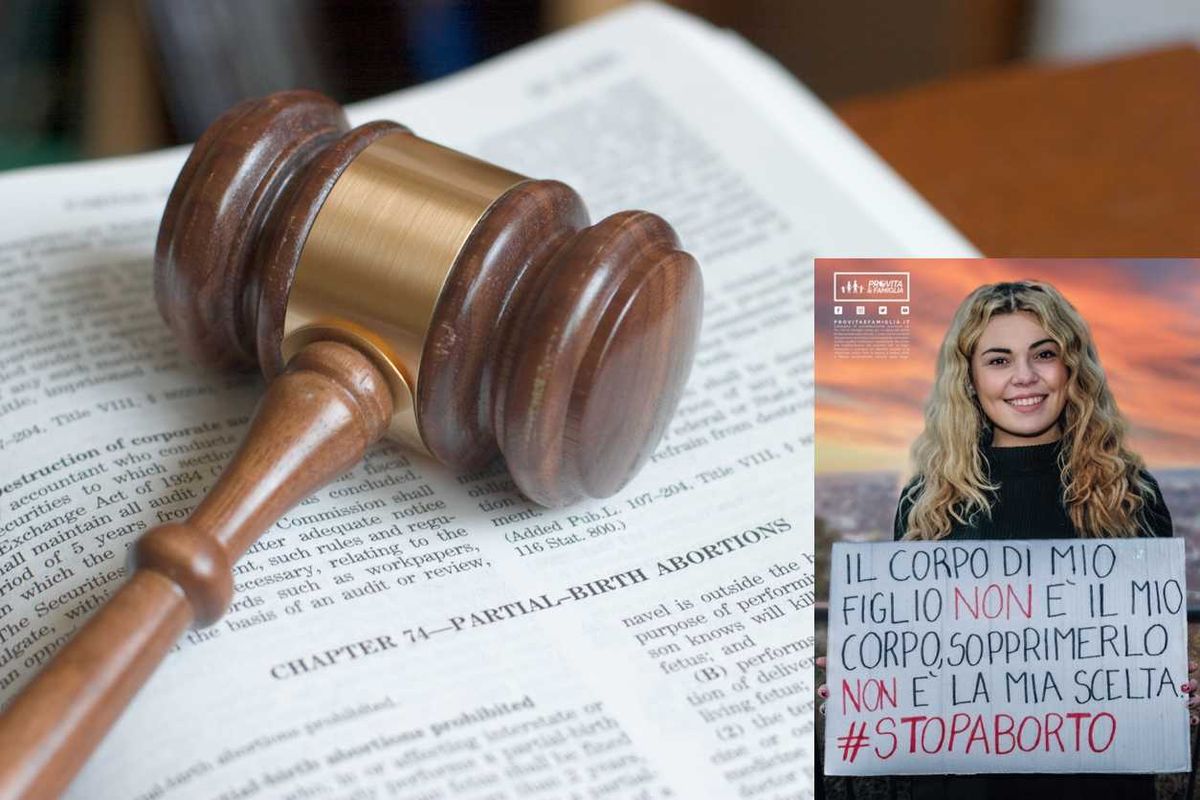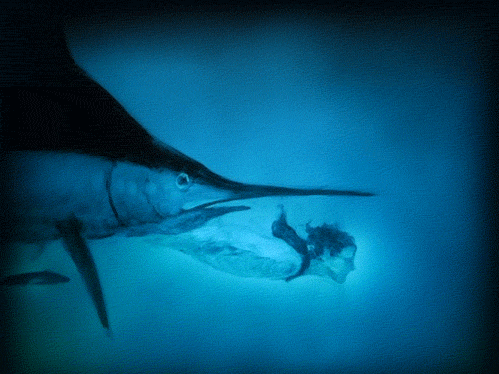
La sua storia è ammantata di leggenda. Sembra che avesse già colpito la fantasia di Omero quando, tra le insenature di Scilla e Cariddi, fece passare Ulisse e gli argonauti. In una sorta di… darwinismo al contrario, si racconta che i mirmidoni, valorosi guerrieri della Tessaglia, per vendicare l'uccisione da parte dei troiani del loro comandante Achille (quello dal tallone fragile) li sfidarono alla lotta. Tuttavia, al loro defilarsi, queste truppe si lasciarono andare, in silenzioso abbandono, tra le acque dei flutti. Colpita da tale fedeltà al loro condottiero, la madre di Achille, Tetide, li trasformò in vigorosi pesci armati di una spada, a testimonianza del loro valore. Pesce spada che continuò a bucare l'immaginario collettivo nei secoli, con Polibio prima e Strabone poi, che ne esaltò la caccia paragonandola solo a quella del cinghiale, in terraferma.
Una zona, quella dello stretto, via di passaggio tra le acque fredde del Tirreno e quelle calde dello Jonio. Pesce solitario vi giunge verso fine aprile, nella stagione degli amori, costeggiando la costa calabra dal Tirreno allo Jonio per ridiscendere dopo, tra luglio e agosto, lungo la costa siciliana. Ed è in questa stagione che si trasforma da cacciatore delle profondità a giocherellone amoroso con la compagna, intrattenendosi spesso a pelo d'acqua, e questo lo sanno bene i suoi cacciatori, perché quando si parla di pesce spada il termine usato è caccia, e non pesca. Sviluppatasi all'inizio sul versante calabrese dove, piazzate sui promontori le vedette (u' banniaturi) per secoli avvertivano le scialuppe della sua presenza. Solo verso il Cinquecento si sviluppò la pesca anche sul versante siciliano, posto che la costa, generalmente sabbiosa, non poteva offrire punti di avvistamento adeguati. Ma qui subentrò l'ingegno e alcune barche vennero trasformate con delle torri di veduta che, progressivamente, passarono da 5 a quasi 30 metri. Barche stanziali, zavorrate perché poi la caccia alla preda avveniva con la veloce luntre, spinta dal vigore dei marinai. Cosa curiosa era che queste barche procedevano… al contrario, ovvero navigando di poppa, posto che era su questa che si poneva u'illanzaturi, il fiocinatore, con una migliore base di appoggio per poter lanciare la sua draffinera.
Verso fine Ottocento la tecnica si era perfezionata, al punto che dai 30 metri della torretta u'intinneri (l'uomo in cima) dava le dritte una volta avvistata la preda. Un vecchio detto recitava che queste due figure «sunnu chitarra e mandulinu» da quanto dovevano essere coordinate. Tradizione trasmessa per eredità familiare. A Ganzirri, versante messinese, era prassi che il fiocinatore venisse addestrato sin da piccolo a centrare bucce d'arancia che galleggiavano sul mare. Mentre l'antenniere cominciava a salire verso il cielo sui pioli della barca già verso i 10 anni. Il segreto era avvicinarsi alle spalle dello spada, meglio se quando in parighhia, cioè in coppia. Colpendo prima la femmina, il maschio sarebbe rimasto nella mischia (e quindi catturato a sua volta). A lungo si è discettato su questo aspetto dai sentori deamicisiani, contorni d'amore e morte. Tanto che le due spade innamorate furono ben immortalate da Domenico Modugno con il suo Lu pisci spada del 1954. La verità è stata scoperta recentemente, in quanto molti non si spiegavano come mai, se colpito prima il maschio, la femmina se ne andava per i fatti suoi. In realtà quest'ultima, una volta ferita, emette degli ormoni che, disperdendosi nell'acqua, coinvolgono il maschio in una lotta all'ultimo guizzo con il pescatore.
Una caccia dai mille risvolti. Sullo stretto i mastri firrara erano un'autorità. Forgiavano l'arpione nel segreto della loro fucina. Non li vendevano, ma li noleggiavano ai pescatori che, in cambio, portavano poi loro parte della pesca. Storico il nome di Ninu Puglisi. C'era la fila davanti alla sua bottega all'inizio della stagione. Come è vero che il rito della pesca prevedeva la scialata (o schiticchio) una sorta di pranzo che i padroni offrivano nei mesi invernali per selezionare il futuro equipaggio, quando le barche venivano benedette dal parroco del paese e poi salpavano dopo il 25 marzo, giorno di San Marco, per tradizione apertura della stagione di pesca. A San Marco andavano i ringraziamenti se la caccia era fruttuosa mentre una prece a Santa Maria biniditta era levata al cielo prima di gettare l'arpione in acqua. Una tradizione viva al di qua e al di là dello stretto tanto che la forza, il coraggio, il legame di coppia hanno reso il pesce spada un simbolo di potenza e rettitudine, avversario di lotta al pari dell'uomo, in una sorta di antropoformizzazione tra chi si confronta in maniera epica. Un bel documentario è stato girato, nel 1954, da Vittorio De Seta, con il suo Lu tempo di li pisci spata, come ai pescatori di Scilla ha dedicato un dipinto Renato Guttuso. Una creatura dell'acqua dai tratti affascinanti. Può viaggiare anche oltre i 90 all'ora. Spada che gli serve per la caccia con la quale stordisce la preda (seppie, calamari, una predilezione per le anguille) ma anche per difendersi dagli squali, dai tonni, oltre che dall'uomo. Negli anni Cinquanta il cambio di passo, con la feluca a motore che, dotata di una alta torre e una lunga passerella a prua, ha mandato in pensione la luntra. La caccia nello stretto, oramai, è una procedura in via di estinzione, soppiantata dalla pesca in mare aperto. Anche lo spada, come il tonno, è considerato una sorta di maiale del mare, di cui non si butta via niente. Per tradizione, un tempo, una volta issato sulla feluca, i marinai incidevano con un'unghia una sorta di cardata di cruci (croci doppie) sotto l'occhio dell'animale, come segno di rispetto. Dopo di che veniva prelevata la carne della testa «il ciuffo» (o scurzetta, in siciliano) che, per tradizione, veniva offerta al feudatario locale. Assieme al ciuffo veniva prelevata la bbotta, la parte posta attorno all'arpione. Ciuffo e bbotta sono la componente principale della ghiotta, un goloso condimento di pasta, in particolare le casarecce. La parte più grassa dell'addome dà dei tranci che vanno bene arrosto, ma può anche essere impanata e fritta, dando luogo agli involtini che trovano la loro variante messinese che li vede ripieni di caciocavallo, altro spada macinato, pangrattato e basilico, mentre sul versante calabro si usa la surra, ovvero lo stomaco.
Un tempo il grasso tra le venature ossee della pinna dorsale erano una sorta di merenda, a crudo, per i marinai prima di tornare a riva. Più volte citato da Alexandre Dumas padre, noto gourmet. Nel 1860, al seguito delle truppe garibaldine in Sicilia, lo spada era presenta abitualmente nel menù riservato allo stato maggiore anche se, in una sua precedente esperienza del 1835, proprio sulla barca dei pescatori, lo stesso Dumas aveva rifiutato la più ricercata leccornia dell'equipaggio: il midollo da risucchiare dalla spada tagliata apposta dal comandante. Spada cui fu attribuito l'onore di un'udienza papale, nel 1896, quando la comunità di Scilla ne volle fare dono a papa Leone XIII. Il pesce è eclettico in cucina, considerata l'assenza di lische, ma anche le proprietà di una carne ricca di proteine e povera di grassi. L'elenco potrebbe proseguire all'infinito, anche se la citazione della staffa golosa va a una ricetta di Leonida Repaci, scrittore nativo di Palmi, divenuto toscano d'adozione, fondatore e a lungo presidente del Premio Viareggio. Lo preparava con salsa al salmoriglio (un mix siculo calabrese di aromi vari) passato poi al tegame «da far leccare le lerfie (labbra) pure ai morti». E se lo confermavano quei toscanacci di cui si era circondato Repaci, c'è da credervi.