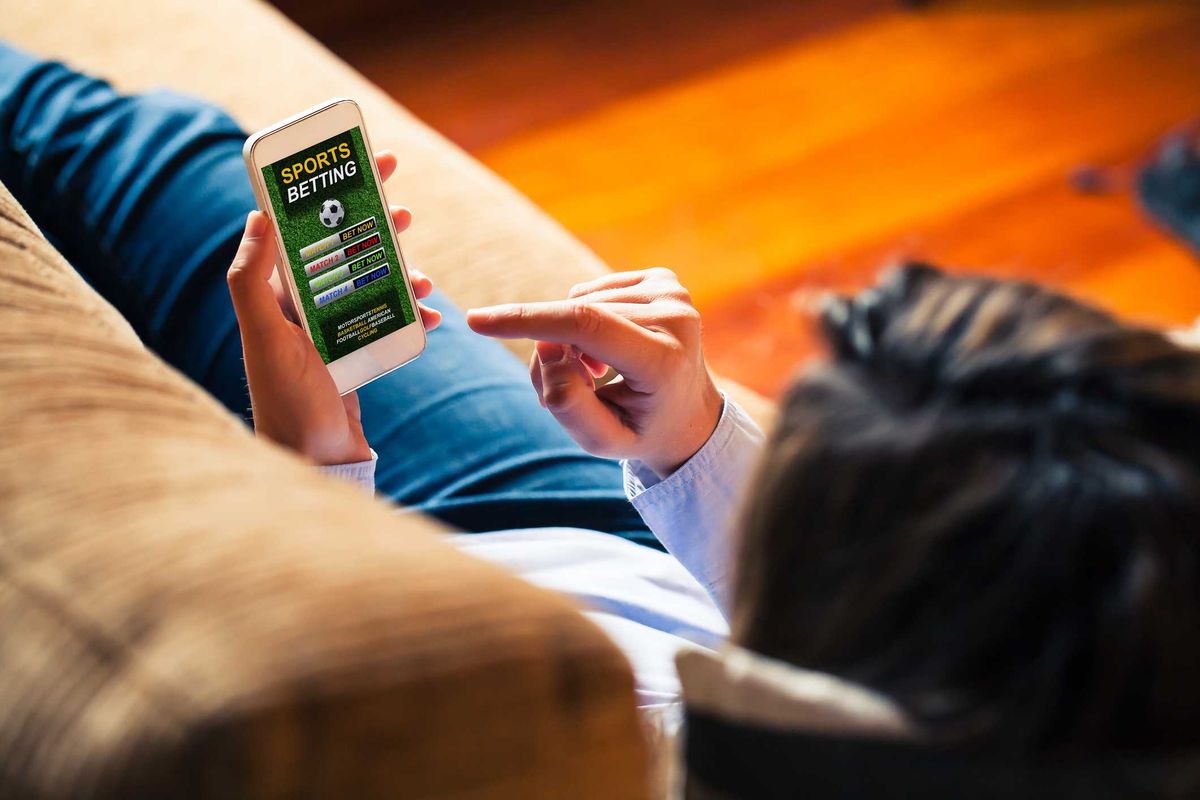Urbex - ossia urban exploration - è il termine con cui ci si riferisce all'esplorazione di luoghi abbandonati nell'ambiente urbano (e non solo), a opera di appassionati, curiosi e fotografi. Da Consonno (Lecco) a Monteruga (Lecce), passando per Castel d'Alfero (Forlì-Cesena), Galeria Antica (Roma) e Rocchetta Alta (Isernia) percorriamo lo Stivale alla scoperta di cinque paesi fantasma.
Urbex - ossia urban exploration - è il termine con cui ci si riferisce all'esplorazione di luoghi abbandonati nell'ambiente urbano (e non solo), a opera di appassionati, curiosi e fotografi. Da Consonno (Lecco) a Monteruga (Lecce), passando per Castel d'Alfero (Forlì-Cesena), Galeria Antica (Roma) e Rocchetta Alta (Isernia) percorriamo lo Stivale alla scoperta di cinque paesi fantasma.Lo speciale contiene un articolo e cinque approfondimenti.Il fascino dell'abbandono colpisce non solo e non tanto gli amanti della grande storia, quanto i feticisti dell'immaginazione e del brivido. Una sorta di voyeurismo che rende onore al dimenticato e che riporta a galla fatti e segmenti di vite, singole e collettive. Ex manicomi, paesi fantasma e fabbriche dismesse seducono in maniera oscura, forse in quanto sottili diaframmi tra la vita e la morte. A differenza di un classico reperto archeologico, che si perde lontano nel tempo, forse smorzando le emozioni connesse alla fine, la sedia a rotelle mezzo divorata dalla natura funge da perturbante sulla coscienza di chi pratica questo genere di turismo (chiamato anche turismo dell'oblio).Dimentichiamoci atrii accoglienti e orari di ingresso e di uscita: ad attenderci, porte sbattute dal vento e orologi fermi da secoli. Le pitture rupestri? Sostituite da murales che chiedono al visitatore temerarie interpretazioni.In fin dei conti, l'urbex è la versione contemporanea dell'archeologia ma, a differenza di quest'antica disciplina, non ha un approccio scientifico e non punta alla classificazione. La urban expoloration è, appunto, attività da esploratori con una predilezione per il difforme, l'isolato, il macabro. Pavimenti instabili, oggetti obsoleti e posti dimenticati si fanno guardare con curiosità e fotografare, come freaks architettonici spesso colonizzati dalla natura, unica testimone di una vita ancora palpitante.Ma dove fare urbex, in Italia e nel mondo? Uno dei siti più celebri è Kolmanskop, in Namibia. Chi non ha mai visto almeno una fotografia di quelle che furono, un tempo, porte aperte, porte attraversate e porte chiuse, tra le quali oggi scorre solo la sabbia, a coprire voci che non ci sono più? Il villaggio, ormai abbandonato, ebbe il suo massimo splendore negli anni Venti del secolo scorso, in quanto miniera di diamanti a cielo aperto.E come non citare l'aereo di Sólheimasandur a Vik, in Islanda? La carcassa che rimane del velivolo dell'aeronautica americana è estremamente popolare tra gli amanti dei luoghi abbandonati. Fortunatamente nessuna storia tragica dietro al tetro monumento, che ricorda invece un atterraggio d'emergenza finito bene.Altro luogo lasciato al proprio è Detroit, nello Stato del Michigan. Città industriale e ricchissima fino a non molto tempo fa, è oggi il simbolo mondiale della decadenza, anche se in ripresa. Un viaggio che potrebbe rivelarsi terapeutico, o almeno istruttivo, non solo per gli appassionati di urbex, ma per tutti coloro che vogliono trarre insegnamento dalle sorti del capitalismo e dall'unica regola non scritta della vita: la sua finitudine.Eppure, c'è abbandono e abbandono. Se, in alcuni casi, gli edifici abbandonati sono assimilabili a corpi privi di vita, in altri prevale un senso di trascendenza. Si pensi al tempio buddista di Angkor Wat, in Cambogia. Il suo orientamento a ovest (tipico dei mausolei), la perfetta armonia tra natura e architettura e il silenzio parlante delle sculture conferiscono a questo luogo qualità ultraterrene.L'assenza di vita, a volte, copre invece la tragedia con la sua apparente tranquillità. Viene in mente Černobyl'. La città ucraina, tristemente famosa per il disastro nucleare del 1986, è oggi meta di un turismo dai tratti inquietanti. Rievocare il dolore indossando caschi e rilevatori di radiazioni: qual è il confine tra fame di conoscenza e morbosità? Ma qui sforiamo nel dark tourism. Un'espressione fuorviante, in realtà, spesso assimilabile all'urbex. In questo caso sarebbe meglio parlare di cattivo gusto. L'urbex, talvolta, sconfina anche nell'illegalità, sia per la violazione di luoghi formalmente non concessi ai visitatori che per la pericolosità di alcune location. Caso esemplare fu quello di Philibert Aspairt, portinaio francese e fondatore della urban exploration: morì nelle catacombe di Parigi dopo esservi entrato abusivamente e il suo corpo fu ritrovato solo nel 1804, 11 anni dopo la scomparsa.Crolli, agenti tossici, vetri rotti, terreni friabili: bisogna fare i conti con i rischi legati a questo tipo di turismo, indubbiamente connesso con la ricerca di senso, ma spesso praticato da persone che dimenticano il contatto con la realtà. Una precisione doverosa, da parte nostra, prima di accompagnarvi in un viaggio tra alcune delle mete italiane preferite dai coloro che riescono a trovare bellezza tra cumuli di polvere, detriti e porte scrostate. Visiteremo cinque paesi fantasma, accompagnati solo dalle voci tremule del vento e degli spettri, gli unici abitanti di questi luoghi. Ma perché proprio i paesi fantasma? Perché siano un monito per le generazioni future: come ritroveremo i nostri borghi tra qualche anno?Purtroppo l'esodo verso le grandi città ha lasciato i segni sulle realtà più piccole, che oggi ci ritroviamo a fotografare come attoniti di fronte alla loro scomparsa.<div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/turismo-citta-scomparse-paesi-fantasma-2653371904.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="consonno-lecco" data-post-id="2653371904" data-published-at="1623683517" data-use-pagination="False"> Consonno (Lecco) Consonno (iStock) Il nostro tour urbex parte dalla Lombardia e, precisamente, dalla provincia di Lecco. Qui si trova Consonno, una delle tappe più conosciute dagli amanti dei luoghi abbandonati, ma anche dell'archeologia industriale.Il borgo fantasma deve il suo fascino attuale al conte Mario Bagno, che all'inizio degli anni Sessanta voleva trasformarlo in una città dei balocchi. Dopo averlo acquistato, il Grande Ufficiale procedette alla demolizione di quasi tutti gli edifici precedenti.L'intenzione dell'eccentrico nobile e imprenditore era quella di dare vita a una Las Vegas brianzola, kitsch come l'originale, attraverso la riproduzione di architetture arabeggianti, orientaleggianti, medievaleggianti. I suoi sogni vennero prima realizzati e poi infranti da una frana, che nel 1976 spazzò via tutto. O quasi. Rimangono i resti, a partire dal minareto, cuore del paese fantasma. Della galleria commerciale, posta alla base dell'edificio che lo sostiene, rimane invece ben poco oltre ai muri scrostati e ad alcuni tentativi di street art. Poco più in là, la sala da ballo all'aperto. Sembra ancora di sentire la musica tipica delle balere, resa tetra da un'eco immaginaria. La fantasia vaga nella fatiscenza, cercando di colmare le parti mancanti. L'unico edificio scampato sia alla frana che alla visione di Mario Bagno è la chiesa di San Maurizio, la cui costruzione risale al Medioevo. Viene ancora usata per le funzioni religiose, una delle poche forme di vita rimaste in questa frazione.Presenze umane arrivano anche dall'Associazione Amici di Consonno, che tiene in vita il borgo scomparso ormai da anni, ripulendo le aree verdi e organizzando eventi (Covid permettendo).Visitare questa frazione lombarda (il comune è Olginate) significa tornare agli anni del boom economico, che in qualche modo voleva mettere in scena. Vi arrivavano, per esibirsi, personaggi del calibro di Mina e Adriano Celentano, motivo per cui Consonno può essere considerato una specie di inno alla vita, il luogo delle feste. Sui pochi muri rimasti potrebbe esserci scritto «carpe diem». <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/turismo-citta-scomparse-paesi-fantasma-2653371904.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="castel-d-alfero-forli-cesena" data-post-id="2653371904" data-published-at="1623683517" data-use-pagination="False"> Castel d'Alfero (Forlì-Cesena) La stazione di Castel d'Alfero (Wikimedia Commons) Il secondo luogo abbandonato della serie è il romagnolo Castel d'Alfero (frazione di Sarsina), fondato nel IX secolo e morto negli anni Settanta a causa dello spopolamento subito dai borghi italiani.La Soprintendenza per i beni paesaggistici ed architettonici lo ha sottoposto a vincolo monumentale, visto il valore storico-artistico dei suoi edifici: le poche case in pietra che lo compongono, infatti, presentano elementi tipici dei Maestri Comacini, artigiani e artisti del regno longobardo.Il borgo che vediamo oggi era (come suggerito dal nome) un piccolo castello protetto da una cinta muraria, di cui oggi rimangono pochi resti. Come la porzione dell'antica rocca, che si trova all'interno di un'abitazione. Oggi Castel d'Alfero è uno dei luoghi del cuore del Fai, che l'anno scorso ha organizzato visite guidate in questo piccolo centro dal fascino antico e decadente. La bellezza del luogo è data, oltre che dalla sua storia, anche dalla natura circostante: situato nell'Appennino Tosco Romagnolo, dista pochi minuti dalla bellissima Cascata dell'Alferello, chiamata anche «Cascata delle trote». Un salto di circa 30 metri, che forma diverse pozze d'acqua, di cui una («Il pozzo») balneabile.A chi è adatto il paese fantasma dell'Emilia Romagna? Agli amanti del verde, della storia e del silenzio, non certo a chi cerca monumenti di grande impatto visivo. L'emozione di questo genere di luoghi è sottile, perfetta per chi è sensibile a cose e persone segnate dal tempo e da eventi naturali come i terremoti.Chi sa andare al di là delle impalcature e delle ferite, chi trae pace dall'osservare la storia pietrificata e la natura che se ne impossessa non può mancare all'appuntamento. A maggior ragione se è un amante del trekking: Castel d'Alfero, infatti, può essere raggiunto attraverso il sentiero delle cave di pietra, che conduce attraverso valli e calanchi. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem5" data-id="5" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/turismo-citta-scomparse-paesi-fantasma-2653371904.html?rebelltitem=5#rebelltitem5" data-basename="galeria-antica-roma" data-post-id="2653371904" data-published-at="1623683517" data-use-pagination="False"> Galeria Antica (Roma) Galeria Antica (Wikimedia Commons) A qualche chilometro da Roma sorge un paese fantasma poco conosciuto persino tra gli stessi romani: Galeria Antica.Non è immediato trovarlo. Bisogna prima raggiungere il borgo di Santa Maria di Galeria e da lì percorrere qualche centinaio di metri, fino a una strada sterrata. Si prosegue a piedi nel bosco, finché lo sterrato non diviene un ammasso di sampietrini, che conducono alla meta.Particolarità di Galeria Antica è il suo essere Monumento Naturale dal 1999. Da allora, infatti, fa parte delle aree protette romane per via delle innumerevoli specie, soprattutto vegetali, che vi si trovano.Siamo nell'Agro Romano, laddove i nostri passi vengono accompagnati dallo scrosciare del fiume Arrone. Camminare tra i ruderi della città morta è un'esperienza da fare, soprattutto se si ama la natura, che - come sempre accade - ha ormai preso il sopravvento sulla mano dell'uomo. Non sappiamo ancora se il paese fu fondato dai Galerii o dagli Etruschi. È comunque certa la dominazione romana e anche quella di epoca medievale, come l'architettura dei ruderi dimostra. Ci fu poi un passaggio di proprietà da una famiglia nobile all'altra, fino al definitivo abbandono, avvenuto nell'Ottocento a causa di un'epidemia di malaria.Un abbandono assai strano, in quanto precipitoso al punto che i morti non vennero nemmeno seppelliti. Sarà per questo che intorno a Galeria Antica gira la leggenda del fantasma Senz'Affanni? Pare che lo si possa sentire mentre intona un canto alla sua amata ogni volta che il fiume Arrone è in piena.Tra le rovine spicca il campanile, appartenuto alla settecentesca chiesa di San Nicola. L'orologio non segna più le ore e lascia senza fiato i visitatori che si fermano ai suoi piedi.Una volta usciti dal borgo abbandonato, si attraversano nuovamente i grandi campi fioriti, che danno una nota di colore all'ombra e al grigio che dominano nella zona un tempo abitata.Visitare pure Galeria Antica, ma - come già raccomandato - prestate la massima attenzione, sia alle rovine pericolanti che alle pareti a strapiombo che si aprono, spesso all'improvviso, sotto la vegetazione. <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem4" data-id="4" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/turismo-citta-scomparse-paesi-fantasma-2653371904.html?rebelltitem=4#rebelltitem4" data-basename="rocchetta-alta-isernia" data-post-id="2653371904" data-published-at="1623683517" data-use-pagination="False"> Rocchetta Alta (Isernia) Rocchetta Alta (iStock) Incastonata in un paesaggio suggestivo quanto solitario, Rocchetta Alta si fa notare già da lontano per via della sua posizione arroccata su uno sperone di roccia.Come Galeria Antica, fu anch'essa distrutta dai Saraceni. Il suo progressivo abbandono ha permesso alla vegetazione di infiltrarsi tra porte e finestre, unica abitante - insieme a uccelli e animali - di questi ruderi lasciati a sé stessi da anni. Sullo sfondo, le Mainarde Molisane e ai piedi le sorgenti del Volturno.Poco prima di arrivare, si supera un abitato, anche se nemmeno qui sembra esserci traccia di essere umano. Del resto, il fascino del Molise consiste proprio nel suo essere una regione defilata, i cui abitanti sembrano preferire le mura di casa, lasciando agli sparuti turisti l'onere e l'onore di scoprire le bellezze locali.Di fronte all'ingresso del paese fantasma, una scritta sbiadita - MUNICIPIO - cattura l'attenzione, ricordandoci che Rocchetta Alta non è un ammasso di pietre senz'anima, ma un luogo che ha visto uomini e donne vivere tra i suoi vicoli.Salendo, ci si trova davanti a una chiesa, al cui esterno, sopra una croce in ferro, una lapide marmorea commemora i caduti in guerra. Si susseguono abitazioni, modeste e non, dietro ai cui portali svettano fichi e altre piante che si sono fatte spazio a forza tra un piano e l'altro. Sulla sommità, ciò che rimane del castello di Battiloro. Da qui si può godere di una vista privilegiata sulle montagne circostanti, ma bisogna fare molta attenzione a dove si mettono i piedi.I dintorni di Rocchetta Alta sono altrettanto affascinanti. A pochi chilometri si trova il Lago di Castel San Vincenzo, specchio artificiale che prende il nome da un borgo che vale una visita anche solo per gli scorci panoramici di indimenticabile bellezza.Da non dimenticare l'Abbazia di San Vincenzo al Volturno, a Rocchetta al Volturno, che affonda le sue radici ai tempi dei Longobardi. È assolutamente da vedere la cripta dell'abate Epifanio, vero e proprio capolavoro visitabile solo su prenotazione (trovate gli orari sul sito dell'abbazia). <div class="rebellt-item col2" id="rebelltitem6" data-id="6" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/turismo-citta-scomparse-paesi-fantasma-2653371904.html?rebelltitem=6#rebelltitem6" data-basename="monteruga-lecce" data-post-id="2653371904" data-published-at="1623683517" data-use-pagination="False"> Monteruga (Lecce) Monteruga (iStock) Monteruga è un borgo abbandonato in mezzo alle campagne salentine.Costruito durante il Fascismo e spopolatosi negli anni Ottanta, è oggi meta dei pochi turisti che ne hanno sentito parlare. Facendosi largo tra le palme e i cieli azzurri di Puglia, si possono ammirare quelle che furono le case dei contadini - che qui coltivavano il tabacco - e i negozi abbondati, oltre alla scuola e alla chiesa di Sant'Antonio Abate. Ma c'erano anche un frantoio, un campo da bocce e il tabaccaio, il dopolavoro e la caserma, a scandire una quotidianità fatta di sudore e pochi momenti dedicati allo svago.Entrando negli edifici, si possono ancora trovare oggetti di uso quotidiano: qui un paio di pantofole abbandonate, lì un letto sfondato. Nella chiesa c'è ancora l'altare davanti a cui il prete officiava le diverse funzioni, oggi ricoperto dall'intonaco caduto. Sono rimaste anche le panche in legno per i fedeli.Monteruga venne lasciato a causa dei grandi centri urbani, che nel tempo hanno assorbito gli abitanti dei piccoli centri. Eppure ancora oggi sembra vivere di vita propria. Sarà che qui la natura ha relativamente preso il sopravvento sulle architetture: siamo infatti in una terra arsa dal sole e il verde dell'erba e del fogliame non copre i colori caldi delle poche strutture rimaste.Il paese, circondato da ettari di macchia mediterranea, è situato all'incrocio tra Nardò, Avetrana, San Pancrazio e Salice Salentino, a pochi chilometri da quel mare turchese che attira migliaia di turisti ogni anno. Chissà se l'abbandono di Monteruga verrà sfruttato e riconvertito dal genio e dai soldi di qualche imprenditore. O se, in fin dei conti, la memoria di quello che fu, lasciata al suo destino, non abbia un senso anche solo per il manipolo di fotografi e appassionati che sono in grado di coglierlo.Oggi Monteruga è proprietà privata, ma i progetti elaborati intorno al paese fantasma non sono diventati ancora realtà. A presidiarlo ed abitarlo, oggi, c'è solo il custode.
Giorgia Meloni (Ansa)
L’inquilina del Nazareno prova ad attaccare il premier: «Aiuta i più ricchi». Il leader del M5s però la lascia sola a inseguire Maurizio Landini: «Imposta non all’ordine del giorno». Idea della Lega: flat tax al 5% per gli under 30.
Non pare vero alla sinistra di avere ora un modello Oltreoceano a cui ispirarsi. La vittoria di Zohran Mamdani a New York, con la sua ricetta di tassare i ricchi, ha ridato forza alla Cgil per riaprire il dibattito sulla patrimoniale. Il tema che fa parte del Dna della sinistra torna ciclicamente, fa capolino ogni volta che c’è da cannoneggiare una manovra economica considerata poco generosa con i ceti meno abbienti. E il programma con cui Mamdani è riuscito a conquistare la Grande Mela, che ha come pilastro un prelievo sui grandi patrimoni, è un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, l’ha colta al volo e, cavalcando l’ondata di entusiasmo che il neo sindaco ha scatenato nella sinistra, ha ritirato fuori dal cassetto la proposta di una patrimoniale. Ovvero, un contributo straordinario dell’1% sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro. Secondo il sindacato, garantirebbe entrate fino a 26 miliardi di euro da destinare a sanità, scuola e lavoro. Il retropensiero di Landini è che se la proposta ha mietuto consensi nella capitale americana del business, si può rilanciarla in Italia, dove i soldi scarseggiano e la coperta dei finanziamenti è sempre corta. Tanto più che, secondo la narrazione del sindacalista, il governo si appresterebbe a stornare le poche risorse disponibili dalla sanità alle spese militari.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!