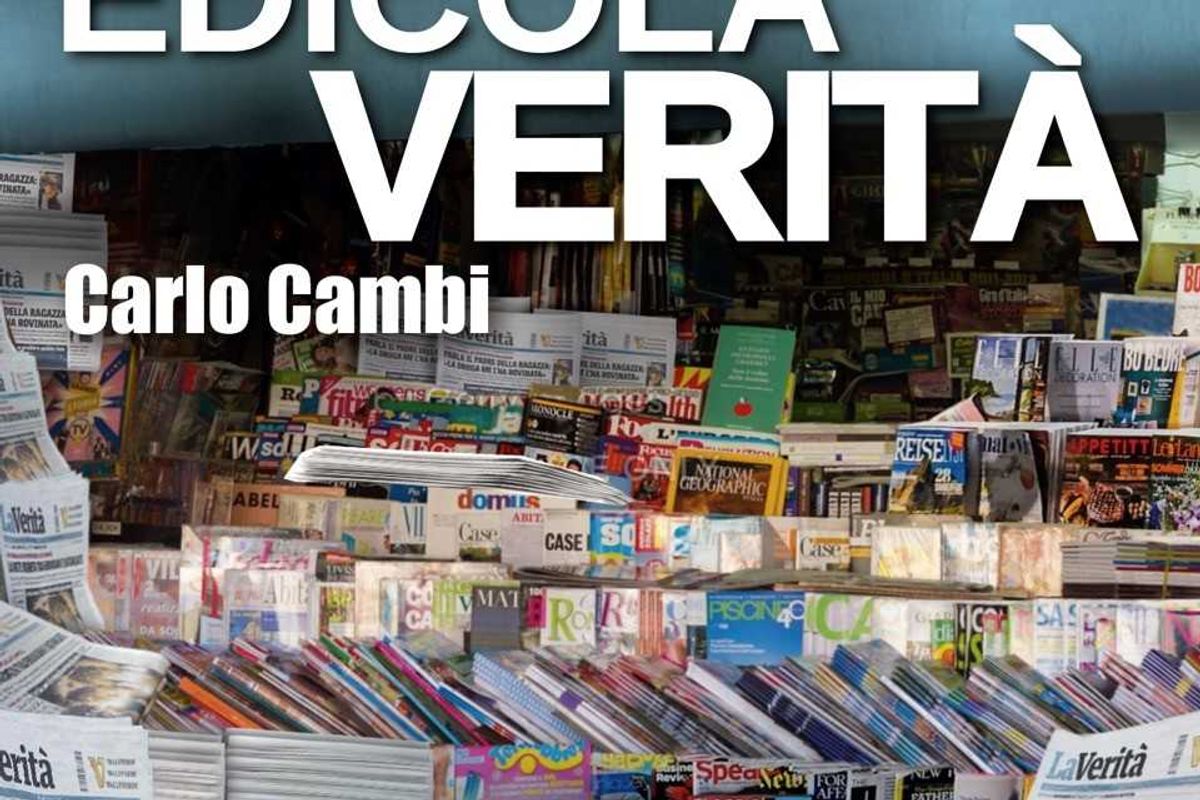Tonno, il maiale pregiato del mare cacciato da tutti e finito in scatola
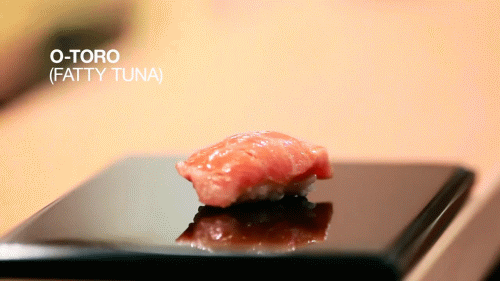
Il tonno è presente, da sempre, nella storia dell'uomo. Lo hanno cacciato fenici, greci, romani, con il Mediterraneo bacino eletto per la sua variante più pregiata: il tonno rosso. Greci i primi a conservarne le carni sotto sale. Tracce letterarie si incontrano con Aristotele, che ne descrive la migrazione o Eschilo, Oppiano di Cilicia ricorda come i più grossi venissero sacrificati a Nettuno. Più concreto Aristofane racconta che, in Sicilia, delle vedette si appostavano sui rilievi costieri più alti per segnalarne l'arrivo.
Furono i romani i primi ad organizzare le tonnare, termine con il quale si intende il sistema di pesca, ma anche quello dei luoghi in cui avvenivano lavorazione e conservazione, pur se lo sviluppo della tecnica lo si deve agli arabi. Testimone Abad al Furat che, nel 827, descrisse le prime tonnare di Mazara e Favignana. Mentre prima il tonno era pescato al largo e poi portato nelle insenature costiere per la relativa cattura e la successiva lavorazione a terra, gli arabi, con lo sviluppo delle tonnare, un insieme di reti a camere successive di cattura ancorate in profondità, consentirono di ottimizzare il pescato e la continuità di raccolto. Un protocollo di pesca che si concludeva con la mattanza, il progressivo portare a galla i tonni che, nel frattempo, erano stati imprigionati in profondità.
Un rito ben descritto da Al.Idri, nel XII secolo, dove viene raccontato come queste procedure venissero accompagnate con i canti dei pescatori che, con un rispetto d'altri tempi, conducevano i tonni al sacrificio finale, quasi scusandosi per questa reciproca lotta di sopravvivenza. Altra rivoluzione con i normanni e Ruggero II; affidamento delle tonnare a feudatari locali e sviluppo delle saline quali materia prima per la conservazione del prodotto. L'olio arrivò con gli spagnoli nel XV secolo, epoca del massimo sviluppo. Nel frattempo le tonnare si erano espanse lungo il Mediterraneo, anche se i tonnaroti, cioè i pescatori siciliani, in particolare quelli di Trapani, facevano scuola ed erano ricercati ogni dove. Un esercito con le sue gerarchie, governato dal Rais, il capo, un termine, come tanti, derivante dall'origine araba. Ogni tonnara poteva coinvolgere sino a 300 persone tra pescatori e tutto il resto che stava a terra, nei cosiddetti marfaraggi, deposito di materiali, ricovero di barche, reti, locali per la lavorazione e trasporto del tonno. Tale era l'impatto nell'economia del tempo che la Corona di Spagna, dopo la disastrosa guerra delle Fiandre, dovette ricorrere a dei prestiti e fu così che il genovese Camillo Pallavicino chiese in garanzia le isole Egadi, al largo di Trapani, con relative tonnare e diritto di pesca.
Le cose iniziarono a cambiare nell'Ottocento. Nicolas Appert, francese, scoprì un metodo per conservare i cibi in contenitori di vetro. L'inglese Bryan Donkin mise a punto la sterilizzazione delle scatole metalliche. Fu l'inizio di una rivoluzione. Il mercato del tonno si aprì a nuove strade modificando anche le tecniche di pesca. Se gli arabi, con il sistema di reti delle tonnare fisse, avevano sostituito la pesca a sciabica dei romani, ovvero il trascinamento dei tonni fino alla costa per poi catturarli, ora si è globalizzata la pesca con le tonnare volanti, in alto mare, dove i branchi vengono intercettati al largo con grave nocumento delle loro fasi più delicate di crescita, a partire dalla riproduzione. Le tonnare tradizionali entrarono in crisi sino a chiudere e a niente sarebbero servite invocazioni come quando, in carestia di pesca, fu chiesta la benedizione delle acque, con papa Clemente V nel 1706. L'ultima mattanza, a Favignana, la capitale delle tonnare, avvenne nel 2007. Favignana è il simbolo di questa epoca. Fondata dagli arabi, ebbe il suo massimo splendore nell'Ottocento con i Florio, tanto da arrivare ad occupare, con l'indotto, sino a 1.000 persone. Dopo un lungo abbandono, è stata restaurata e riaperta al pubblico nel 2010. Patrimonio dell'Unesco, al suo interno si possono rivivere storie diverse. Il rito della mattanza governata dal rais, il generale delle acque, con la sua flotta di tonnaroti cui impartiva ordini secchi e precisi mentre questi intonavano «aja mola, aja mola» (o mio signore, o mio signore), un canto propiziatorio ritmato in modo incalzante così da aiutare il sincronismo dei pescatori nell' issare a bordo il tonno sulle barche. I rais sono figure che hanno lasciato il segno. A Favignana una lapide ricorda Antonio Casubolo, sotto la cui guida i tonnaroti «mattarono», in una sola stagione, 10.159 tonni. Jachino Cataldo fu il rais per antonomasia. «Un uomo con la salsedine nel sangue e il cuore che ha battuto sino alla fine al ritmo delle onde». Uno dei pochi ad essere riconosciuto tra i tesori umani viventi dall'Unesco.
Al giorno d'oggi il tonno vale circa 42 miliardi di euro all'anno. In Giappone le migliori pezzature di tonno rosso spuntano alle aste prezzi da capogiro, anche se il normale tonno che si trova ai banchi di vendita è il più modesto pinne gialle. Piatto simbolo del tonno dagli occhi a mandorla è il tataky, cotto alla piastra e rivestito di sesamo. Si dice inventato da un samurai, Sakamoto Ryoma, dopo aver visto degli europei arrostire il pesce alla griglia. Da noi il tonno lo si può trovare in diverse preparazioni. In Piemonte un classico è il vitello tonnato, un mix di girello, frollato e poi ricoperto con una salsa a base di tonno e aromi. Il tonno in scatola presenta una versatilità domestica che ben si presta alla cucina veloce dei tempi moderni: dalla pasta alle insalate, ma è il sapiente utilizzo delle diverse componenti che permette di raggiungere vertici del gusto che meritano la scoperta. Non a caso veniva chiamato maiale del mare, di cui non si buttava via niente.
Un tempo veniva diviso in 32 parti. Componente fondamentale del garum, per i romani. Con le uova, essiccate sotto sale, si prepara la bottarga, una sorta di caviale del Mediterraneo, mentre con le gonadi maschili si ha il lattume, servito in fette sottili. Nel 1641 Luigi XIII giunse in un monastero di Marsiglia a implorare la clemenza divina per avere un erede. Poi visitò la vicina tonnara e lì, il locale Rais, di origine trapanese, lo spinse a mangiare le gonadi di tonno per darsi forza. Il caso volle che, nove mesi dopo, arrivò l'erede, il futuro Luigi XIV, il Re Sole. Moltissime altre sono le prelibatezze del tonno regale, come il tarantello essiccato, o prosciutto di mare, di cui andava ghiotto Carlo V. A Favignana una goduria era la ficazza, o sasizzella, salame di tonno conciato con gli ultimi residui delle carni attaccate alle lische, mentre in Giappone oggetto di culto è la pupilla, dal sapore simile ad un uovo bollito. Per saperne di più imperdibile il Girotonno, a Carloforte, in Sardegna dove viene proposto in mille modi. Se volete papparvi le lasagne del rais, il piatto premio dopo le fatiche della mattanza, oltre al tonno, godetevela con pomdodoro, uvetta e pinoli. E come non citare il tonno eretico, quello che sembra ma non è. Ci pensarono i frati di Avigliana, in Piemonte, inventandosi il tonno di coniglio. Per aggirare i divieti quaresimali ne frollavano le carni a lungo sott'olio sino ad assumere le sembianze ... di un tonno, appunto, anche se il tonno eretico più famoso è quello del Chianti raccontato da quel toscanaccio di Dario Cecchini.