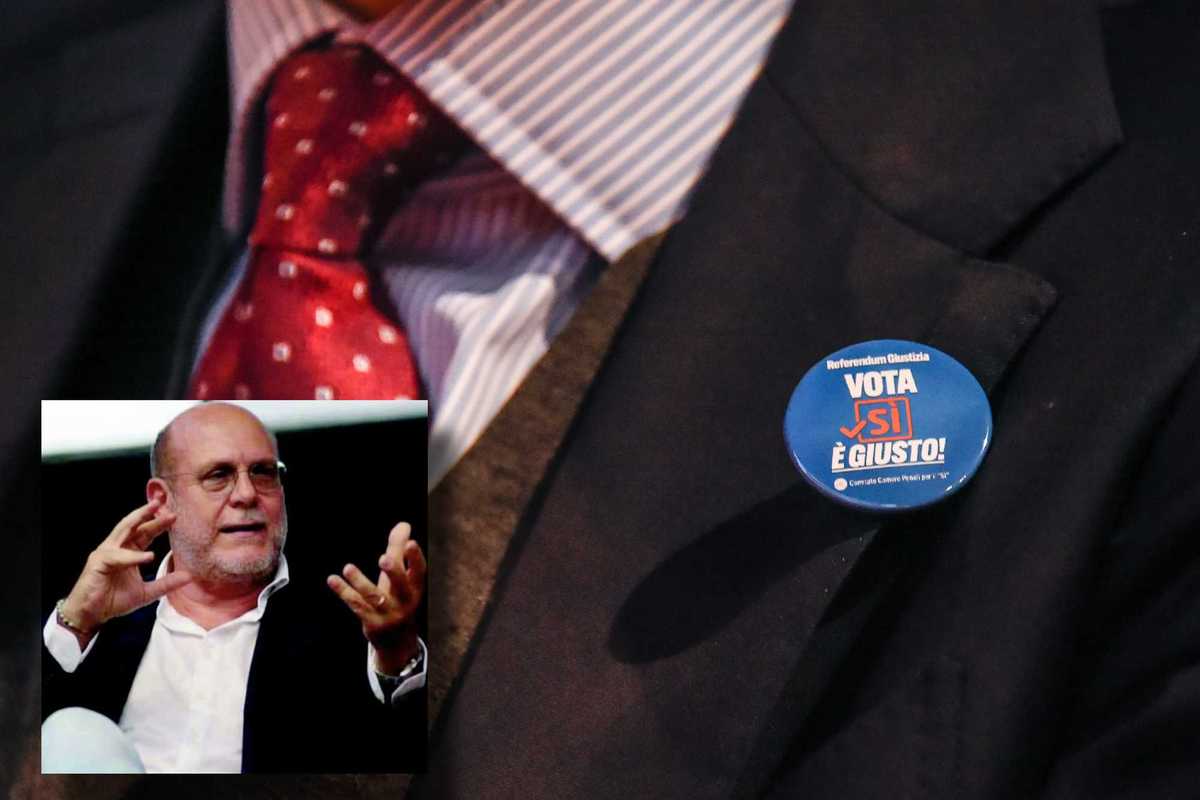Nei media e nei dibattiti, il tema della «fine del lavoro» o della sua centralità, è diventato tutto a un tratto prioritario. Ovunque si sta sperimentando o pensando, in modo più o meno consapevole, la riduzione delle ore di lavoro e l'impatto su stipendi e potere di acquisto. Con l'implicita promessa di voler realizzare per tutti meno lavoro, miglior lavoro, migliore qualità della vita. Un nuovo Eden sulla terra, post ultimo Reset-Covid. All'insegna del transumanesimo.
La spiegazione logica di questa promessa sta nell'esigenza di dover essere competitivi nel mondo globale, incluso necessariamente il costo e l'efficienza del lavoro. Ma per convincere ad accettarne le conseguenze imprevedibili, si è adottata la subdola spiegazione che finalmente l'uomo oggi, grazie a scienza e tecnologia, ha la opportunità di scrollarsi di dosso la sofferenza e la fatica del lavoro: non dovrà più nascere, istruirsi e formarsi professionalmente per lavorare, come insegnerebbe la cultura della Genesi, che ci ricorda che l'uomo è nato «ut operaretur». Si afferma, come corollario, che l'uomo è finalmente «maturato» ed è divenuto «adulto», si rifiuta di esser la creatura descritta nella Genesi e ha deciso che a lavorare deve essere una sua creatura, chiamiamola per semplificare, robot. Formulando però anche previsioni utopistiche, con riflessi morali enormi, piuttosto sottovalutati, celati sotto l'espressione ambigua transumanesimo.
Transumanesimo, accelerato dalle circostanze che spiegano il Reset post Covid in corso, significa che scienza e tecnologia aumentano le capacità cognitive e psicofisiche dell'uomo, che può pertanto migliorare l'intera umanità, realizzando anche un miglior «bene comune», naturalmente guidando lui direttamente il processo evolutivo. Si noterà la fusione di scientismo positivista e di morale cattolica in queste considerazioni. Infatti furono predette più di 70 anni fa da un famoso teologo, paleontologo ed evoluzionista gesuita, Teilhard de Chardin, nonché confermate più scientificamente dall'altrettanto famoso genetista darwiniano Julian Huxley, primo responsabile dell'Unesco e fondatore del Wwf.
Forzare la fusione di opportunità scientifiche con morale e antropologia, per risolvere soprattutto il problema del lavoro umano, può produrre conflitti difficilmente superabili e conseguenze che possono esser nefaste. Per esempio il problema-conflitto insuperabile principale oggi è quello che ha proprio creato la crisi economica e il problema della competitività del lavoro, cioè il crollo voluto della natalità in Occidente e il convincimento che il numero di esseri umani sia in eccesso. Questo problema è riconosciuto esser in conflitto con la crescita economica, ma non si vuole risolvere per evitare altri conflitti più o meno veri o artificiali, quali gli squilibri ambientali. Un approccio logico-scientifico avrebbe imposto di studiare le cause di questi problemi prima di decidere come porvi rimedio. Invece si è deciso di agire solo sugli effetti anziché sulle cause, pretendendo di conciliare indispensabile crescita economica, nascite e ambiente, con artifici utopistici, primo fra tutti quello sul riconcepimento del lavoro umano. E si è deciso di farlo chiedendo aiuto a scienza e tecnologia e cercando persino di avere un supporto di carattere morale. Ma natalità, creazione di ricchezza e distribuzione, ambiente, son fenomeni «naturalmente» collegati fra loro e completamente contraddetti dalle prospettive del lavoro umano che deve esser sostituito tecnologicamente dal robot e dal digitale. I nostri profeti spiegano che il lavoro umano è destinato a scomparire sostituito dalle tecnologie, da cui non si può peraltro prescindere essendo elementi chiave per competere a livello globale. Ma la scomparsa del lavoro umano pone invariabilmente il problema di come si creerà e distribuirà la ricchezza, poiché non basta produrre beni, bisogna anche venderli e se non si lavora e si produce reddito, non si capisce dove possa nascere il potere di acquisto. Forse dal reddito di cittadinanza che diverrà «reddito di esistenza»?
Nel contempo anche la legittimità della proprietà privata è stata curiosamente messa in discussione, proprio dalla autorità morale. Ma la proprietà privata è proprio frutto del lavoro umano che crea ricchezza. Oggi taluni moralisti vorrebbero che fosse il capitale redistribuito ad essere il Bene Comune trasformato in «Bene in Comune», rendendolo improduttivo e perciò creatore di povertà anziché ricchezza. Al contrario la proprietà privata non solo è legittima, ma è proprio frutto del lavoro umano ed è necessaria proprio per creare il capitale, cioè la risorsa indispensabile per realizzare il Bene Comune vero. Ma la scomparsa del lavoro prevista o pretesa oltre a cancellare una intera civiltà, anche fondata sulla proprietà privata, pone un problema ancor più curioso e inquietante. Cancellando la «condanna» di uomo nato «ut operaretur» si nega il senso della Creazione e si conferma pertanto che l'uomo non è altro che un accidente della evoluzione, risolvibile trasformando la sua operosità produttiva (ma dannosa per l'ambiente ) in operosità contemplativa di protezione dell'ambiente.
E riflettendo su questo intuito è possibile intendere che la scomparsa del lavoro più che una prospettiva potrebbe proprio essere una scelta per ridimensionare il ruolo della creatura, del Creatore e del senso stesso della Creazione. Chi dovrebbe esser responsabile della morale, dovrebbe fare attenzione a questo rischio, se lo considera un rischio e non invece una fase scontata di processo evolutivo... San Giovanni Paolo II, in Sollecitudo Rei Socialis, spiegò che l'uomo di questo secolo ha investito molto in scienza e tecnologia, ma poco in sapienza, essendo perciò immaturo per saper gestire strumenti così sofisticati e creando le condizioni per cui questi possano sfuggirgli di mano. Benedetto XVI in Caritas in Veritate spiegò i rischi degli strumenti economici e tecnologici che prendono autonomia morale. Oggi chi e come se ne occupa?