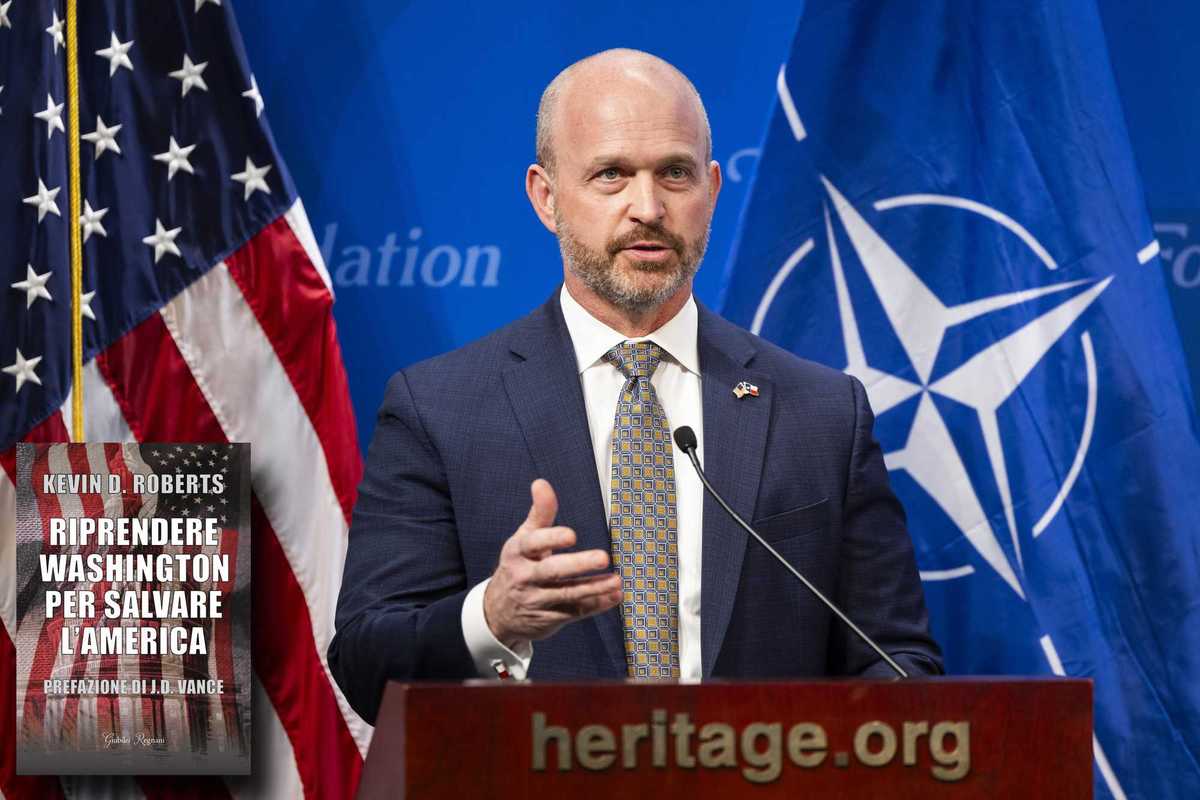Tante tasse ma nessuna solidarietà. Il Recovery fund è la copia del Mes

I dubbi sul Recovery and resilience fund (Rrrf), condivisi unicamente dalla Verità e dalla stampa internazionale, aumentano man mano che se ne apprendono i dettagli. Quanto denaro, in quali tempi, con quali garanzie da parte degli Stati membri, quanto dovremo pagare per ricevere quei fondi, per non parlare delle condizioni relative al loro impiego e al rispetto di vincoli assai stringenti di politica economica e della clamorosa rivelazione annunciata con grande imbarazzo dal ministro Roberto Gualtieri alla commissione Bilancio della Camera: i prestiti concessi dalla Ue attraverso il Rrf e il Sure (utile a sostenere la cassa integrazione) saranno privilegiati rispetto alla rimanente parte del debito pubblico. Al pari del Mes per intendersi. Cosa di cui non si è trovato incredibilmente alcuna traccia nelle 67 pagine di conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo.
Con lo scoppio della pandemia l'Unione europea ha dimostrato tutta la sua intrinseca fragilità, impiegando 150 giorni a concordare un piano che si svilupperà fra mille cavilli in sei anni e a partire - se va bene - dal 2021. Stati Uniti, Regno Unito e Giappone - al pari di qualsiasi altro Stato monetariamente sovrano - hanno potuto mettere in campo subito ciò che serve per risollevare l'economia piegata e piagata dal lockdown: i soldi. Il pinguino dentro la savana insomma che però ora potrebbe - anzi vorrebbe - trasformarsi in leone. Questo sembra l'Ue in procinto di affacciarsi sul mercato obbligazionario per finanziare il suo NextGenEU da 750 miliardi di euro da distribuire sotto forma di sussidi e prestiti ai 27 Paesi dell'Unione e sui cui criteri di allocazione dei fondi girano per ora tante congetture, ma nessun dato certo. Oltre al programma Sure di altri 100 miliardi.
Reazioni entusiastiche quasi orgasmiche da parte degli europeisti: un nuovo benchmark; l'euro diventerà finalmente una valuta di riserva; un vero «safe asset» europeo; il primo vero tentativo dell'eurozona di mutualizzare il debito; e il suo più grande passo verso l'integrazione fiscale.
Ma può una montagna di debito rendere uno sgorbio come l'Ue simile agli Stati Uniti o più semplicemente lasciare lo sgorbio così com'è, ma con 850 miliardi di debiti in più sul groppone? «La seconda che hai detto», avrebbe esclamato Corrado Guzzanti.
A negoziati ancora in corso, vi abbiamo illustrato i dubbi che sussistono sull'entità delle cifre sbandierate, da ultimo confermati anche dal Financial Times, secondo cui «la Commissione non ha pubblicato i dettagli sulla ripartizione dei fondi, anche perché un terzo dei fondi dipenderanno dalla crescita del 2021 e 2022. Le cifre che circolano sono frutto di stime dei governi».
Altri dubbi sussistono sui tempi di erogazione: con 850 miliardi di titoli emessi, la Commissione sarebbe superata solo da Germania, Francia e Italia. Il mercato, pur esprimendo un notevole interesse per questi bond, ha comunque i suoi tempi di assorbimento e le emissioni saranno scaglionate. Fonti del quotidiano londinese riferiscono che dal 2021 al 2024 saranno piazzati poco meno di 200 miliardi all'anno per finanziare il NextGenEU. Con ciò confermando che nel 2020 anche il fondo Sure da 100 miliardi avrà poco da erogare. La Commissione concentrerà il grosso dei pagamenti nel triennio 2022-2024. Non si dimentichi, infatti, la differenza tra impegni di spesa e pagamenti. Questi ultimi arrivano sempre molto dopo rispetto ai primi. E anche la capo economista di Unicredit, Loredana Federico, conferma che l'impatto finanziario più rilevante si avrà nel 2022 e 2023. I dubbi su chi e come contribuirà al rimborso di queste obbligazioni poi non mancano: fino a oggi il bilancio dell'Ue presentava un conto economico ben visibile e uno stato patrimoniale quasi assente. Un bilancio strutturalmente a somma zero. I soldi arrivano dalla Ue perché qualcuno ce li mette: da una parte gli Stati - attraverso i trasferimenti - e dall'altra i consumatori pagando l'Iva - una cui parte del gettito alimenta le cosiddette «risorse proprie» di Bruxelles. Che poi sarebbero vostre. Niente soldi in arrivo dagli Stati o dai consumatori? Niente soldi in uscita. Debiti praticamente zero. Escludendo una piccola marginale emissione di circa 50 miliardi di obbligazioni in circolazione utilizzate per i prestiti all'Irlanda e al Portogallo durante la crisi finanziaria del 2008-2009.
Con l'emissione di 750 miliardi di bond a scadenza trentennale, a partire dal 2028 va in onda però tutto un altro film. C'è la fottutissima necessità da parte dell'Ue di riscuotere ogni piccolo cent: dall'Iva sui consumi all'accise su ogni grammo chilo di plastica prodotto. Da ogni trasferimento intergovernativo per alimentare il bilancio Ue, ai balzelli su digitale, emissioni dei mezzi aerei e marittimi, carbone e transazioni finanziarie. E che succede se uno dei 27 Paesi debitori dell'Ue minaccia o attua un default selettivo su quanto dovuto a Bruxelles? Ognuno paga per sé, entro un certo limite. Vincoli di solidarietà zero.
La risposta sta nei punti A9 e A10 delle conclusioni del Consiglio del 21/7 e in due documenti di lavoro della Commissione che abbiamo potuto visionare. Le entrate del bilancio Ue fino al 2058 saranno temporaneamente aumentabili fino a un massimo dello 0,6% del Gni (Reddito nazionale lordo), circa 81 miliardi annui di maggiori entrate proprie. Queste garantiranno agli investitori che le obbligazioni in scadenza fino al 2058 saranno onorate. Quindi più tasse per tutti. Una somma rilevante, considerato che il bilancio annuale Ue è pari a circa 150 miliardi. Questi 81 miliardi sono un tetto massimo per tenere conto degli scenari peggiori: come appunto il mancato rimborso dei prestiti da parte di uno Stato membro o il mancato versamento dei contributi.
Scendendo nei particolari, i 390 miliardi di obbligazioni utili a finanziare i sussidi, dovranno essere rimborsati per un importo non superiore al 7,5% annuo, vale a dire 29 miliardi. Altri 7 miliardi ci vorranno per gli interessi. Si aggiungono altri 25 miliardi di rimborsi dei prestiti che ora scopriamo essere privilegiati. Se non vi siete persi, siamo a 61 miliardi, cui si aggiunge un altro cuscinetto prudenziale: lo 0,1% del Pil (14 miliardi) per fronteggiare cali imprevisti di reddito.
Ma allora perché l'Ue può arrivare a incassare 81 miliardi? È il diktat delle agenzie di rating. Gli Stati con rating Aaa e Aa pesano infatti per il 42% del Pil europeo, e gli investitori esigono che almeno il 42% delle entrate future del bilancio Ue provenga da loro. A fronte di rimborsi massimi di 29 miliardi annui di obbligazioni emesse per i sussidi, la Ue si è premunita di risorse proprie aggiuntive per più del doppio; quasi il triplo. Non si sa mai. Con un ulteriore paracadute. Infatti, il punto A10 delle conclusioni del Consiglio, autorizza la Commissione a richiedere somme addizionali anche solo ad alcuni Stati membri a titolo di anticipo, sempre nel limite del 0,6% del rispettivo reddito. Questo nel caso la Commissione non abbia possibilità di indebitarsi a breve e si trovi, evento ritenuto piuttosto improbabile, senza gli incassi di contributi e tasse necessari per rimborsare le obbligazioni.
Nulla è eterno, nemmeno la Ue e, come ha dichiarato Moritz Kraemer (già a Standard & Poor's): «anche se oggi appare improbabile lo scioglimento della Ue, fino al 2058 molte cose possono andare storte». E senza dubbio, nella foga di inchiodare gli Stati nazionali, l'Ue si stava esponendo a potenziali ricadute negative sul proprio merito creditizio qualora uno o più Stati avessero minacciato default selettivi su quanto a lei dovuto. Un'arma di difesa che la Grecia, ad esempio, non aveva nei momenti di maggior pressione subiti nel 2015. Di qui la clamorosa rivelazione di Gualtieri. I prestiti del Rrf avranno lo status di credito privilegiato al pari di quelli del Mes e in caso di default verranno pagati per primi. Ma su questa rilevantissima attribuzione dovrà esserci una delibera all'unanimità in seno al consiglio Ue nell'ambito dell'approvazione del bilancio 2021-2027 in forza dell'articolo 48(6) del Trattato dell'Ue, secondo il giurista Barra Caracciolo. Infatti il Mes trova sancito il suo status di creditore privilegiato proprio nel suo Trattato e, non a caso, un meccanismo di assistenza finanziaria come l'Efsm, che ha erogato prestiti a Irlanda e Portogallo tra 2011 e 2014, non possiede questo status. Quando ci sarà da approvarlo, i giornaloni esultanti all'indomani del 21 luglio, si renderanno conto che avremo prestiti alle stesse condizioni che il Fmi concede ai Paesi in via di sviluppo.
E se qualcuno non rimborsasse il prestito, privilegio o no, la Ue è blindata perché comunque toccherebbe al resto del condominio, ovviamente sempre in proporzione alle quote. Nessuna garanzia solidale. Per i prossimi 30 anni, è come se l'Italia, assieme agli altri, avesse già firmato un assegno alla Commissione fino al 0,6% del proprio Reddito nazionale lordo, cioè 11 miliardi all'anno, monetizzabile a vista. Per la Ue si tratterà solo di presentarlo all'incasso.