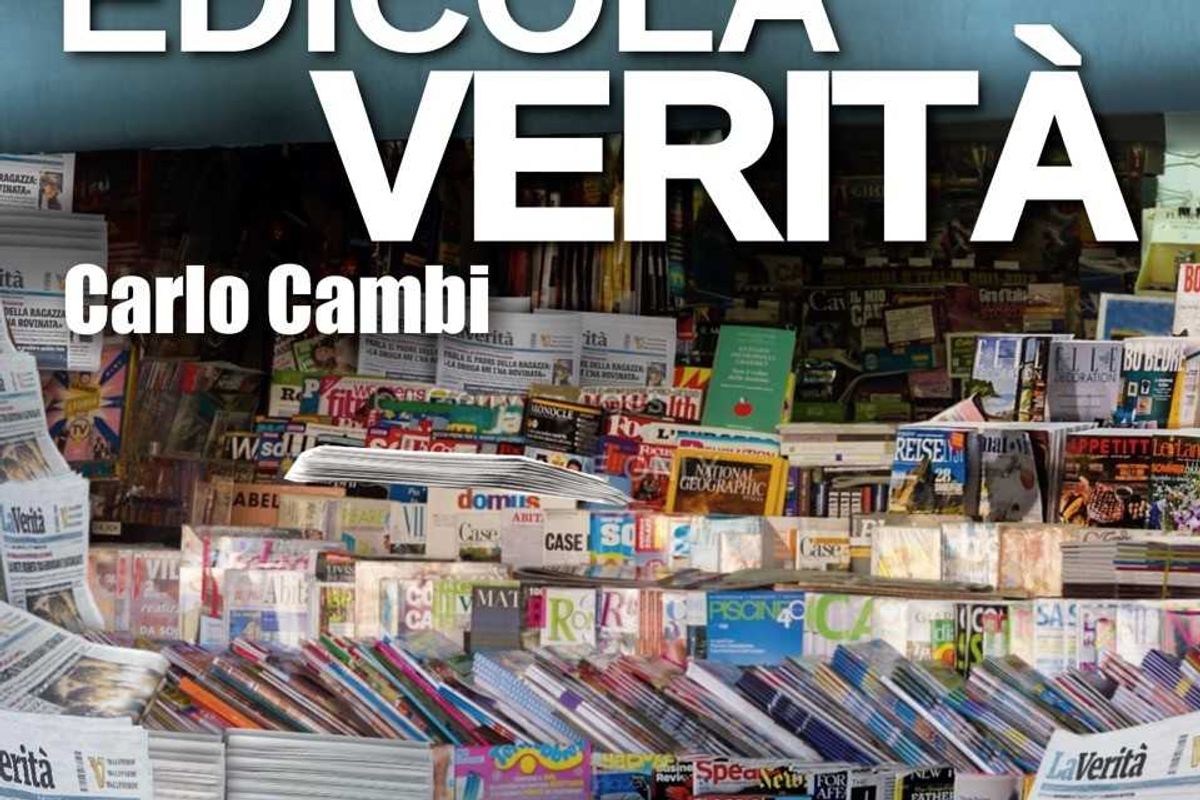Alle elezioni presidenziali francesi del 2002, Jean Marie Le Pen - padre di Marine - andò al ballottaggio dove poi perse fragorosamente con Jacques Chirac, in un gioco politico tipico del doppio turno francese. Esattamente vent’anni fa, però, il dato più rilevante non fu la conferma del presidente uscente ma l’irrompere stesso del Front National come forza in grado, per la prima volta nella storia della République, di andare al ballottaggio staccando i socialisti allora capitanati da Lionel Jospin (16,86% contro 16,18%). Nel 2007 la situazione, anche dal punto di vista dell’equilibrio con le famiglie politiche europee, fu «normalizzata», nel senso che sinistra (Ségolène Royal) e Ump, la sigla gollista dell’astro nascente Nicolas Sarkozy, arrivarono al secondo turno totalizzando, insieme, circa il 57% dei consensi dei votanti (Le Pen, quarto, precipitò al 10% e spicci).
Da qui inizia un fenomeno politico talmente macroscopico da finire paradossalmente occultato nelle analisi sui flussi elettorali francesi ed europei: la progressiva perdita di peso dei partiti «di sistema», riconducibili alle famiglie popolari e socialiste. Insomma conservatori e centrosinistra, nelle varie e articolate formazioni e sigle specifiche nazionali. Lo stesso fenomeno di erosione, che molti osservatori pensavano fosse giunto al culmine col biennio 2016-2018 (Brexit, Trump, governo gialloverde), tocca ora un picco inedito a Parigi. Se infatti già nel 2012 François Hollande e Sarko avevano raggiunto più o meno la stessa quota al primo turno (56% sommando Ump e socialisti), cinque anni dopo irruppero due fattori destinati a sconvolgere il quadro. Il primo fu ovviamente Emmanuel Macron (24% con la neonata En Marche), il secondo il 21,3% della Le Pen permise al Fn di accedere al secondo turno. Il combinato disposto portò al 26% circa la somma di gollisti e socialisti, col progressista Benoît Hamon che prese meno di un terzo dei voti di Jean Luc Mélenchon (6 e rotti % contro poco meno del 20) e il repubblicano François Fillon fermo al 20%, dietro alla figlia dell’anziano leader storico (21,3%). E siamo all’oggi, con una riedizione del ballottaggio 2017 che porta con sé un massacro con pochissimi precedenti nella storia politica recente: Valérie Pécresse dei Repubblicani sotto il 5% e soprattutto Anne Hidalgo, rieletta sindaco di Parigi due anni fa, che racimola un umiliante 1,75% per il suo Partito socialista. Il totale di «popolari» e socialisti si attesta così al 6,5%: le due famiglie hanno visto crollare la somma dei loro voti dal 56 al 6,5%, una catastrofe politica che accentua in modo marcato il trend in atto in mezza Europa. È come se Pd e Forza Italia, fatti tutti i debiti distinguo, non arrivassero al 7% sommati.
In effetti, come detto, l’andazzo ha tratti comuni in molti grandi Paesi: in Germania, lo Stato forse meno soggetto a scossoni simili, dal 2012 a oggi la somma di socialisti (Spd) e popolari (Cdu e Csu) è passata dal 67,2% al 53,4% (2017) fino al 49,8% dello scorso settembre. Con il nuovo governo, la Cdu è finita fuori dalla maggioranza dopo l’era merkeliana. Il baricentro del Ppe in Europa è all’opposizione in patria.
In Spagna Popolari e Psoe sono scesi dall’83,8% del 2008 al 53,1% (media tra le due tornate ravvicinate del 2015 e 2016) e poi al 45,5% delle politiche 2019. E anche in Italia le ultime elezioni del 2018 Fi e Pd hanno raggiunto il 32,8%. Oggi sarebbero probabilmente a livelli più bassi. Ai tempi di Pdl e Pd veltroniano la loro somma arrivò al 70,5%.
Si potrebbero fare molti altri esempi di un andamento non dissimile, in cui è difficile non cogliere un tratto comune. Ma al di là delle percentuali e delle sigle, dei nuovi partiti e delle dinamiche specifiche di ogni Paese, il voto francese acuisce la necessità di fronteggiare due questioni, almeno come tentativo di analisi e riflessione.
La prima è: perché avviene questa erosione di consenso? Sotto l’inconsistente marchio del «populismo» si è tentata una squalifica ex ante di molta offerta politica nata da un rigetto discutibile ma legittimo. Le tradizionali «famiglie», quell’articolazione della rappresentanza che dovrebbe tradurre ideali, interessi ed equilibri in azione legislativa e di governo, ha un problema di tenuta interna o è soggetta all’attacco di forze oscure (fascismi di ritorno, condizionamenti esteri, disinformazione distorsiva)? In fondo il bivio è ancora questo, e permette di superare l’improponibile divisione tra «sistema» e «antisistema» (chi fa un partito e prende il 20% è parte del sistema, anche se parla sguaiato): o i paradigmi dei partiti tradizionali sono inadeguati secondo l’unico criterio possibile in democrazia, cioè lo scrutinio degli elettori, oppure in ultima analisi sbagliano gli elettori che vanno convinti a qualunque costo, minacciando scenari da fine di mondo a ogni tornata (un esempio è la «vittoria di Putin» in caso di affermazione del Fn).
La seconda faccenda è a livello di politica europea: questa erosione di popolari e socialisti ha prima disarticolato l’alternanza a livello di Parlamento Ue e Commissione, poi costretto alla coabitazione forzata le due coalizioni, quindi a improbabili alleanze come quella che ha fatto del M5s a Strasburgo un essenziale portatore di voti per blindare Ursula von der Leyen e la sua squadra nel 2019. È una grave responsabilità dei partiti cosiddetti alternativi non aver saputo creare un’articolazione europea utile a tradurre questi equilibri in modo efficace. Fingere che gli equilibri siano invariati, però, non è un’opzione rassicurante per nessuno.