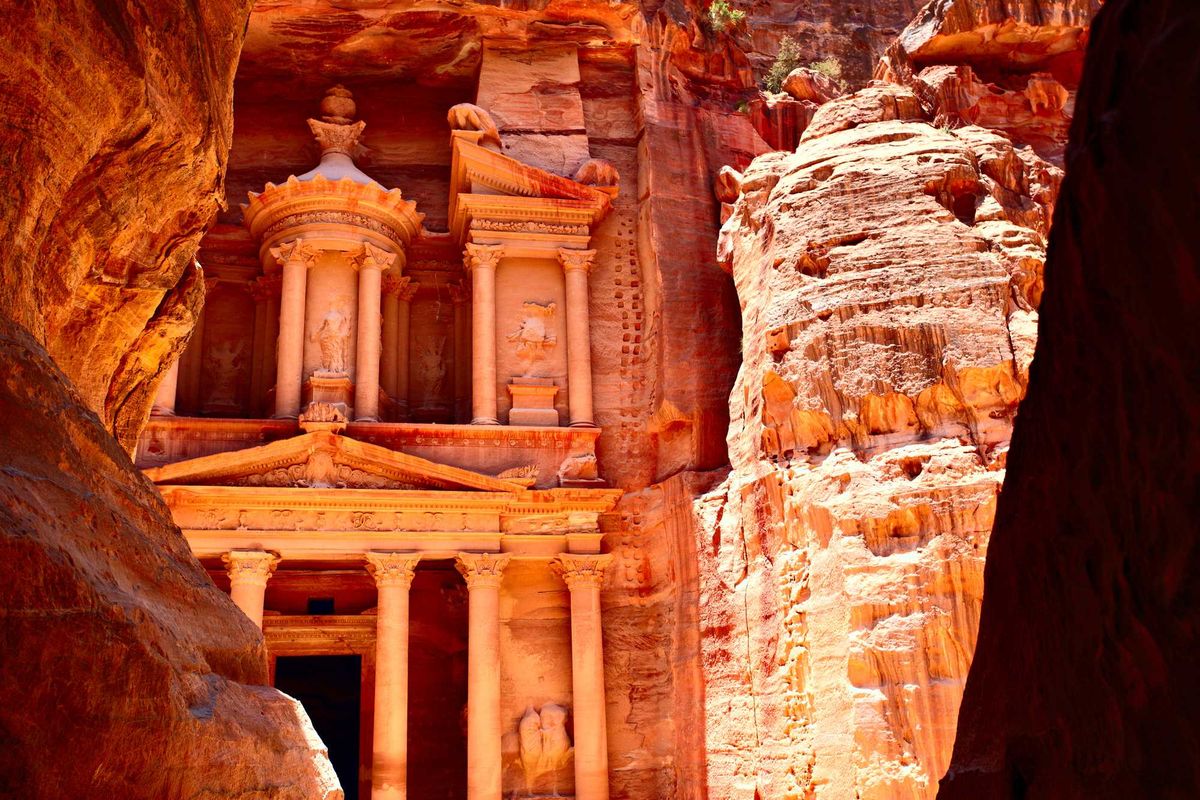È fresco fresco il passaggio dall’ora legale all’ora solare. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, per la precisione alle 3, abbiamo spostato l’ora, arretrandola alle 2. Si tratta del gesto speculare a quello che abbiamo compiuto a marzo scorso, sei mesi addietro, quando abbiamo spostato le lancette in avanti di un’ora, alle 2 della notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo le abbiamo spostate alle 3. A marzo abbiamo dormito un’ora in meno, a ottobre dormiamo un’ora in più. Se a marzo entriamo nell’ora legale, a ottobre ne usciamo e rientriamo nell’ora solare. A marzo, perdiamo un’ora di sonno e ne acquistiamo una di luce. A ottobre, accade il contrario: perdiamo un’ora di luce e ne acquistiamo una di sonno.
O meglio, azzeriamo il nostro debito di sonno di un’ora posto in essere all’inizio dell’ora legale a marzo, recuperando quell’ora in ottobre. Debito che riavremo tra le mani a marzo 2024 e poi azzereremo, ancora, a ottobre 2024: l’ultima domenica di marzo e l’ultima domenica di ottobre sono le date di questo valzer delle lancette. Va avanti così da molti decenni. Il nostro orario normale è quello solare. La cosiddetta convenzione dell’ora legale compare nella nostra nazione durante la prima guerra mondiale. Siamo nel 1916 e per la prima volta fa capolino l’idea che se durante il periodo primaverile-estivo già caratterizzato da maggiore luminosità si estende forzatamente quest’ultima di un’ora ulteriore, si risparmia sul costo dell’illuminazione serale/notturna. L’ora legale è stata introdotta proprio per questo motivo e per questo stesso motivo, dopo alcune sospensioni, è stata adottata definitivamente dal nostro Stivale. Spiega Wikipedia: «Già nel 1784, Benjamin Franklin, l’inventore del parafulmine, pubblicò un’idea sul quotidiano francese Journal de Paris. In queste riflessioni, Franklin si poneva l’obiettivo di risparmiare sulla spesa in candele ma, per la stravaganza delle proposte (come mettere un cannone in ogni via, che sparasse un colpo per svegliare gli abitanti), non trovarono seguito. Sostanzialmente Franklin non propose di spostare il tempo, bensì di obbligare, esercitando varie forme di pressione (tassazione delle persiane, razionamento candele, divieto di circolazione notturna, ed una sveglia rumorosa all’alba), a forzare la popolazione ad alzarsi ad orari più mattinieri.
La proposta di spingere la popolazione ad alzarsi prima modificando il riferimento orario, origina da un lavoro dell’entomologo neozelandese George Vernon Hudson. Nel 1895, egli presentò un documento alla Società flosofica di Wellington, proponendo uno spostamento in avanti degli orologi di due ore. L’idea venne ripresa pochi anni dopo, dal costruttore britannico William Willett, e questa volta trovò terreno fertile nel quadro delle esigenze economiche provocate dalla prima guerra mondiale: nel 1916 la Camera dei comuni diede il via libera al Bitish summer time, che implicava lo spostamento delle lancette un’ora in avanti durante l’estate. Molti paesi imitarono il Regno Unito in quanto in tempo di guerra il risparmio energetico era una priorità». In Italia, il semestre di ora legale viene acquisito stabilmente a partire dal 1966 e lo abbiamo ancora in uso. Non solo noi: sono molte altre le nazioni che vi ricorrono, non solo in Europa. In tutte le nazioni dell’Unione europea che l’hanno, il semestre di ora legale ha inizio l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre.
Ma anche il Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, Svizzera, Norvegia e Città del Vaticano, che Unione Europea non sono, seguono le stesse regole. E si seguono anche molto oltre l’Unione europea e l’Europa, per esempio in paesi come il Canada e gli Usa. Ci sono poi paesi nei quali la differenza tra ore di luce e ore di buio non è così importante, non hanno bisogno dell’ora legale e non la usano, sono per lo più i paesi dal clima tropicale, con giornate già molto lunghe tutto l’anno.
L’Italia appartiene all’emisfero boreale, e quando da noi a settembre inizia l’autunno, nell’emisfero australe inizia la primavera (idem a marzo, nell’emisfero boreale inizia la primavera, nell’emisfero australe l’autunno). I momenti di maggiore e minore durata della giornata ossia della luce sono quelli dei solstizi. Il solstizio d’estate segna il giorno con più ore di luce dell’anno, il solstizio di inverno quello con meno ore di luce e sono i momenti in cui il Sole è alla massima distanza dai Poli. Sebbene Santa Lucia, il 13 dicembre, sia considerato il giorno più corto dell’anno con tanto di proverbio «Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia», in realtà il più breve è il solstizio d’inverno. Se arriviamo all’equinozio di primavera da mesi nei quali le ore di buio sono state maggiori di quelle di luce, l’equinozio di autunno ci vede proseguire lungo la perdita di luce cominciata dal giorno dopo il solstizio d’estate con quest’ultima giornata paritaria equinoziale.
Se a inizio settembre 2023 si avevano 13 ore e 9 minuti di luce, a fine settembre abbiamo registrato 11 ore e 49 minuti, che a fine ottobre saranno 10 ore e 25 minuti, a fine novembre 9 ore e 23 minuti, il 22 dicembre 9 ore e 7 minuti che dal giorno dopo inizieranno a crescere: 9 ore e 8 minuti il 23, 9 ore e 10 il 31. In autunno, la mattina il Sole sorge più tardi, la sera tramonta sempre prima, la regola si inverte dal 23 dicembre in poi. La caratteristica principale dell’autunno è rappresentata dalla diminuzione: di temperatura ambientale e di ore di luce. Si tratta di una stagione che costituisce una pausa dopo il fulgore caldissimo dell’estate, come abbiamo visto giusto due settimane fa parlando del cambio di stagione autunnale. Questa naturale contrazione autunnale delle ore di luce durante l’autunno viene poi amplificata dal ripristino dell’ora solare. Molti la vivono come l’imposizione di un orario posticcio e artificiale che getta addosso un quasi brutale cambio di scenario orario, per cui il penultimo sabato di ottobre fa buio alle 18 circa e bùm, dopo una settimana fa buio alle 17 circa.
Anche ai fini di assorbire meglio la cosa dal punto di vista fisico e psicologico, è importante ricordare che non si tratta di un deliberato imposto nuovo orario, ma del ripristino dell’orario precedente. Dal punto di vista amministrativo, infatti, la modifica vera e propria avviene a marzo. A marzo, si applica una convenzione di ora appunto legale, che sposta avanti l’orario di un’ora, come abbiamo visto, allo scopo di sfruttare ulteriormente l’irraggiamento solare estivo che già dona maggiore luminosità. Se questo orario legale è, in un certo senso, artificiale, con la locuzione «ora solare» si intende, invece, l’ora del meridiano del fuso orario di riferimento anche detta «ora civile convenzionale». Ci sono luoghi in cui l’ora legale semestrale viene definita «orario estivo», «ora estiva» o addirittura, in inglese, Dst, daylight saving time, cioè «orario di risparmio della luce diurna». D’altronde, lo abbiamo detto, la convenzione nasce per questo: risparmiare. Luce elettrica, quindi consumo elettrico, quindi denaro. Se le nostre ore di veglia coincidono con quelle in cui il Sole dà un’illuminazione naturale, accendiamo meno lampadine, spendiamo meno. L’ora legale è nata proprio per favorire il risparmio energetico in tempi di crisi e ciò che ci potrebbe sembrare un’imposizione artificiosa, a ben guardare, è una concezione che riporta in auge ciò che l’uomo faceva tradizionalmente prima dell’applicazione convenzionale dell’ora ossia allineare la veglia della sua esistenza alla luce naturale. Gli antichi Romani chiamavano ora prima la prima ora di luce che cominciava col sorgere del sole, sole che naturalmente sorgeva e si palesava prima o dopo in virtù delle stagioni in corso. Prima in primavera ed estate, dopo in autunno e inverno. Di notte si dormiva e di giorno si lavorava, soprattutto la terra, l’elettricità non esisteva (arriva nel diciannovesimo secolo). Oggi ci sembra normale accendere la luce elettrica, ma nella storia dell’uomo questo è un recentissimo privilegio: il fuoco si accende nel 50.000 a.C., nell’8.000 a.C. si registra la lampada a tazza (predecessore della lampada in argilla), nel 700 a.C. la lampada a olio, nel II secolo d.C. assistiamo alla nascita delle candele, nel 1783 arriva la lampada Argand (a olio), nel 1798/1802 l’illuminazione a gas giunge nelle fabbriche inglesi e in quello stesso diciannovesimo secolo si afferma l’illuminazione elettrica, ma generalmente, prima dell’illuminazione elettrica, la popolazione, per lo più di contadini, si svegliava col sorgere del sole: la civiltà agricola non era regolamentata da bioritmi fissi come sarà invece dalla civiltà industrializzata compresa in poi.
Il contadino aveva bioritmi mobili la cui variazione era determinata dall’inizio e dalla fine della naturale luminosità diurna. Esso si alzava col sole, indipendentemente da quando ciò accadeva, e terminava le attività col suo tramontare, tramontare che era mobile anch’esso. L’istituzione dell’ora legale modifica il bioritmo fisso dell’orario in virtù di un elemento che determinava i bioritmi naturali: istituire/sfruttare una maggiore luminosità col semestre di ora legale è, in un certo senso, una riproduzione dell’antico rapporto mobile tra uomo e luminosità naturale.
Può sembrare un paradosso, ma non lo è. Secondo molti adottare l’ora legale tutto l’anno farebbe risparmiare centinaia di milioni di euro annuali che potrebbero perfino aumentare se aumentasse ancora il costo dell’elettricità. Il Parlamento europeo nel 2018 ha approvato l’abolizione dell’obbligo dei paesi membri di alternare ora legale e ora solare e richiesto una decisione autonoma sull’adozione permanente dell’ora solare o dell’ora legale (la cosiddetta «ora legale tutto l’anno") che andava comunicata entro fine 2021. Al momento, nessuno dei paesi ha deciso modifiche, sebbene in alcuni Stati ci siano stati sondaggi volti a capire la preferenza dei cittadini, come in Francia, dove la maggioranza dei francesi si è espressa per l’ora legale tutto l’anno. Il nord Europa tendenzialmente non ha bisogno dell’ora legale, essendo l’esposizione solare estiva di quelle zone già lunghissima. L’Italia non ha ancora deciso nulla e ci sono già posizioni, perfino appelli, a favore dell’ora legale tutto l’anno.