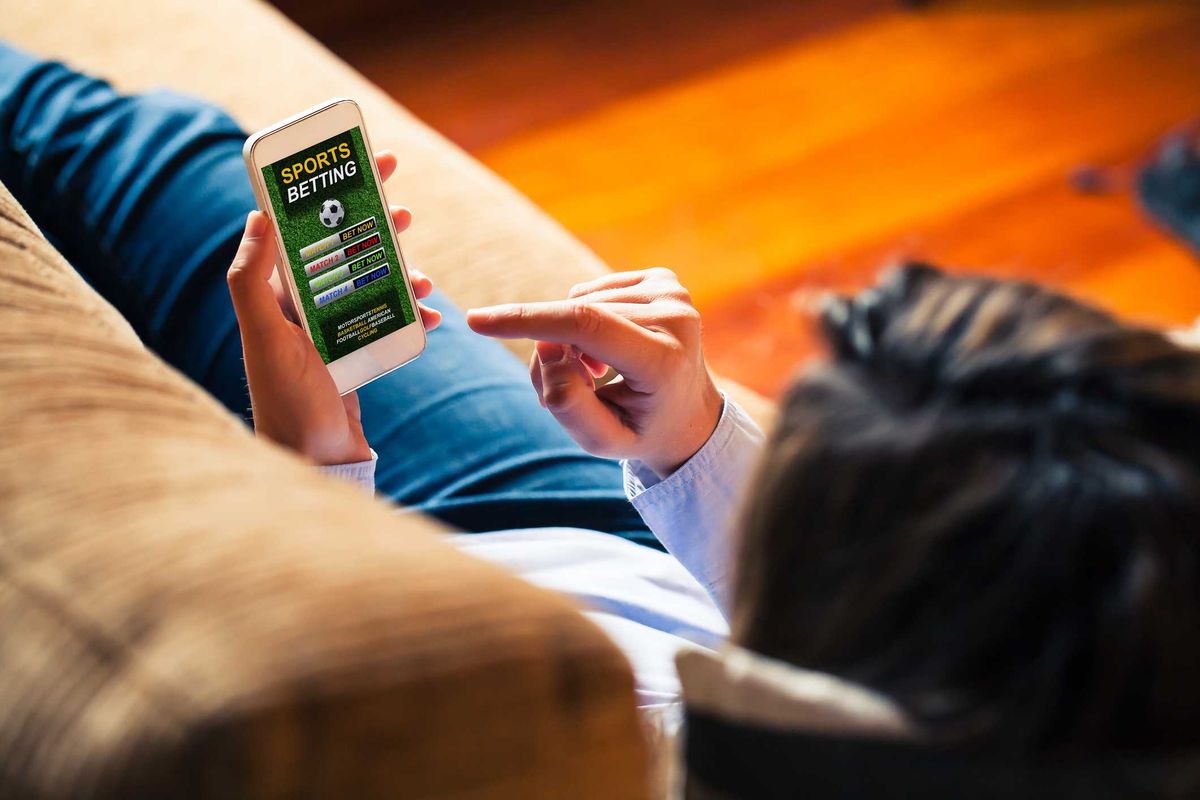2018-08-19
Quei pezzi dello Stato che tifano accoglienza
Lo scontro tra Viminale e Guardia costiera sul caso della nave Diciotti mostra l'esistenza di un conflitto istituzionale profondo. La gestione dell'emergenza sbarchi ha infatti dato ampi poteri e prestigio alle Capitanerie. Oltre a 27 milioni di fondi europei.C'è qualcosa di grottesco nella situazione della nave Diciotti, ancora ferma in rada davanti Lampedusa con il suo carico di 177 migranti, in attesa di autorizzazioni dal Viminale (il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha chiesto «urgenti informazioni» sulla situazione). Una nave della Guardia costiera italiana che non può attraccare in un porto italiano: la contraddizione balza agli occhi. Ma è un vicolo cieco a cui non si è giunti per caso. A ogni barcone che si affaccia nelle acque del Mediterraneo si consuma infatti una sorta di resa dei conti interna fra apparati dello Stato italiano. Prendiamo l'ultimo caso, quello appunto dei 177 immigrati attualmente a bordo della nave italiana. L'intervento della Diciotti è apparso quanto meno irrituale, se non del tutto arbitrario. Sono infatti le autorità maltesi, nelle cui acque si è verificato il salvataggio, ad aver sottolineato che quella della nave italiana è stata «un'intercettazione ingiustificata in mare aperto, non sussisteva alcun elemento di pericolo. Le vostre affermazioni secondo cui i migranti vi stavano contattando per informarvi che erano in difficoltà sono false. La vostra è stata un'interferenza». Non c'era emergenza, quindi, né richiesta di intervento. E non c'è stata neanche comunicazione con il Viminale, come Matteo Salvini ha subito sottolineato, stizzito. Perché questa opacità nell'azione di una nave che dovrebbe agire per conto dello Stato italiano? Che la nostra Guardia costiera non remi sempre nella stessa direzione del governo gialloblù è più che un'impressione. Bisogna ricordarsi che, nel periodo d'oro delle Ong, quando fu non a caso creata l'espressione «taxi del mare» per designare quello che era diventato un vero e proprio sistema ben rodato, la Guardia costiera era diventata l'organismo di riferimento delle imbarcazioni degli attivisti. Era infatti l'Imrcc, il Centro nazionale per il coordinamento del soccorso marittimo di Roma, ad assegnare le competenze d'intervento dopo ogni chiamata di soccorso. Un ruolo che non solo l'ha posta a stretto contatto con le Ong, ma le ha permesso anche di ampliare enormemente raggio d'azione, mezzi e prestigio.C'è, inoltre, anche una questione di vil denaro. Sul sito della Guardia costiera, si precisa esplicitamente che, «con lo scopo di affrontare l'eccezionale pressione migratoria che insite sulle frontiere di alcuni Stati membri, l'Unione Europea ha istituito un meccanismo di solidarietà e sostegno aggiuntivo per affrontare situazioni di emergenza alle frontiere esterne dell'Unione». Si illustrano poi le domande di finanziamento avanzate dal corpo e valutate positivamente dalla Commissione Europea. Il grosso dei fondi sono stati ottenuti nel 2016: 2.241.692 euro, poi 12.253.584, e ancora 4.607.706, 693.300, 1.844.816 e 2.726.687. Nel 2017, è indicato un solo finanziamento di 2.726.687 euro. Più di 24 milioni in un anno, quasi tre l'anno successivo. Un bel tesoretto. Nulla di male, sia chiaro, si tratta di fondi destinati a potenziare un corpo dello Stato italiano. La finalità dei finanziamenti, tuttavia, è ben indicata ed è una sola: quella di gestire l'emergenza migratoria. Che il cambiamento di andazzo faccia storcere la bocca a chi si era ormai abituato a gestire il Mediterraneo come casa propria è comprensibile. Senza trascurare il fatto che lo stesso governo non è sempre monolitico sulla questione migranti. E per quanto la Guardia costiera risponda principalmente al ministero delle Infrastrutture dell'allineatissimo Danilo Toninelli, essa, avendo anche compiti militari, è pure alle dipendenze del ministero della Difesa di quella Elisabetta Trenta che, poco dopo essere stata nominata, candidava la Marina militare al premio Nobel per la pace per aver salvato i migranti in mare. E che ad Avvenire affermò che «la parola accoglienza è bella, la parola respingimenti è brutta», che «c'è il diritto di assicurare un asilo a chi fugge dalla guerra e il diritto di arrivare e trovare un lavoro», e persino che occorreva dire «basta a una eccessiva demonizzazione» delle Ong. Lo scorso 14 luglio, sulla Verità, Francesco Bonazzi faceva in effetti notare: «La sensazione è che ci siano parti dello Stato che sull'immigrazione remano contro la nuova linea della fermezza». E aggiungeva: «Sarebbe ingenuo ignorare che dietro al tandem Salvini-Toninelli non c'è una macchina compatta. E la Guardia costiera, guidata dall'ammiraglio Giovanni Pettorino, ne è un esempio». Lo stesso Pettorino che ancora a giugno scorso ci teneva a sottolineare che «abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso» e che la risposta è «un obbligo giuridico» ma anche «un obbligo che sentiamo moralmente». Precisazione che non ha altra funzione se non quella di ostentare una presa di posizione politica. Ma non si tratta di prese di posizioni isolate. Vincenzo Melone, comandante fino al febbraio scorso, sostenne in Parlamento che «riportare in Libia i migranti è illegale». L'ammiraglio Enrico Credendino, che guida l'operazione Sophia, ha sempre ribadito che «il diritto del mare non vieta alle Ong di entrare in acque libiche». Ancora ad Avvenire, invece, l'ammiraglio Vittorio Alessandro, responsabile delle relazioni esterne delle Capitanerie di porto negli anni del boom degli sbarchi a Lampedusa ha spiegato: «Appartengo a una storia condivisa dai colleghi, professionisti del mare, dei quali conosco non solo la serietà, la netta adesione alle leggi dello Stato ma anche la sensibilità. Non so quanto sia moneta corrente ancora l'umanità, ma in mare c'è la regola del salvataggio come prima risposta. Il resto viene dopo. Ritengo di poter condividere con tutti i marinai, coi quali ho fatto un percorso di vita, un imbarazzo e un grande senso di impotenza». Un senso di imbarazzo che, forse, qualcuno ha pensato di esorcizzare facendosi un giretto nelle acque maltesi.