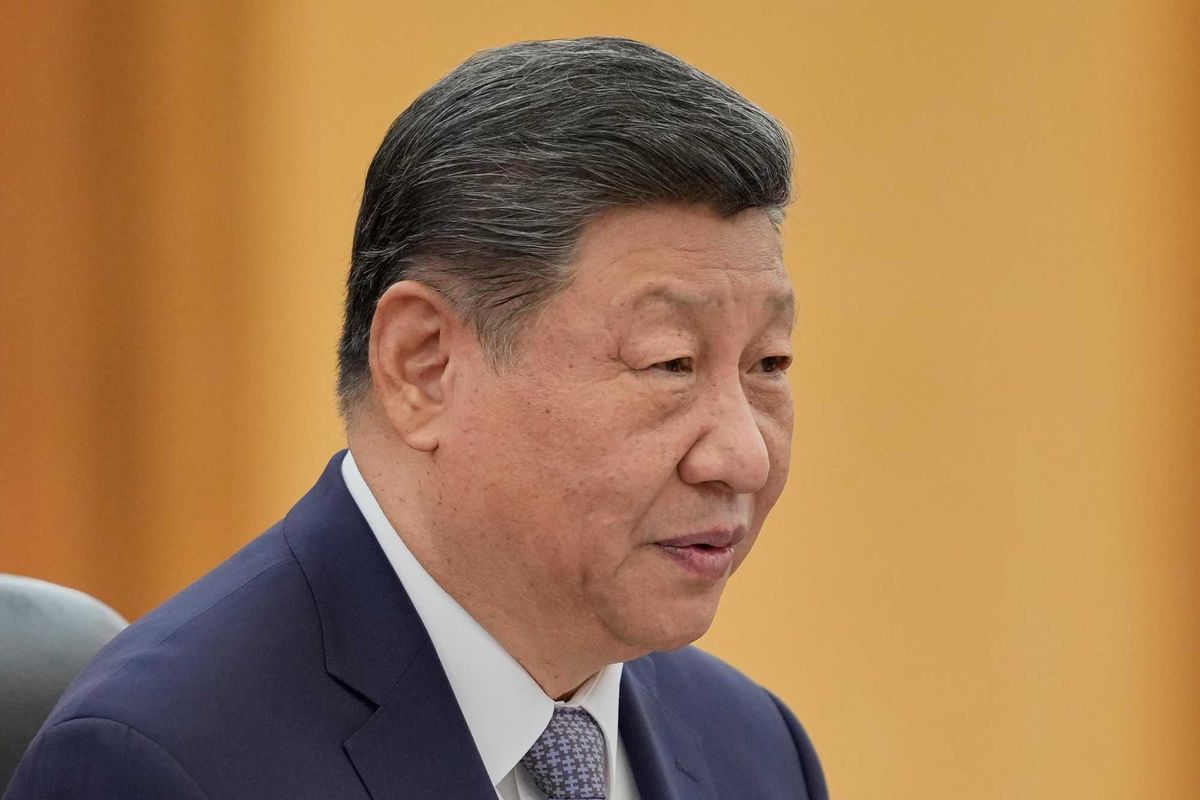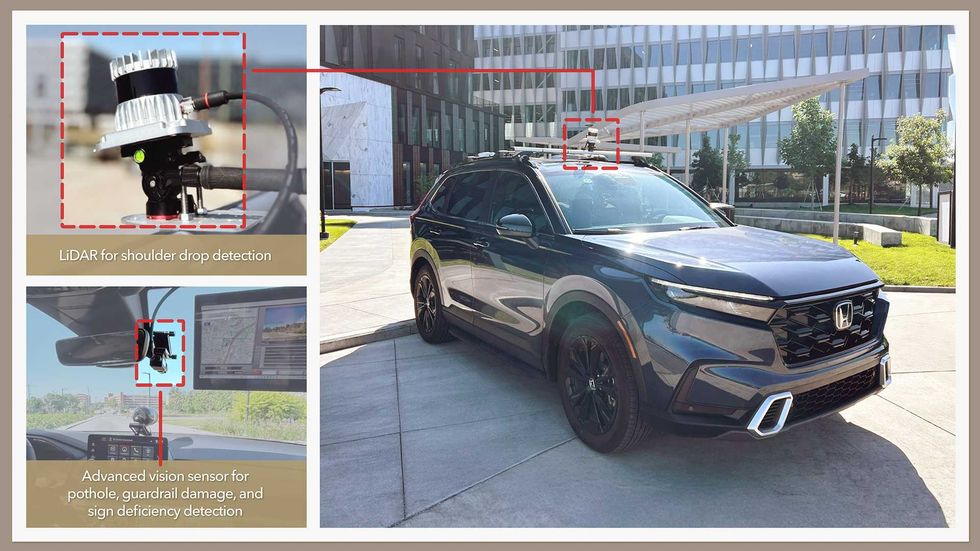Super poliziotto, spia e «burattinaio». L’eminenza grigia degli Anni di piombo

Agli italiani che ricordano il periodo storico, tra il 1969 e il 1980, quando l'atto di sostare in una stazione ferroviaria o di salire su un treno paventava immagini di ordigni esplosi e carni dilaniate, e che ancora si pongono domande sui mandanti ed esecutori delle stragi perpetrate nel Paese nel corso dei truci anni della «strategia della tensione», il nome di Federico Umberto D'Amato risulta poco noto.
Eppure con questa figura schiva che, attraverso una progressione di carriera, iniziata il 1° agosto 1943, quando entrò in polizia e fu assegnato al commissariato di Trastevere a Roma, divenne il più potente e ascoltato dirigente di quell'Ufficio affari riservati (Uar) del ministero dell'Interno, cellula istituzionale con ruolo di polizia politica e di intelligence al più alto livello, di fatto un super-servizio segreto, s'intrecciano gli enigmi tuttora scarsamente chiariti della Prima Repubblica durante la Guerra Fredda. Come quelli che ancora sussistono sull'eccidio alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, che ebbe un bilancio di 85 morti e centinaia di feriti.
L'11 febbraio 2020, la Procura generale di Bologna ha formalizzato avvisi di conclusione delle indagini con ipotesi di reato quale presunto mandante e finanziatore della strage nei confronti di D'Amato, in concorso con l'ex-capo della loggia massonica segreta P2, Licio Gelli, con il banchiere Umberto Ortolani e con l'ex-direttore della rivista Il Borghese, Mario Tedeschi. Gli indiziati sono tutti deceduti. Le imputazioni della Procura petroniana si basano su un appunto manoscritto in possesso di Gelli al momento del suo arresto a Ginevra il 13 settembre 1982, nel quale, sotto l'indicazione del numero di conto corrente del «Venerabile» all'Unione Banche Svizzere (525779-.Xs) e la dizione «Bologna», sono riassunte varie operazioni finanziarie avvenute tra il 1979 e il 1980 a favore di riceventi con nome in codice. Una di esse, è destinata a un fantomatico «Relaz. Zaff.», personaggio oppure organizzazione che, nell'ottobre 1980, avrebbe ricevuto 850.000 dollari attraverso 5 bonifici.
Non è la prima volta che questo documento finisce al centro di un'inchiesta giudiziaria, ma stavolta, la Procura di Bologna suppone che lo «Zaff» del manoscritto sia il criptonimo di D'Amato, dominus dell'Uar. La tesi è che egli, appassionato di gastronomia - tanto da essere stato incaricato, nel 1977, dal settimanale di sinistra L'Espresso, di curare una rubrica di cucina, firmata con pseudonimi, e di dirigere la Guida dei ristoranti italiani - sia stato il destinatario degli emolumenti. L'identificazione di «Zaff.» in D'Amato si legherebbe al fatto che colui che amava essere soprannominato «lo Sbirro», avesse esaltato le proprietà dello zafferano in due righe di un suo libro del 1984, Menu e dossier.
Un altro indizio da decifrare è il versamento di 506.000 dollari, somma che corrisponde a quella del quarto bonifico a favore di «Zaff.», su un conto Ubs di Ginevra chiamato «Federico», forse provenienti dalla filiale peruviana del Banco Ambrosiano, eseguito da tale avvocato Michel De Gorsky, amministratore della società «Oggicane», che sarebbe riconducibile a D'Amato. Questi fondi furono utilizzati nel novembre 1979 per l'acquisto di un appartamento a Parigi che fu in effetti, prima di essere venduto, di proprietà dello stesso ex capo dell'Uar.
In attesa di conoscere maggiori dettagli sull'inchiesta dei pm bolognesi, lo storico Giacomo Pacini, che nel libro uscito per Einaudi La spia intoccabile. Federico Umberto D'Amato e l'Ufficio affari riservati, parte da questi elementi per ricostruire cupi retroscena degli anni degli opposti estremismi. Tuttavia sostiene che la tesi accusatoria che vorrebbe D'Amato - nel 1980 direttore della polizia di frontiera - complice di Gelli nel finanziamento di cellule eversive neofasciste mediante fonti distratti dal Banco Ambrosiano e confluiti nelle banche di Ortolani, appare «estrema», «fino ai limiti della credibilità».
D'altra parte, un altro nodo, archiviato dalla Procura di Bologna, resta insoluto. È quello riconducibile alla «pista palestinese», in base al quale l'attentato del 2 agosto sarebbe stato un atto di rappresaglia del Fronte nazionale di liberazione della Palestina (Fnlp), per violazione da parte delle autorità italiane del «lodo Moro», accordo di non belligeranza con i palestinesi accettato dallo statista Dc, venuto meno con l'arresto novembre 1979 a Ortona (Chieti) di alcuni militanti di Autonomia operaia che trasportavano missili terra-aria Strela sovietici destinati ai palestinesi e, a Bologna, di Abu Anzeh Saleh, garante del Fnlp.
Ma, riguardo l'incriminazione di D'Amato, che rapporti intratteneva con Gelli? E qual era la sua storia? Pacini, paziente esploratore d'archivi, ne ricostruisce, con dovizia di riferimenti documentali, biografia e attività. Quando, nel luglio 1981, il ministro dell'Interno Virginio Rognoni chiese all'alto funzionario spiegazioni sul perché il suo nome apparisse tra gli iscritti alla P2, egli rispose di non aver avuto nulla a che fare con le attività della loggia. E «che era entrato a farne parte solo per svolgere quei compiti di tipo informativo da sempre chiestigli dal ministero», gli stessi rapporti «di quelli che aveva avuto con militanti dell'estrema sinistra, dell'estrema destra, del Pci, del Msi, del terrorismo palestinese o con agenti dei servizi sovietici». In un'intervista, definì Gelli «un cretino» che diceva «tremende banalità», pur sapendo essere «persuasivo, rassicurante», tanto che potenti, si trattasse di «un presidente del Consiglio pericolante (…) o un direttore di giornale» che temevano di essere sostituiti, si rivolgevano a lui nella suite all'hotel Excelsior di Roma, ma il suo scopo «non era politico, ma economico. Perché mai avrebbe dovuto sovvertire le istituzioni? Ideare un golpe? (…) Lui stava benissimo così, intrallazzando, facendo soldi a palate».
Federico Umberto D'Amato nacque solo per una coincidenza a Marsiglia il 4 giugno 1919. Era figlio di un commissario di polizia napoletano di origini aristocratiche e di un'operaia piemontese, attivista nel sindacalismo cattolico. Si laureò in giurisprudenza a Roma nel 1942 e i suoi primi legami con l'intelligence si ebbero dopo l'8 settembre 1943 quando, schieratosi con gli alleati, dopo essere stato iscritto al Partito fascista, l'agente segreto statunitense James Jesus Angleton lo reclutò per recuperare per l'«Offices of secret services», antesignano della Cia, nel territorio della Repubblica di Salò, gli archivi dell'Ovra, la polizia politica di Mussolini. Agli Affari riservati entrò nel 1960 e qui rimase, pur con qualche ostacolo, negli anni successivi, sempre in stretta collaborazione con la Cia, fino a diventarne direttore dal 1971 all'anno in cui esso fu sciolto, il 1974. In quel periodo l'Uar era una struttura piramidale che raccoglieva, attraverso infiltrati e collaboratori, informazioni si uomini politici (tra i quali Andreotti, Fanfani, Donat Cattin, Cossiga), sindacalisti, giornalisti (come Biagi e Bocca) e movimenti extra-parlamentari.
Alla base della piramide operavano squadre periferiche di ufficiali di pubblica sicurezza svincolati dalle questure e attivi in anonimi uffici privati. A discrezione di D'Amato era la «valutazione politica» dei rapporti pervenuti e la decisione di quali elementi trasferire alla magistratura e al ministro e quali no. Per questo egli, almeno fino al 1984, quando andò in pensione, «detenne un potere così vasto», si sottolinea nel saggio di Pacini, «da condizionare perfino le scelte dei vari ministri dell'Interno in carica». Anche Tina Anselmi, implacabile accusatrice della P2, in una puntata del dicembre 1989 di La notte della Repubblica di Zavoli, lo elogiò, sostenendo che «negli apparati di sicurezza ci sarebbero voluti più uomini della sua capacità e intelligenza». D'altra parte, l'ex-capitano del Sid Antonio La Bruna, dichiarò ai giudici Mastelloni e Salvini che l'organizzazione di estrema destra Avanguardia nazionale, «era pilotata dall'Uar retto dal D'Amato» e altri verbali riferiscono che il suo leader, Stefano Delle Chiaie, implicato nelle indagini su piazza Fontana (1969), frequentava con familiarità gli ambienti dell'Uar e l'ufficio di D'Amato.
Tra rififi nei servizi segreti e catene di figure messe a tacere per sempre, in una sciarada di specchi e rimbalzi di responsabilità, di Federico Umberto D'Amato resta una sibillina intervista nella quale, mentre esibiva i manichini meccanici che collezionava e di cui amava definirsi il jongleur, il manovratore, sosteneva che «una strage, il più vile attentato che si possa fare, è anche il più facile, non lascia tracce» e, con tono tenebroso, «che le stragi possono essere fatte un po' da tutti».
Parti del suo archivio segreto ancora non si sa dove siano. Nel suo testamento, «somme di denaro di scarsa entità», rivela l'autore del libro, «compaiono, insieme alla titolarità di due appartamenti a Roma, come lascito ad Antonella Gallo, deceduta, compagna di D'Amato dopo la morte della prima moglie Ida Melani (il funzionario non aveva figli, ndr)». Negli anni Sessanta fondò il club di Berna, reunion dei servizi di sicurezza europei, talvolta con partecipazione della Cia, ancor oggi esistente. In vita non fu mai processato. Dopo la sua morte, nel quartier generale Nato a Bruxelles, gli fu intitolata una delle sale più prestigiose, riconoscimento mai ottenuto da alcun agente dell'intelligence italiana.