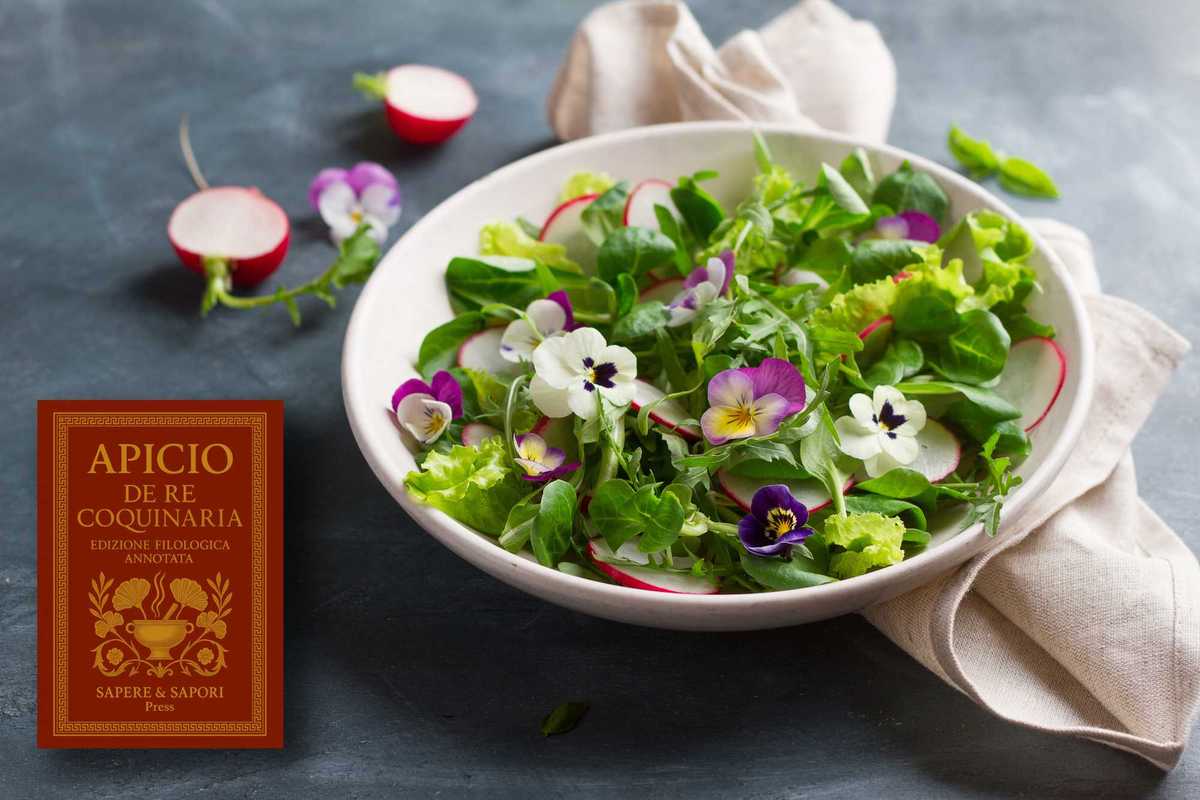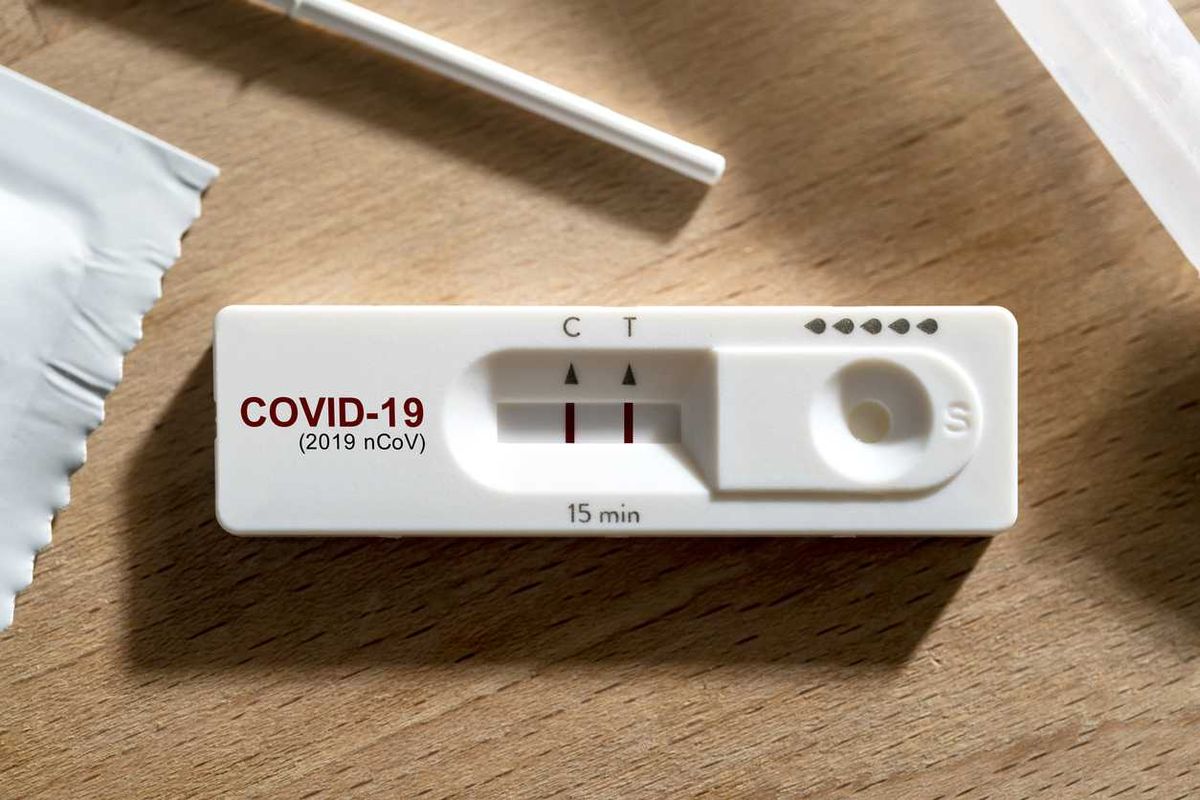
Zero tituli. Forse proprio zero no, visto il «curriculum ragguardevole» evocato (per carità di patria) dall’onorevole Alberto Bagnai della Lega; ma uno dei piccoli-grandi dettagli usciti dall’audizione di Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler in commissione Covid è che questo custode dei big data, colui che in pandemia ha fornito ai governi di Giuseppe Conte e Mario Draghi le cosiddette «pezze d’appoggio» per poter chiudere il Paese e imporre le misure più draconiane di tutto l’emisfero occidentale, non era un clinico né un epidemiologo, né un accademico di ruolo.
«Ho cercato il suo settore scientifico disciplinare sull’organico del Ministero dell’Università e della ricerca», lo ha sollecitato Bagnai, «e non sono riuscito a trovarla: lei è di ruolo nell’università italiana?». Merler ha risposto con un rassegnato «no», aprendo la strada a una ridda di considerazioni che portano tutte verso la stessa conclusione, condivisa anche dal presidente della commissione Marco Lisei (Fratelli d’Italia): il matematico, scelto dall’allora ministro della salute Roberto Speranza per governare i dati sulla base dei quali è stato chiusa l’Italia per due anni, si è trovato all’improvviso nella stanza dei bottoni senza mai essere stato contrattualizzato e senza avere alcun titolo universitario. Tant’è che il senatore Claudio Borghi della Lega non ha esitato a complimentarsi con lui: «Abbiamo un non-medico e un non-accademico che è stato considerato la voce più autorevole del Cts in una delle situazioni più drammatiche della nostra nazione: interessante». Ed è stato lo stesso Borghi, a questo punto, a chiedere a Merler come abbia fatto ad arrivare fin lì, domanda rivolta al matematico anche da Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione incaricata di fare luce sulla sciagurata gestione pandemica. Merler ha citato il Cnesps (Centro nazionale di epidemiologia) di Stefania Salmaso, poi Andrea Piccioli del ministero, poi Gianni Rezza. Fatto sta che - ed è questa la notizia - Speranza e Conte hanno costituito il primo Cts senza inserire né un clinico (come ha riferito Matteo Bassetti nell’audizione di lunedì scorso) né un epidemiologo: come fare la torta al cioccolato con tanti ingredienti ma senza cacao. In compenso, però, Conte e Draghi, che gli è succeduto a febbraio 2021, hanno affidato a un oscuro matematico della provincia di Trento, Merler per l’appunto, tutta la statistica pandemica nonché il piano di contingenza, dandogli accesso a tutte le informazioni e alle notizie riservate. Il tutto senza contratto e senza compenso, dunque a quanto pare pro bono.
Basterebbe già questo per avere un’idea dello spirito brancaleonico che ha caratterizzato la gestione operativa di Speranza. Spirito afferente all’attitudine - più che alle competenze di tutto rispetto - delle 1.000 task force, comitati e commissioni che a vario titoli sono intervenute nella confusa gestione pandemica: il problema, infatti, è stato il mancato coordinamento e la riorganizzazione delle informazioni, oltre che l’assenza di un piano pandemico.
Merler ne ha dato un’idea ben precisa rispondendo ad altre domande di Alice Buonguerrieri riguardo alcune affermazioni rilasciate da lui stesso alla procura di Bergamo, secondo cui aveva cominciato a studiare il virus Sars Cov-2 «prima di Natale 2019». «Come faceva ad essere a conoscenza di questi elementi prima ancora che lo stesso Oms li conoscesse? E chi ha ritenuto di informare?», gli ha chiesto Buonguerrieri. Merler ha dapprima nicchiato, poi ha ammesso a mezza bocca che gli erano arrivati alcuni dati in cui «i colleghi cinesi» avevano ricostruito la storia dell’infezione di alcuni pazienti riportandola a prima di Natale. Quindi ha riferito di aver informato già a inizio febbraio del virus e della sua pericolosa diffusività anche Speranza. Ma, come noto, in quei primi due mesi del 2020, governo e parlamentari del Pd minimizzavano andando a consumare gli spring rolls sui Navigli milanesi, salvo poi, con attitudine quasi schizofrenica, ribaltare l’approccio e diffondere il terrore in tutto il Paese dall’11 marzo 2020 in poi. Anche Lisei gliene ha chiesto conto: «L’adozione di misure di contenimento, come il lockdown, se adottate tempestivamente a livello locale possono essere uno strumento alternativo al lockdown nazionale?». «È una domanda maledettamente complicata, ma in linea di principio sì», ha replicato Merler. Confermando - ha chiosato Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori Fdi - «ciò che tanti scienziati e i parenti delle vittime della Bergamasca dicono da tempo: la zona rossa in Val Seriana andava istituita già a fine febbraio […], ma invece di chiudere per tempo e solo la Bergamasca, Conte decise di chiudere l’Italia intera con il lockdown nazionale. Il Governo Conte II pensò di far redigere un piano, incaricando un matematico, in piena pandemia, ma non ritenne di applicare un Piano pandemico influenzale già pronto, quello del 2006, che proponeva anche l’istituzione delle zone rosse».
Alberto Bagnai e Claudio Borghi hanno incalzato il matematico di Trento anche sulle sue stime catastrofistiche diffuse sia nel 2020 (quando Merler previde 150.000 terapie intensive se avessimo riaperto a maggio), sia nel 2021, quando quantificò 1.300 morti al giorno a metà luglio per poi averne «soltanto» 23. Merler ha smentito che quelle fossero «previsioni» e ha scaricato la responsabilità alla cattiva comunicazione della stampa. Si è anche dichiarato «arrabbiato» con Mario Draghi che lo aveva criticato pubblicamente per quelle analisi errate. «Questo significa», ha osservato Borghi, «che tutti i giornali ci propinavano fesserie e forse anche il presidente del Consiglio ogni tanto qualche fesseria l’ha detta (a cominciare da quel “se non ti vaccini ti ammali e muori”, ndr)». Poteva andare peggio di così? Forse no.