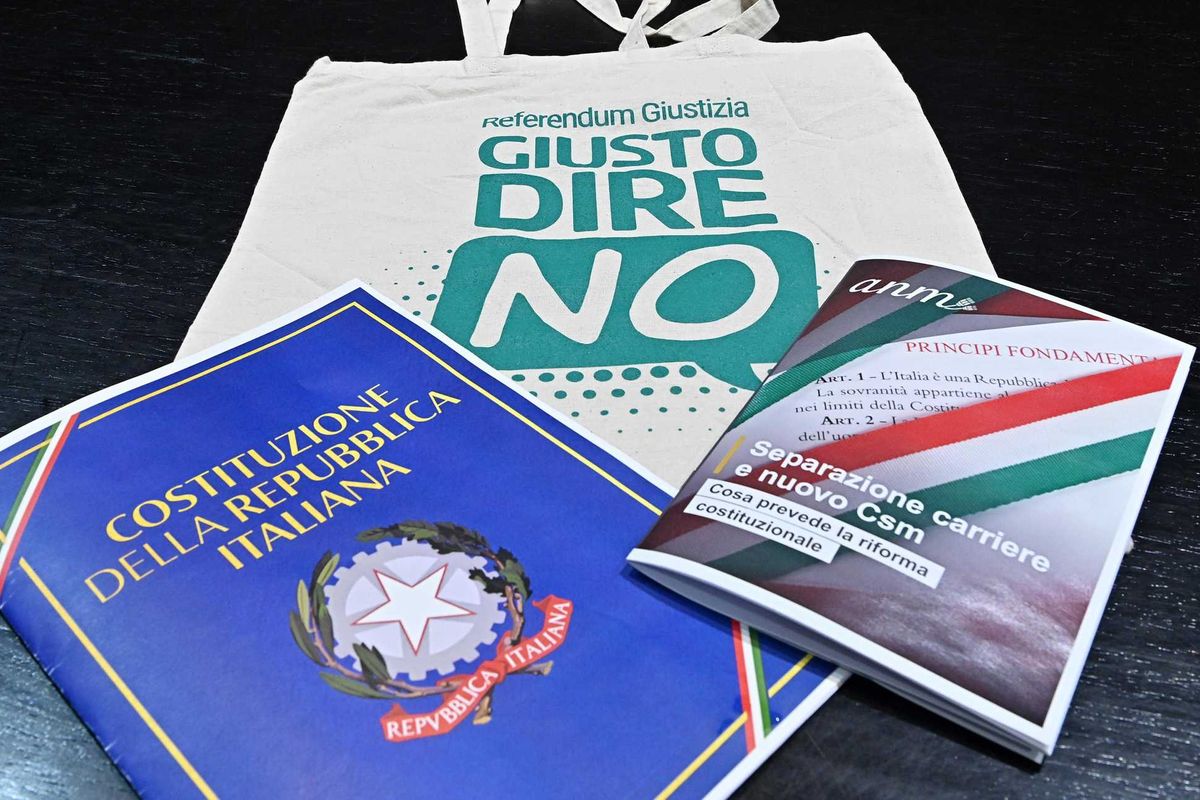True
2020-03-11
In Italia il virus uccide di più perché mancano i posti letto
Ansa
Paese che vai, mortalità del coronavirus che trovi. Su questo specifico punto l'Organizzazione mondiale della sanità è stata piuttosto chiara fin dall'inizio: la gravità del contagio dipenderà in buona parte anche dal livello di preparazione del sistema sanitario di ciascuno Stato, e dunque dalla sua capacità di assorbire il colpo dell'epidemia. Stando agli ultimi dati, il tasso di mortalità per Covid-19 in Italia è decisamente più alto rispetto agli altri Paesi del mondo. Si parla di differenze non trascurabili, che pongono interrogativi seri e delicati, e sui quali solo una conoscenza approfondita e prolungata nel tempo del virus e del suo comportamento potrà fornire una risposta.
Tuttavia, osservando i numeri nudi e crudi non si può fare a meno di notare uno scostamento notevole. Nel nostro Paese, ormai stabilmente al secondo posto per numero di casi nel mondo, il tasso di mortalità si attesta addirittura al 6,22% (631 decessi su 10.149 casi totali). Occorre tuttavia specificare che i dati di ieri sono viziati dal fatto che la Lombardia ha comunicato il numero dei decessi, ma non quello dei contagi. Fino a lunedì, comunque, il tasso di mortalità viaggiava allo 5,05%, un valore molto più elevato di quello del resto del mondo, che invece si ferma al 3,48%. Parlando della Cina, luogo dal quale il patogeno si è diffuso per poi contagiare il mondo intero, occorre fare una distinzione: la maggior parte dei decessi (circa il 96%) si trova nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, dove la percentuale di decessi è paragonabile alla nostra (4,43%), mentre nel resto del Dragone è decisamente più bassa, addirittura inferiore all'1% (0,88%). Positivo l'andamento della mortalità anche in Corea del Sud, che pure si aggiudica il terzo gradino del podio per numero di casi (7.513), e nella quale il tasso si attesta allo 0,72%. Dati inferiori all'Italia anche in Francia (1,16% per 949 casi) e, soprattutto, in Germania, dove si contano appena 2 decessi su 1.139 contagi.
Quali possono essere le cause che hanno portato a queste differenze tanto marcate? Ovviamente non si può non tenere conto delle diverse modalità di conteggio dei decessi e delle tempistiche di avanzamento dell'epidemia, fattore quest'ultimo che fa presagire come negli altri Paesi la diffusione del virus sia ancora ben lungi dall'aver espresso il massimo potenziale. Senza contare le abitudini di vita, compresa una maggiore inclinazione alle relazioni sociali, e la composizione demografica della popolazione. Tutti elementi che, almeno sulla carta, giocano a nostro sfavore. Ma al netto di questi importantissimi caveat, è possibile identificare un comune denominatore in grado di giustificare, almeno parzialmente, un andamento tanto sfavorevole nel nostro Paese?
Senza dubbio la resilienza del sistema sanitario di fronte a uno choc di questa portata diventa determinante. Non si può tenere in considerazione solo la gratuità dei servizi e la (sacrosanta) universalità di accesso alle cure: in situazioni di crisi come quella che stiamo affrontando in queste settimane, uno degli elementi in grado di mitigare gli effetti risulta senza dubbio la capacità di accoglienza delle strutture sanitarie. E da questo punto di vista, gli altri Stati ci fanno le scarpe. Prendiamo il dato dei posti letto, un marker infallibile per valutare la qualità del sistema salute di un Paese. Negli ultimi tre decenni, dati Ocse alla mano, in Italia si è assistito a una lenta ma costante diminuzione della disponibilità per abitante: si è passati infatti dai 6,8/1.000 abitanti del 1991 ai 3,18 del 2017. Tradotto in parole semplici, meno della metà. Nello stesso periodo la Germania è passata da 10,1 a 8 posti ogni 1.000 abitanti. Dunque, nonostante la lieve flessione, Berlino ci surclassa in termini assoluti. Quello che impressiona è la cavalcata trionfale della Corea del Sud, risalita dai 2,48 di trent'anni fa ai 12,27 posti odierni, vale a dire quasi il quadruplo di quelli italiani. Una progressione che ha permesso a Seul di guadagnarsi il secondo gradino del podio a livello mondiale dopo il Giappone. Paradossalmente, queste cifre hanno suscitato più di una polemica nella penisola coreana, dal momento che un così grande numero di strutture necessita di essere adeguatamente approvvigionato di personale medico, al fine di garantire elevati standard qualitativi.
Parlano da soli anche i numeri della terapia intensiva, la cui robustezza gioca oggi un ruolo fondamentale nella sfida contro il coronavirus. Qua la fa da padrona la Germania, la quale può contare su 28.000 posti letto (34 ogni 100.000 abitanti) a disposizione degli ammalati più gravi. Poco più indietro la Corea, con 10.000 posti letto che si traducono in 20 ogni 100.000 abitanti. Distante anni luce l'Italia, che dispone di appena 5.100 posti, cioè 8 ogni 100.000 abitanti. Un gap imbarazzante dovuto in gran parte dai tagli alla sanità dell'ultimo decennio, e in assenza del quale il nostro Paese sarebbe stato in grado di affrontare l'epidemia con armi ben più efficaci.
Miracolo tedesco? Occhio, Berlino non conta i decessi come facciamo noi
Il virus ha reso l'Italia come una zona di guerra. In Francia, minaccia la classe dirigente. In Germania, invece, nonostante il contagio inizi a galoppare, l'allarme è rimasto contenuto. Soprattutto, il Paese registra un numero di vittime esiguo: due (la terza era un pompiere tedesco di 60 anni morto in Egitto) su 1.457 infetti. Ma fu vera gloria, direbbe Alessandro Manzoni? Forse no. Forse anche i teutonici hanno un problema, ma l'hanno gestito all'anglosassone: sobrietà e scarsa enfasi, finché possibile.
È vero che in Germania, dopo una partenza timida, la frequenza dei tamponi è cresciuta. Non v'è però certezza sul totale: i negativi non vengono comunicati. Le casse mediche Kbv parlano di 35.000 test. Eppure, nessun accertamento è stato compiuto sui 202 pazienti morti per influenza. Non è da escludere, dunque, che qualcuno di loro avesse contratto il coronavirus. Peraltro, stando al racconto di una donna tedesca rientrata dall'Italia, riportato da Berlino magazine, farsi esaminare, nel Paese, non è affatto facile. La signora dichiara di avere accusato sintomi da Covid-19, ma di non essere riuscita a mettersi in contatto con un medico né tramite i numeri verdi per l'emergenza, né raggiungendo di persona il tendone allestito da un ospedale berlinese: si somministrano 60 tamponi al giorno nonostante le file di centinaia di persone (e privatamente, il test costa 300 euro, «ma nessuno sa come si faccia»).
Inoltre, segnalava giorni fa Sky Tg24, chi è stato colpito dal coronavirus, ma al momento del decesso soffriva di patologie più gravi, è stato incluso nel conteggio dei morti a causa di quelle altre malattie. Pertanto, le cosiddette «comorbidità» contribuirebbero a diminuire la portata del fenomeno. Più o meno, è lo stesso (mezzo) tentativo fatto in Italia: dopo aver scatenato il panico, il governo aveva avallato l'idea che si muore «con» il coronavirus e non «per» il coronavirus. Da noi, alla fine, ha prevalso l'approccio alla cinese o alla coreana: cercare, attraverso i tamponi, tutti i positivi e quindi associare al Covid-19 i 631 morti registrati fino a ieri.
Non significa per forza che siamo più trasparenti: dipende da che via è stata scelta - e perché: meno caos significa meno danni economici. Per di più, in Germania i Länder godono di ampia autonomia in ambito sanitario: è possibile che alcuni utilizzino metodi di calcolo che sottostimano la diffusione del virus.
Ufficialmente, i tedeschi attribuiscono i pochi decessi (un'ottantanovenne di Hessen e un settantottenne di Heisenberg) all'età media dei contagiati. Secondo Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute, l'organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive, i positivi, in Germania, «nel 70% dei casi» hanno tra i 20 e i 50 anni. L'età media lì è di 40 anni, in Italia è di 60. Lo studioso, tuttavia, ha precisato che «nelle prossime settimane e mesi» i dati dei due Paesi tenderanno ad allinearsi. È in questo solco che, «per tranquillizzare complottisti scemi e idioti d'ogni genere», s'è mosso il corrispondente eurolirico Udo Gümpel: «Dopo il morto vigile di fuoco amburghese deceduto in Egitto», ha twittato in italiano teutonicizzato, «anche due malati di coronavirus in Germania sono deceduti [...]. Due focolai. Dunque: niente immunità crucca». I tedeschi «sono mortali».
Lo stesso Gümpel, in un altro ameno cinguettio, aveva spiegato che gli anziani tedeschi si ammalano di meno perché «hanno molto meno socialità, per esempio bar e ritrovi: socialmente più isolati ma protetti». Più laicamente, il vicepresidente di International Sos, la principale azienda di servizi di sicurezza medica del mondo, interpellato da Fox news, aveva osservato che «il distanziamento sociale potrebbe essere più complicato in culture avvezze al contatto intimo». Se c'è un'epidemia e una nazione algida ne incontra una di baci e abbracci, quella di baci e abbracci è morta...
Non si possono non prendere sul serio, però, i riscontri sulle dotazioni del servizio sanitario tedesco. L'ha ricordato il ministro della Salute, Jens Spahn: la Germania dispone di 28.000 posti in terapia intensiva, il dato più alto d'Europa, anche se i letti totali risultano già occupati per l'80%. L'Italia è entrata nel pieno dell'emergenza con 5.100 unità di rianimazione. Probabilmente è questo il superpotere teutonico, che consente una relativa tranquillità, nonostante l'esecutivo di Berlino abbia ammesso l'esistenza di focolai locali (ci sono casi in tutti i 16 Länder), abbia attivato il Piano nazionale antipandemia, abbia richiesto la sospensione degli eventi con più di 1.000 partecipanti, abbia deciso che il match di Champions League, Bayern-Chelsea, si giocherà a porte chiuse e sia orientato a limitare l'accesso agli stadi pure in Bundesliga, con buona pace della Federcalcio tedesca. Nel frattempo, musei, teatri e discoteche restano aperti. E il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha forse lasciato intendere qual è lo scenario che la Germania, tenendo i toni bassi, vuole fugare: «Quanto più lentamente si diffonde il virus, tanto più è probabile che possiamo prevenire una recessione economica». Essere «appestati» costa.
A Roma un altro centro anti epidemie. Il problema è che è chiuso da 15 anni
Negli ospedali della Lombardia ormai prossimi al collasso si creano reparti di terapia intensiva perfino nei corridoi per cercare di fermare il coronavirus? A Roma, facendo tutti gli scongiuri possibili, si sta cercando, in poche ore, di allestire un circuito parallelo per i malati con Covid-19 per non allargare il contagio e garantire l'assistenza anche ai pazienti delle «normali» patologie? Allo Spallanzani, il centro romano specializzato per le malattie infettive, esiste un ospedale «ad alto isolamento», nuovo di zecca, costruito apposta per affrontare le nuove pesti del terzo millennio. Ma da quindici anni, impeccabile nella sua struttura modernissima, è inutilizzato. Ultimato ma assolutamente, irrimediabilmente, lasciato a fare solo da monumento a se stesso.
Le vetrate impeccabili che lo avvolgono riflettono le nuvole e il verde dei giardini. Soprattutto sono lo specchio della strana sindrome da cupio dissolvi, o semplicemente taffaziana, più pericolosa di ogni infezione che da tempo ammorba l'Italia. Un esempio di come pastoie burocratiche insieme a furori giustizialisti riescano ad ingoiare tutto nella pubblica amministrazione ed in particolare nella sanità, malefatte o presunte tali ed eccellenze.
La storia è molto semplice. La struttura viene concepita e realizzata nel 2003-2004 ai tempi della Sars sotto l'egida di Guido Bertolaso, sottosegretario al governo Berlusconi con delega alla Protezione civile, che oltre ad essere un grande organizzatore ed essere circondato da un team di prim'ordine, è, combinazione, anche un medico. La Sars, l'altra infezione da coronavirus dilagata dalla Cina dal 2002 al 2004, fortunatamente non ha lo sviluppo da pandemia che si temeva. Ma la struttura ormai c'è. Anche l'ospedale «anti-epidemie» viene inghiottito nell'indagine contro Bertolaso e quella che noi della grancassa mediatica abbiamo chiamato la «cricca».
Ma, piaccia o no, si tratta di una grande intuizione scientifico-operativa. Come stiamo scoprendo a costi altissimi in questi giorni le nuove pesti richiedono di avere strutture dedicate, riservate solo a questi malati per evitare il collasso dell'intero sistema sanitario. Così ad esempio nel Lazio, che, Dio non voglia, potrebbe essere investito in pieno dallo «sciame infettivo» del Covid-19, in tutta fretta si sta cercando di allestire un circuito parallelo che fa capo ai tre poli ospedalieri universitari (Umberto I, Tor Vergata, Gemelli) e che non metta a contatto i contagiati con altri, malati per altre patologie o sani che siano.
In tutta la sua splendida solitudine di vetrocemento questo fantasma delle buone intuizioni sta lì, 200-300 metri al massimo dallo Spallanzani dove medici, infermieri, pazienti da settimane sono in prima linea sul fronte di questa guerra contro il nemico invisibile. Costato a quanto pare intorno ad una trentina di milioni, chi l'ha visitato dice che ha 10 posti letto di terapia intensiva «ad altissimo isolamento» e 20 posti «ad alto isolamento». Mancano solo le macchine e le attrezzature. «Anche se l'epidemia da coronavirus penso finisca prima, almeno lo spero, che possa essere resa funzionante», dice una fonte medica, «è evidente che una struttura così potrebbe essere molto utile nell'emergenza attuale».
A quanto è dato sapere mancano i collaudi: l'opera formalmente non è ancora stata collaudata. Insomma, passaggi burocratici. Chi scrive nel 2014 ai tempi di Ebola per il Tg5 realizzò un servizio nel quale l'allora responsabile della Protezione civile (competente sulla struttura) assicurò: entro sei mesi l'ospedale ad alto isolamento sarà perfettamente funzionante. «La verità è che è finito nel tritatutto della Protezione civile», dichiara una fonte medica che vuole restare anonima, «non sono passati sei mesi ma sei anni e non è stato fatto nulla».
«È una struttura di assoluta eccellenza, all'avanguardia in Europa e nel mondo», riconoscono alla Protezione civile. E dunque? «Da un po' è partito il collaudo tecnico-amministrativo ovvero la verifica degli atti. Il collaudo funzionale lo abbiamo completato, l'ultimo step è stato il collaudo dei reflui», fanno sapere. Insomma è stata realizzata a regola d'arte. «Le lungaggini? Sono dovute al fatto che dopo l'emergenza del 2003 si sono seguite le procedure ordinarie». Ah beh… «Nel Milleproroghe», continuano, «sono già stanziate le risorse perché la Regione Lazio la faccia funzionare». Tempo previsto per il trasferimento dalla Protezione civile alla Regione: settembre. Speriamo non del 2035.
Continua a leggereRiduci
Seul ha poche decine di decessi sebbene abbia quasi i nostri contagi, ma nel Paese c'è il quadruplo dei presidi ospedalieri per abitante. In Germania il doppio. Dopo anni di tagli siamo indietro pure sulle terapie intensive.La Germania ignora le vittime se presentano altre patologie. Italia, Cina e Corea cercano invece di identificare tutti i positivi.Allo Spallanzani esiste una struttura ad alto isolamento, nuova di zecca, costruita apposta per queste emergenze. Voluta da Guido Bertolaso, mai attivata a causa delle inchieste sulla Protezione civile.Lo speciale contiene tre articoli.Paese che vai, mortalità del coronavirus che trovi. Su questo specifico punto l'Organizzazione mondiale della sanità è stata piuttosto chiara fin dall'inizio: la gravità del contagio dipenderà in buona parte anche dal livello di preparazione del sistema sanitario di ciascuno Stato, e dunque dalla sua capacità di assorbire il colpo dell'epidemia. Stando agli ultimi dati, il tasso di mortalità per Covid-19 in Italia è decisamente più alto rispetto agli altri Paesi del mondo. Si parla di differenze non trascurabili, che pongono interrogativi seri e delicati, e sui quali solo una conoscenza approfondita e prolungata nel tempo del virus e del suo comportamento potrà fornire una risposta. Tuttavia, osservando i numeri nudi e crudi non si può fare a meno di notare uno scostamento notevole. Nel nostro Paese, ormai stabilmente al secondo posto per numero di casi nel mondo, il tasso di mortalità si attesta addirittura al 6,22% (631 decessi su 10.149 casi totali). Occorre tuttavia specificare che i dati di ieri sono viziati dal fatto che la Lombardia ha comunicato il numero dei decessi, ma non quello dei contagi. Fino a lunedì, comunque, il tasso di mortalità viaggiava allo 5,05%, un valore molto più elevato di quello del resto del mondo, che invece si ferma al 3,48%. Parlando della Cina, luogo dal quale il patogeno si è diffuso per poi contagiare il mondo intero, occorre fare una distinzione: la maggior parte dei decessi (circa il 96%) si trova nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, dove la percentuale di decessi è paragonabile alla nostra (4,43%), mentre nel resto del Dragone è decisamente più bassa, addirittura inferiore all'1% (0,88%). Positivo l'andamento della mortalità anche in Corea del Sud, che pure si aggiudica il terzo gradino del podio per numero di casi (7.513), e nella quale il tasso si attesta allo 0,72%. Dati inferiori all'Italia anche in Francia (1,16% per 949 casi) e, soprattutto, in Germania, dove si contano appena 2 decessi su 1.139 contagi.Quali possono essere le cause che hanno portato a queste differenze tanto marcate? Ovviamente non si può non tenere conto delle diverse modalità di conteggio dei decessi e delle tempistiche di avanzamento dell'epidemia, fattore quest'ultimo che fa presagire come negli altri Paesi la diffusione del virus sia ancora ben lungi dall'aver espresso il massimo potenziale. Senza contare le abitudini di vita, compresa una maggiore inclinazione alle relazioni sociali, e la composizione demografica della popolazione. Tutti elementi che, almeno sulla carta, giocano a nostro sfavore. Ma al netto di questi importantissimi caveat, è possibile identificare un comune denominatore in grado di giustificare, almeno parzialmente, un andamento tanto sfavorevole nel nostro Paese?Senza dubbio la resilienza del sistema sanitario di fronte a uno choc di questa portata diventa determinante. Non si può tenere in considerazione solo la gratuità dei servizi e la (sacrosanta) universalità di accesso alle cure: in situazioni di crisi come quella che stiamo affrontando in queste settimane, uno degli elementi in grado di mitigare gli effetti risulta senza dubbio la capacità di accoglienza delle strutture sanitarie. E da questo punto di vista, gli altri Stati ci fanno le scarpe. Prendiamo il dato dei posti letto, un marker infallibile per valutare la qualità del sistema salute di un Paese. Negli ultimi tre decenni, dati Ocse alla mano, in Italia si è assistito a una lenta ma costante diminuzione della disponibilità per abitante: si è passati infatti dai 6,8/1.000 abitanti del 1991 ai 3,18 del 2017. Tradotto in parole semplici, meno della metà. Nello stesso periodo la Germania è passata da 10,1 a 8 posti ogni 1.000 abitanti. Dunque, nonostante la lieve flessione, Berlino ci surclassa in termini assoluti. Quello che impressiona è la cavalcata trionfale della Corea del Sud, risalita dai 2,48 di trent'anni fa ai 12,27 posti odierni, vale a dire quasi il quadruplo di quelli italiani. Una progressione che ha permesso a Seul di guadagnarsi il secondo gradino del podio a livello mondiale dopo il Giappone. Paradossalmente, queste cifre hanno suscitato più di una polemica nella penisola coreana, dal momento che un così grande numero di strutture necessita di essere adeguatamente approvvigionato di personale medico, al fine di garantire elevati standard qualitativi. Parlano da soli anche i numeri della terapia intensiva, la cui robustezza gioca oggi un ruolo fondamentale nella sfida contro il coronavirus. Qua la fa da padrona la Germania, la quale può contare su 28.000 posti letto (34 ogni 100.000 abitanti) a disposizione degli ammalati più gravi. Poco più indietro la Corea, con 10.000 posti letto che si traducono in 20 ogni 100.000 abitanti. Distante anni luce l'Italia, che dispone di appena 5.100 posti, cioè 8 ogni 100.000 abitanti. Un gap imbarazzante dovuto in gran parte dai tagli alla sanità dell'ultimo decennio, e in assenza del quale il nostro Paese sarebbe stato in grado di affrontare l'epidemia con armi ben più efficaci. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/pero-in-italia-abbiamo-piu-morti-anche-per-carenza-di-posti-letto-2645453863.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="miracolo-tedesco-occhio-berlino-non-conta-i-decessi-come-facciamo-noi" data-post-id="2645453863" data-published-at="1769714022" data-use-pagination="False"> Miracolo tedesco? Occhio, Berlino non conta i decessi come facciamo noi Il virus ha reso l'Italia come una zona di guerra. In Francia, minaccia la classe dirigente. In Germania, invece, nonostante il contagio inizi a galoppare, l'allarme è rimasto contenuto. Soprattutto, il Paese registra un numero di vittime esiguo: due (la terza era un pompiere tedesco di 60 anni morto in Egitto) su 1.457 infetti. Ma fu vera gloria, direbbe Alessandro Manzoni? Forse no. Forse anche i teutonici hanno un problema, ma l'hanno gestito all'anglosassone: sobrietà e scarsa enfasi, finché possibile. È vero che in Germania, dopo una partenza timida, la frequenza dei tamponi è cresciuta. Non v'è però certezza sul totale: i negativi non vengono comunicati. Le casse mediche Kbv parlano di 35.000 test. Eppure, nessun accertamento è stato compiuto sui 202 pazienti morti per influenza. Non è da escludere, dunque, che qualcuno di loro avesse contratto il coronavirus. Peraltro, stando al racconto di una donna tedesca rientrata dall'Italia, riportato da Berlino magazine, farsi esaminare, nel Paese, non è affatto facile. La signora dichiara di avere accusato sintomi da Covid-19, ma di non essere riuscita a mettersi in contatto con un medico né tramite i numeri verdi per l'emergenza, né raggiungendo di persona il tendone allestito da un ospedale berlinese: si somministrano 60 tamponi al giorno nonostante le file di centinaia di persone (e privatamente, il test costa 300 euro, «ma nessuno sa come si faccia»). Inoltre, segnalava giorni fa Sky Tg24, chi è stato colpito dal coronavirus, ma al momento del decesso soffriva di patologie più gravi, è stato incluso nel conteggio dei morti a causa di quelle altre malattie. Pertanto, le cosiddette «comorbidità» contribuirebbero a diminuire la portata del fenomeno. Più o meno, è lo stesso (mezzo) tentativo fatto in Italia: dopo aver scatenato il panico, il governo aveva avallato l'idea che si muore «con» il coronavirus e non «per» il coronavirus. Da noi, alla fine, ha prevalso l'approccio alla cinese o alla coreana: cercare, attraverso i tamponi, tutti i positivi e quindi associare al Covid-19 i 631 morti registrati fino a ieri. Non significa per forza che siamo più trasparenti: dipende da che via è stata scelta - e perché: meno caos significa meno danni economici. Per di più, in Germania i Länder godono di ampia autonomia in ambito sanitario: è possibile che alcuni utilizzino metodi di calcolo che sottostimano la diffusione del virus. Ufficialmente, i tedeschi attribuiscono i pochi decessi (un'ottantanovenne di Hessen e un settantottenne di Heisenberg) all'età media dei contagiati. Secondo Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute, l'organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive, i positivi, in Germania, «nel 70% dei casi» hanno tra i 20 e i 50 anni. L'età media lì è di 40 anni, in Italia è di 60. Lo studioso, tuttavia, ha precisato che «nelle prossime settimane e mesi» i dati dei due Paesi tenderanno ad allinearsi. È in questo solco che, «per tranquillizzare complottisti scemi e idioti d'ogni genere», s'è mosso il corrispondente eurolirico Udo Gümpel: «Dopo il morto vigile di fuoco amburghese deceduto in Egitto», ha twittato in italiano teutonicizzato, «anche due malati di coronavirus in Germania sono deceduti [...]. Due focolai. Dunque: niente immunità crucca». I tedeschi «sono mortali». Lo stesso Gümpel, in un altro ameno cinguettio, aveva spiegato che gli anziani tedeschi si ammalano di meno perché «hanno molto meno socialità, per esempio bar e ritrovi: socialmente più isolati ma protetti». Più laicamente, il vicepresidente di International Sos, la principale azienda di servizi di sicurezza medica del mondo, interpellato da Fox news, aveva osservato che «il distanziamento sociale potrebbe essere più complicato in culture avvezze al contatto intimo». Se c'è un'epidemia e una nazione algida ne incontra una di baci e abbracci, quella di baci e abbracci è morta... Non si possono non prendere sul serio, però, i riscontri sulle dotazioni del servizio sanitario tedesco. L'ha ricordato il ministro della Salute, Jens Spahn: la Germania dispone di 28.000 posti in terapia intensiva, il dato più alto d'Europa, anche se i letti totali risultano già occupati per l'80%. L'Italia è entrata nel pieno dell'emergenza con 5.100 unità di rianimazione. Probabilmente è questo il superpotere teutonico, che consente una relativa tranquillità, nonostante l'esecutivo di Berlino abbia ammesso l'esistenza di focolai locali (ci sono casi in tutti i 16 Länder), abbia attivato il Piano nazionale antipandemia, abbia richiesto la sospensione degli eventi con più di 1.000 partecipanti, abbia deciso che il match di Champions League, Bayern-Chelsea, si giocherà a porte chiuse e sia orientato a limitare l'accesso agli stadi pure in Bundesliga, con buona pace della Federcalcio tedesca. Nel frattempo, musei, teatri e discoteche restano aperti. E il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha forse lasciato intendere qual è lo scenario che la Germania, tenendo i toni bassi, vuole fugare: «Quanto più lentamente si diffonde il virus, tanto più è probabile che possiamo prevenire una recessione economica». Essere «appestati» costa. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/pero-in-italia-abbiamo-piu-morti-anche-per-carenza-di-posti-letto-2645453863.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="a-roma-un-altro-centro-anti-epidemie-il-problema-e-che-e-chiuso-da-15-anni" data-post-id="2645453863" data-published-at="1769714022" data-use-pagination="False"> A Roma un altro centro anti epidemie. Il problema è che è chiuso da 15 anni Negli ospedali della Lombardia ormai prossimi al collasso si creano reparti di terapia intensiva perfino nei corridoi per cercare di fermare il coronavirus? A Roma, facendo tutti gli scongiuri possibili, si sta cercando, in poche ore, di allestire un circuito parallelo per i malati con Covid-19 per non allargare il contagio e garantire l'assistenza anche ai pazienti delle «normali» patologie? Allo Spallanzani, il centro romano specializzato per le malattie infettive, esiste un ospedale «ad alto isolamento», nuovo di zecca, costruito apposta per affrontare le nuove pesti del terzo millennio. Ma da quindici anni, impeccabile nella sua struttura modernissima, è inutilizzato. Ultimato ma assolutamente, irrimediabilmente, lasciato a fare solo da monumento a se stesso. Le vetrate impeccabili che lo avvolgono riflettono le nuvole e il verde dei giardini. Soprattutto sono lo specchio della strana sindrome da cupio dissolvi, o semplicemente taffaziana, più pericolosa di ogni infezione che da tempo ammorba l'Italia. Un esempio di come pastoie burocratiche insieme a furori giustizialisti riescano ad ingoiare tutto nella pubblica amministrazione ed in particolare nella sanità, malefatte o presunte tali ed eccellenze. La storia è molto semplice. La struttura viene concepita e realizzata nel 2003-2004 ai tempi della Sars sotto l'egida di Guido Bertolaso, sottosegretario al governo Berlusconi con delega alla Protezione civile, che oltre ad essere un grande organizzatore ed essere circondato da un team di prim'ordine, è, combinazione, anche un medico. La Sars, l'altra infezione da coronavirus dilagata dalla Cina dal 2002 al 2004, fortunatamente non ha lo sviluppo da pandemia che si temeva. Ma la struttura ormai c'è. Anche l'ospedale «anti-epidemie» viene inghiottito nell'indagine contro Bertolaso e quella che noi della grancassa mediatica abbiamo chiamato la «cricca». Ma, piaccia o no, si tratta di una grande intuizione scientifico-operativa. Come stiamo scoprendo a costi altissimi in questi giorni le nuove pesti richiedono di avere strutture dedicate, riservate solo a questi malati per evitare il collasso dell'intero sistema sanitario. Così ad esempio nel Lazio, che, Dio non voglia, potrebbe essere investito in pieno dallo «sciame infettivo» del Covid-19, in tutta fretta si sta cercando di allestire un circuito parallelo che fa capo ai tre poli ospedalieri universitari (Umberto I, Tor Vergata, Gemelli) e che non metta a contatto i contagiati con altri, malati per altre patologie o sani che siano. In tutta la sua splendida solitudine di vetrocemento questo fantasma delle buone intuizioni sta lì, 200-300 metri al massimo dallo Spallanzani dove medici, infermieri, pazienti da settimane sono in prima linea sul fronte di questa guerra contro il nemico invisibile. Costato a quanto pare intorno ad una trentina di milioni, chi l'ha visitato dice che ha 10 posti letto di terapia intensiva «ad altissimo isolamento» e 20 posti «ad alto isolamento». Mancano solo le macchine e le attrezzature. «Anche se l'epidemia da coronavirus penso finisca prima, almeno lo spero, che possa essere resa funzionante», dice una fonte medica, «è evidente che una struttura così potrebbe essere molto utile nell'emergenza attuale». A quanto è dato sapere mancano i collaudi: l'opera formalmente non è ancora stata collaudata. Insomma, passaggi burocratici. Chi scrive nel 2014 ai tempi di Ebola per il Tg5 realizzò un servizio nel quale l'allora responsabile della Protezione civile (competente sulla struttura) assicurò: entro sei mesi l'ospedale ad alto isolamento sarà perfettamente funzionante. «La verità è che è finito nel tritatutto della Protezione civile», dichiara una fonte medica che vuole restare anonima, «non sono passati sei mesi ma sei anni e non è stato fatto nulla». «È una struttura di assoluta eccellenza, all'avanguardia in Europa e nel mondo», riconoscono alla Protezione civile. E dunque? «Da un po' è partito il collaudo tecnico-amministrativo ovvero la verifica degli atti. Il collaudo funzionale lo abbiamo completato, l'ultimo step è stato il collaudo dei reflui», fanno sapere. Insomma è stata realizzata a regola d'arte. «Le lungaggini? Sono dovute al fatto che dopo l'emergenza del 2003 si sono seguite le procedure ordinarie». Ah beh… «Nel Milleproroghe», continuano, «sono già stanziate le risorse perché la Regione Lazio la faccia funzionare». Tempo previsto per il trasferimento dalla Protezione civile alla Regione: settembre. Speriamo non del 2035.
(Ansa)
La riforma consta di otto articoli, sull’ultimo dei quali - «Disposizioni transitorie» - tornerò alla fine. Gli altri sette modificano gli articoli 87, 102, 104-107 e 110 della Costituzione. Sembrerebbe la modifica di sette articoli e infatti le lamentele del Comitato per il No esordiscono proprio così: «Questa legge modifica sette articoli della Costituzione». Il che, pur apparentemente vero, è sostanzialmente sonoramente falso e fuorviante. Il Comitato per il No esordisce manipolandovi col trasmettere il messaggio angoscioso che la riforma governativa stravolgerebbe la Costituzione. Una comunicazione levantina che da sola basterebbe a togliere ogni fiducia a chi invita a votare No.
La verità sostanziale è che si modificano solo due articoli, mentre gli altri sono solo adeguati per coerenza. Per esempio, visto che nei due veri articoli modificati si istituiscono due magistrature governate, ciascuna, dal proprio Consiglio superiore, l’articolo 87 - che attualmente recita: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm» - diventa: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm giudicante e il Csm requirente». Simili considerazioni valgono per gli articoli 102, 105, 106 e 110. Gli articoli veramente modificati sono il 104 e il 105. La riforma disciplina tre cose.
L’esordio dell’articolo 104 - «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» - diventa: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». È finalmente introdotta la separazione delle carriere: così come l’avvocato che vi difende non è collega del giudice che deve emettere sentenza, anche la pubblica accusa non lo sarà più. Ove l’articolo vecchio continua assegnando la presidenza dell’unico Csm al capo dello Stato, quello nuovo si adegua, istituisce due Csm e mantiene il capo dello Stato a presiederli entrambi. Ecco attuato il principio del giusto processo, in ottemperanza all’articolo 111 della Costituzione.
Secondo il vecchio articolo, gli altri componenti (attualmente 24) sono «eletti» per 2/3 dai magistrati e per 1/3 da una lista che il Parlamento compone tra professionisti di lungo corso del diritto. Nell’articolo modificato dalla riforma, la parola «eletti» è sostituita con le parole «estratti a sorte».
L’articolo 105 attuale recita: «Spettano al Csm le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Il nuovo articolo 105 è molto più lungo, col primo comma quasi coincidente con l’intero articolo vecchio: «Spettano a ciascuno dei due Csm le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati». Come si nota, le parole «le promozioni» sono sostituite con le parole «le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni»; e sono state soppresse le parole «provvedimenti disciplinari» del vecchio articolo. Cosa significa? Significa, intanto, che ove la vecchia legge parla solo di «promozioni», la nuova parla di «valutazioni di professionalità». Ora, non voglio qui rivangare la brillante carriera dei giudici che hanno distrutto la vita di Enzo Tortora, solo perché non voglio dare l’impressione che quella del caso Tortora sia l’eccezione che conferma una regola: temo che sia invece la regola. Ancora: a leggere l’attuale articolo 105, suona quanto mai bizzarro che eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di un magistrato siano affidati a coloro che quel medesimo magistrato ha eletto. E, infatti, come osservavo a mo’ di esempio, quelli coinvolti nel caso Tortora, lungi dal subire provvedimenti disciplinari, fecero invece brillante carriera. Nel resto del nuovo art. 105, la riforma istituisce allora un’Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici professionalmente qualificati: «Tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica» e gli altri 12 sono, di nuovo, tutti estratti a sorte: sei sono della magistratura giudicante, tre della magistratura inquirente e tre da un elenco di professionisti di lungo corso del diritto nominati dal Parlamento. I membri dell’Alta Corte non possono essere membri di nessun Parlamento (regionale, nazionale o europeo) né possono esercitare professione di avvocato. Infine, chi è soggetto a provvedimenti dell’Alta Corte può impugnarli solo dinanzi alla medesima Corte e, in questo caso, essa giudica in assenza dei componenti che hanno concorso alla decisione impugnata.
La prima lamentela del Comitato per il No è che la riforma assoggetterebbe il Csm al governo e/o al Parlamento. Ora, ditemi voi, come possa mai accadere che, passando da un meccanismo elettivo a una estrazione a sorte, chicchessia possa meglio influenzare sull’esito finale. Anzi, l’estrazione a sorte tra i titolati a far parte dei due Csm o dell’Alta Corte è l’unica cosa che garantisce che la scelta dei componenti sia avvenuta senza alcuna influenza esterna. Allora, chi vi dice che la riforma introduce, rispetto alla vecchia legge, maggiore controllo del potere politico, vi sta manipolando, vi sta mentendo, e vi sta togliendo il potere di scegliere. Né è vero che gli scelti per votazione sono i più «bravi»: sono solo quelli che hanno avuto più voti.
Le «Disposizioni transitorie», poi, prevedono che le leggi sul Csm, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate entro un anno alla nuova norma costituzionale. Allora, non solo con la nuova legge l’ingerenza della politica sulla magistratura è ridotta, ma codesta presunta ingerenza non è di alcun beneficio all’attuale esecutivo, che sarà a scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della riforma.
Continua a leggereRiduci
Una seduta del Csm (Imagoeconomica)
Battute a parte, resta la notizia e cioè che ieri il Tar del Lazio ha dato torto ai criticoni: il referendum si terrà nella data fissata dal governo, quindi domenica 22 e lunedì 23 marzo. Per i giudici amministrativi le preoccupazioni del No non avevano senso, non c’era alcuna prevaricazione e soprattutto il tempo per informare i cittadini è assolutamente congruo. Del resto, lo stesso capo dello Stato Sergio Mattarella non aveva avuto problemi a firmare la delibera che fissava la data, alla quale si era giunti dopo una mediazione di equilibrio.
Pertanto non ci saranno sorprese: si va dritti sul 22 e il 23 marzo, nel senso che la decisione del governo, secondo il Tar, non è un atto «lesivo e illegittimo» e non «rappresenta di fatto l’espropriazione del diritto dei cittadini di raccogliere le firme». La decisione dei giudici amministrativi è tanto più importante se si pensa che è avvenuta con sentenza e non con ordinanza, il che - per dirla in soldoni - rafforza la stessa, poiché non si ferma al solo congelamento del ricorso (cioè la richiesta di sospensione cautelare) ma entra anche nel merito delle questioni sollevate dai 15 giuristi che avevano promosso l’iniziativa. Insomma il governo e il fronte del Sì vincono abbondantemente su tutta la linea.
Questo ci permette allora di riprendere quanto nei giorni scorsi Alessandro Sallusti aveva già scritto, illuminando un aspetto fondamentale. Perché - si domandava - così tanto affanno da parte dei promotori nel chiedere la sospensione cautelare rispetto alla data fissata dal governo? Perché chiedere il posticipo, denunciando lesioni di diritti a danno dei cittadini? Ecco, Sallusti ci indicava una ragione che alla luce della sentenza del Tar del Lazio si fa ancor più condivisibile. Al fronte del No, quello che sta raccontando di pm che verrebbero assoggettati al potere politico (da qui la campagna pubblicitaria nelle stazioni e non solo…), interesserebbe arrivare al rinnovo del Csm con le vecchie regole; perciò spingeva a posticipare il referendum: buttare la palla in tribuna e guadagnare tempo.
In effetti, quand’anche il referendum convalidasse la riforma del governo - come sembra dai recenti sondaggi - poi ci sarà bisogno dei decreti attuativi, cioè di quelle leggi che «fanno camminare» le buone intenzioni legislative. Una vittoria del Sì il 22 e il 23 marzo velocizzerebbe tali norme blindandole in un calendario favorevole al rinnovo del Csm secondo le nuove regole. Un posticipo del referendum avrebbe invece ritardato tali tabella di marcia. Ci sono dieci mesi circa per impostare il rinnovo del Csm che va a scadenza tra un anno: se tutto filerà liscio a quel punto avremo un Csm per i giudici e uno per i pm, con l’azzeramento dei giochi tra le correnti perché gli organi di autogoverno sarebbero compilati secondo il sorteggio.
Ritardare il referendum avrebbe vanificato questa operazione anche in caso di vittoria dei Sì perché le procedure di rinnovo sarebbero state fatte con le vecchie regole e quindi… Buonanotte ai suonatori. La decisone del Tar del Lazio - che ripeto è entrato nel merito delle questioni sollevate dai 15 giuristi promotori spazzandole via - dà indirettamente ulteriore smalto ai promotori del Sì e ci consentirà di entrare nel vivo della campagna al netto degli allarmismi creati ad arte. Questa riforma è un passo avanti in una ridefinizione della giustizia rimettendola su binari più consoni, facendo invece deragliare (con la procedura del sorteggio) il treno del correntismo togato. La riforma del Csm è il cuore della legge costituzionale su cui ci esprimeremo e - ora più che mai - siamo convinti che proprio per questo le anime più politicizzate stanno dicendo e facendo cose bizzarre, dai post del segretario alla richiesta di rinvio del referendum.
Continua a leggereRiduci
Ecco #DimmiLaVerità del 29 gennaio 2026. Il grande esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela un dettaglio inedito della escalation Usa-Iran.
Danni causati dal ciclone Harry sul lungomare di Catania (Ansa)
Può sembrare strano, considerata l’estensione delle nostre coste e che fenomeni del genere, quindi, andrebbero annoverati tra le calamità. Eppure, nella normativa c’è questo vuoto che espone le aziende al rischio di non aver nessun rimborso dalle assicurazioni, anche dopo essersi impegnate economicamente per tutelarsi da possibili disastri. È prevista la copertura contro le inondazioni ma non contro le mareggiate», spiega il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
Una dimenticanza nella preparazione della norma prevista dalla legge di Bilancio 2024? Eppure, il governo ha puntato sul meccanismo delle polizze catastrofali come strumento per evitare che il costo dei danni ricada prevalentemente sul bilancio pubblico, considerata la frequenza dei fenomeni naturali estremi nel nostro Paese. La norma, lo ricordiamo, prevede l’obbligo, per le imprese, di stipulare una polizza per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Le aziende che non si assicurano contro eventi catastrofali perdono l’accesso a contributi pubblici, agevolazioni e incentivi fiscali. Quindi è una misura strategica che, però, «arrivata al primo banco di prova, rischia di fallire», afferma Gronchi.
Le scadenze per dotarsi di una polizza sono state scaglionate: 31 marzo 2025 per le imprese grandi con oltre 250 dipendenti, 30 settembre 2025 per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti), mentre per tutte le micro e piccole imprese l’obbligo era stato posticipato al 31 dicembre 2025. Il Milleproroghe ha poi spostato l’obbligo a fine marzo prossimo per alcune categorie come la ricezione e il turismo, cioè alberghi, bar e ristoranti. «Si può quindi creare la situazione paradossale che in un immobile danneggiato ci siano differenti trattamenti; magari c’è un negozio che è stato obbligato a sottoscrivere una polizza mentre un bar aveva il tempo per farlo fino a fine marzo. È una norma che ha svariate incertezze», afferma Gronchi, sottolineando che «molte imprese hanno difficoltà ad avere i preventivi dalle assicurazioni. Abbiamo un pezzo di imprese senza copertura assicurativa perché la scadenza della sottoscrizione è stata spostata in avanti, mentre altre che non riescono a capire se, pur avendo una polizza, saranno o meno coperte, dal momento che i danni sono da mareggiate e non da inondazioni».
Le problematiche non finiscono qui. Il presidente di Confesercenti evidenzia il rischio che «chi non ha polizza non possa avere accesso a eventuali aiuti pubblici. La normativa dice che, in caso di catastrofe ambientale, l’impresa non assicurata non potrà richiedere ristori o contributi per la ricostruzione. In pratica l’imprenditore dovrà ripagare i danni mettendo mano al proprio portafoglio. Non solo. Senza polizza, l’azienda è considerata fragile e questo può portare al rifiuto di prestiti da parte delle banche o a tassi d’interesse più alti».
Confesercenti si è mossa per dare un aiuto alle aziende in difficoltà. «Abbiamo attivato un plafond complessivo di 2,5 milioni per prestiti agevolati destinati alle imprese siciliane, calabresi e sarde per gestire l’emergenza». L’intervento più strategico è nella lettera che Gronchi ha inviato al premier Giorgia Meloni, nella quale chiede di spostare al 30 giugno la scadenza dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza. «Servirebbe a superare le incertezze. Abbiamo bisogno di tempo per far in modo che il meccanismo funzioni. L’Italia è territorio fragile e senza lo strumento delle polizze catastrofali, che affianchino l’intervento dello Stato, non si va da nessuna parte. In Sicilia ci sono oltre 1.000 imprese concentrate tra Messina e Catania colpite dal ciclone Harry, con danni per 750-800 milioni. Senza contare i danni al patrimonio pubblico».
Poi c’è il capitolo delicato degli stabilimenti balneari, le strutture più danneggiate. «Avendo le concessioni scadute e con l’incertezza dell’esito della direttiva Ue Bolkestein, sono penalizzate dalle banche perché il loro futuro è incerto e potrebbero avere difficoltà nell’accesso al credito».
In questo caos c’è anche il fronte delle assicurazioni. Al pressing del governo per spingerle a rimborsare le imprese danneggiate, l’Ania, richiamando la legge, sottolinea proprio quanto evidenziato dalla Confesercenti, ovvero che le mareggiate e i danni provocati dal vento restano fuori dalla lista degli eventi coperti dalle polizze. A meno che le imprese non abbiano sottoscritto polizze più ampie di quelle obbligatorie, includendo anche le mareggiate, non c’è possibilità di ricevere i rimborsi.
Continua a leggereRiduci