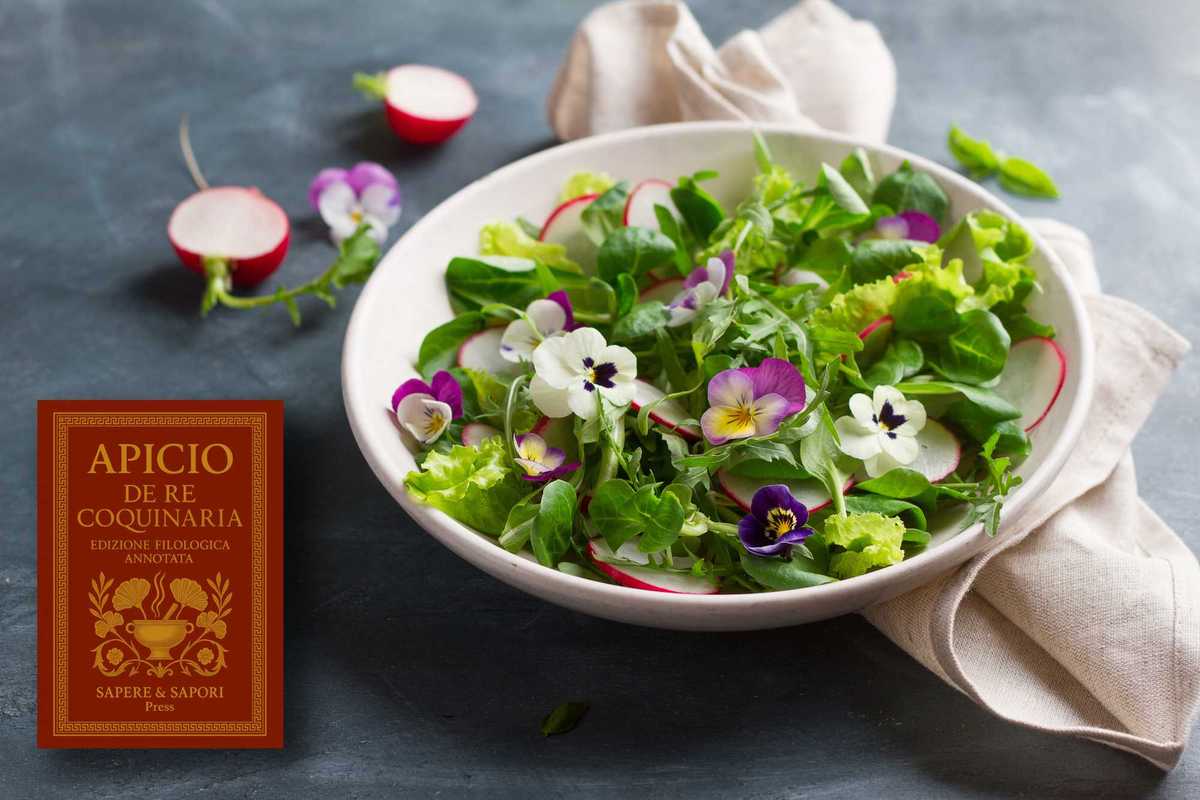- Ieri Ursula von der Leyen ha annunciato un rapporto della Commissione «sullo stato di diritto dei Paesi membri»: le decisioni interne saranno sottoposte a un giudizio politico e i ribelli di fatto commissariati. Chi non seguirà l'agenda di sinistra verrà punito.
- Le Raccomandazioni europee sui tagli alla spesa incluse nelle nostre linee guida.
Lo speciale contiene due articoli.
Ursula von der Leyen ha gettato la maschera. Nel suo speech all'Europarlamento (pomposamente ribattezzato, sul modello Usa, discorso sullo stato dell'Unione), la presidente della Commissione Ue ha adottato un'agenda fortemente spostata a sinistra, provocatoria per tutti i gruppi a destra del Ppe, e apertamente ostile verso i governi sgraditi. Al contrario, non sono mancati assist e carezze per gli esecutivi allineati a Bruxelles (a partire dall'attuale maggioranza italiana), ma a un prezzo sempre più chiaro: il progressivo commissariamento politico di molti Paesi, ben al di là delle condizionalità economiche previste dal Recovery fund.
Ecco il passaggio cruciale, quello in cui la von der Leyen ha preannunciato la prossima arma di Bruxelles: «Prima di fine mese, la Commissione presenterà un rapporto sullo stato di diritto per tutti gli Stati membri». E il primo a capire dove la tedesca intendesse andare a parere è stato -non a caso - un polacco, espressione di uno dei governi sotto tiro, e cioè Ryszard Legutko, presidente del gruppo conservatore.
Il tema aveva già fatto capolino nelle discussioni sul nuovo bilancio Ue, anche in quel caso attraverso una sottolineatura del rapporto tra finanziamenti Ue e stato di diritto. A prima vista, si tratta di un richiamo nobile e di principio: chi potrebbe essere contrario? Ma, a un esame meno ingenuo, il punto è che non esistono atti normativi inequivoci che possano fungere da parametro di riferimento. Morale: è fortissimo il rischio di valutazioni politiche, arbitrarie e discrezionali. Di recente, ad esempio, proprio la Polonia è stata sottoposta a misure punitive (addirittura fino alla minaccia di privarla del diritto di voto) per una riforma giudiziaria nazionale che subordina per alcuni profili la magistratura all'esecutivo. È evidente che su un tema del genere - comunque la si pensi - le valutazioni tenderanno a essere sempre più opinabili e politiche che non freddamente giuridiche o ancorate a benchmark oggettivi. Dunque, ha molte ragioni chi teme che il richiamo allo stato di diritto possa trasformarsi in una frusta per colpire i governi riluttanti ad allinearsi al mainstream Ue.
Ma la von der Leyen non si è fermata qui, anzi. Ci sono stati almeno altri cinque passaggi del suo discorso che vanno interpretati.
Il primo è stato il preannuncio della volontà di costruire «un'unione della sanità»: «Con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l'Europa c'è». Ed è abbastanza intuitivo che su questa base il pressing per spingere l'Italia nel Mes si farà di nuovo martellante.
Il secondo è stato il passaggio sull'ambiente, ad altissima densità «gretina», con obiettivi sempre più impegnativi: adesso la von der Leyen vorrebbe un «taglio delle emissioni del 55% entro il 2030», e non solo del 40%. Il che rischia di creare una bomba fiscale e regolatoria a danno delle imprese europee, con relativa perdita di competitività.
Il terzo passaggio è stato quello sull'immigrazione: «Aboliremo il regolamento di Dublino. Lo rimpiazzeremo con un nuovo sistema europeo di governance delle migrazioni. Avrà strutture comuni per l'asilo e i rimpatri», insieme a «un forte meccanismo di solidarietà». Ma qui la tedesca è rimasta nel vago, né si vede come potrà superare quel regime di volontarietà che in sostanza, fino a oggi, ha consentito a molti Paesi di disimpegnarsi, lasciando il fardello sulle spalle dell'Italia.
Qui la von der Leyen ha colto l'occasione per aggredire Nicolas Bay (francese del gruppo sovranista Identità e democrazia) e Joerg Meuthen (tedesco di Afd, del medesimo gruppo). Per Bay «l'asilo è diventato una filiera per l'immigrazione clandestina» e i richiedenti asilo «non vengono qui per sfuggire alle guerre», ma «per ragioni economiche e sanno che potranno rimanere qui a causa del vostro lassismo». La von der Leyen ha dato fondo al repertorio più classico dei pregiudizi anti destra: «Noi siamo convinti che ogni essere umano abbia una dignità. L'estrema destra ha un'altra visione: quella per cui ci sono diversi tipi di esseri umani, e gli altri devono essere affrontati con l'odio».
Il quarto passaggio delicato è stato quello sui temi etici: «Chiederò il riconoscimento mutuo dello status familiare in tutta Europa. Se si è genitore in un Paese, lo si è in tutti». A questo proposito, il deputato della Lega Vincenzo Sofo ieri ha presentato un'interrogazione al Parlamento europeo chiedendo se la Commissione vuole «vincolare l'uso dei fondi del Next generation Eu da parte degli Stati all'attuazione di politiche pro immigrazione e Lgbt».
Il quinto passaggio significativo della tedesca è stato infine quello per preannunciare «una proposta per sostenere gli Stati nel creare uno schema per i salari minimi». Progetto che è un obiettivo esplicito del ministro Nunzia Catalfo.
Ce n'è abbastanza affinché la sinistra tenti di usare tutto questo armamentario per blindarsi al governo, a partire dall'Italia. E infatti il presidente dell'Europarlamento David Sassoli ha subito chiosato: «Serve stabilità per tutti i governi europei per concretizzare il Recovery fund».
Il Recovery plan accoglie i vecchi diktat pro austerità
Già all'indomani del 27 maggio, quando la Commissione presentò il piano Next generation Eu (Ngeu) e, ancor di più, il 21 luglio, giorno dell'accordo politico in sede di Consiglio europeo, facemmo notare che si stava sovrastimando la sua rilevanza e ne evidenziammo i difetti: pochi soldi veri, erogati lentamente, e soggetti a condizioni potenzialmente dannose per il nostro Paese.
Leggevamo con meticolosità gli atti e le bozze dei regolamenti, senza pregiudizi. Oggi abbiamo la ben magra soddisfazione di trovare conferma dei nostri rilievi nell'atto ufficiale con cui il governo ha trasmesso al Parlamento le linee guida del piano per la ripresa e la resilienza, dichiarando la propria disponibilità a riferire alle Camere e assicurando il loro pieno coinvolgimento nelle fasi successive di elaborazione e approvazione dei singoli progetti.
Accanto al sogno della transizione ecologica e digitale, fa capolino un vecchio arnese della Commissione: le «Raccomandazioni Paese», adottate dal Consiglio a luglio 2019 per un governo non proprio amico e che, secondo l'esecutivo, «la Commissione considera ancora rilevanti ai fini della risposta di policy agli squilibri macroeconomici dell'Italia». Si tratta di cinque punti in cui spiccano la richiesta di assicurare una riduzione della spesa pubblica, di ridurre l'evasione fiscale vietando l'uso del contante (cosa c'entra il contante con gli 1,25 miliardi incassati nel 2019 da un solo accertamento fiscale a un grande gruppo del lusso?), di utilizzare entrate straordinarie (condono e patrimoniale?) per ridurre il rapporto debito/Pil e diminuire il peso delle pensioni di vecchiaia. Non mancano gli investimenti in ricerca, la riduzione dei tempi della giustizia civile (per velocizzare gli espropri dei beni dati in garanzia alle banche da famiglie e imprese piegate dalla crisi?) e l'invito alle banche a proseguire nella svendita di crediti deteriorati, avviata nel 2016.
Allora vien da chiedersi quale crescita sarà mai possibile in queste condizioni. Quale potrà mai essere il beneficio netto sul Pil delle maggiori spese sussidiate dal Ngeu e delle misure recessive che ci vengono richieste? Lo sapremo a fine mese, quando sarà pubblicata la nota di aggiornamento al Def che rischia di somigliare al passo del gambero per i due seguenti motivi:
1 La Nadef conterrà le previsioni per il 2021, tenendo conto del Ngeu che però vedrà giuridicamente la luce solo a inizio anno. Motivo per cui la legge di bilancio potrà contenere maggiori spese di cui non sarà ancora certa la fonte di finanziamento. Ammesso e non concesso che i piani siano approvati dalla Commissione entro aprile, arriverà subito un insignificante anticipo di 6,4 miliardi (10% dei 64 miliardi di sussidi del Rrf) e i successivi pagamenti semestrali potrebbero subire il «freno di emergenza» del Consiglio per ulteriori tre mesi. L'effetto macroeconomico potrebbe essere davvero modesto.
2 I 209 miliardi si stanno sciogliendo come neve al sole. Ci sono tempi relativamente certi, ma lunghi, solo per i 64 miliardi di sussidi del Rrf. I residui 17 dovrebbero provenire da altri strumenti (Reacteu in primis) i cui tempi sono indeterminati. Gli altri 127 miliardi sono prestiti e il governo è stato costretto ad ammettere che, per rispettare la traiettoria di rientro «raccomandata» da Bruxelles, potrebbero finanziare prevalentemente spese già comprese nel deficit attuale. È come se avessimo deciso di mettere a bilancio la spesa per ripristinare gli intonaci e dalla Ue arrivassero prestiti per rifare gli infissi. A quel punto, o mettiamo a bilancio anche queste ultime spese, tagliando le prime (opzione preferita dal governo), in modo da non far esplodere il deficit complessivo, o rinunciamo a rifare gli infissi. In ogni caso, l'effetto sulla crescita è pari a zero, in quanto non si genera deficit aggiuntivo.
Next generation Eu promette di essere, per la gran parte, solo uno strumento di finanziamento (alternativo al Btp) di un bilancio costretto a ridursi.