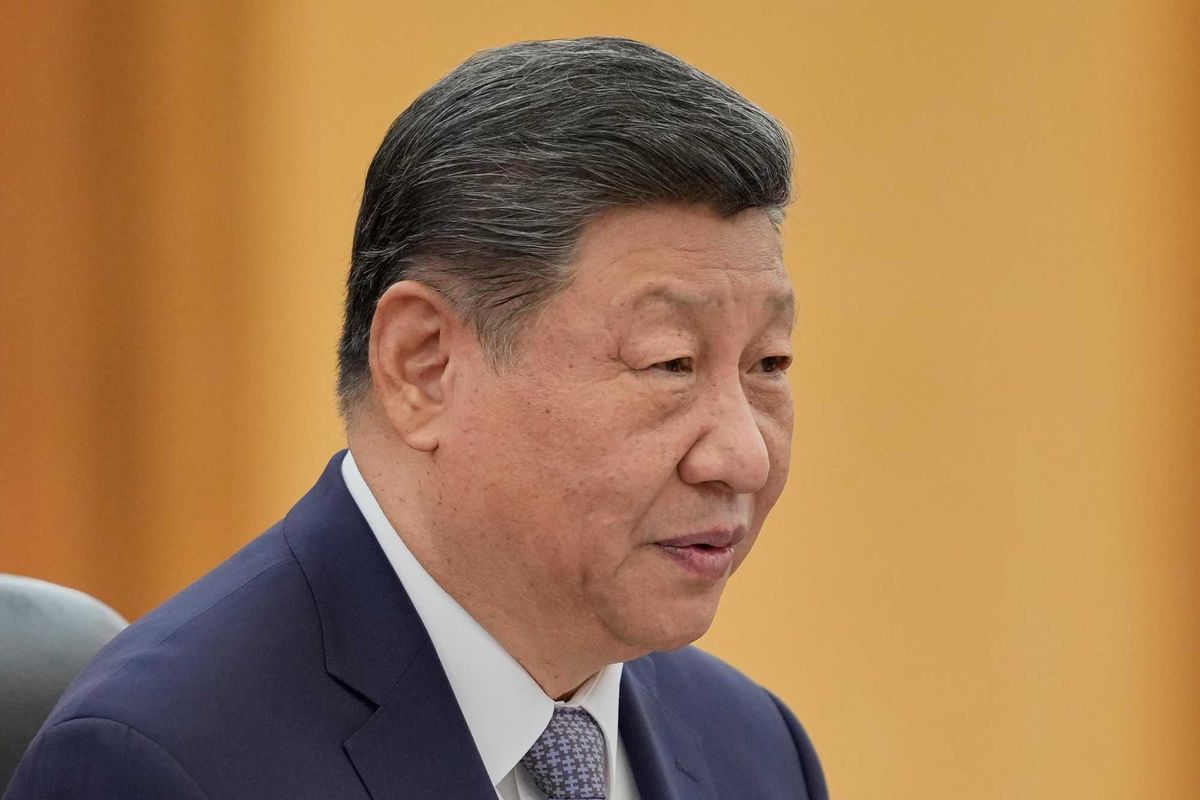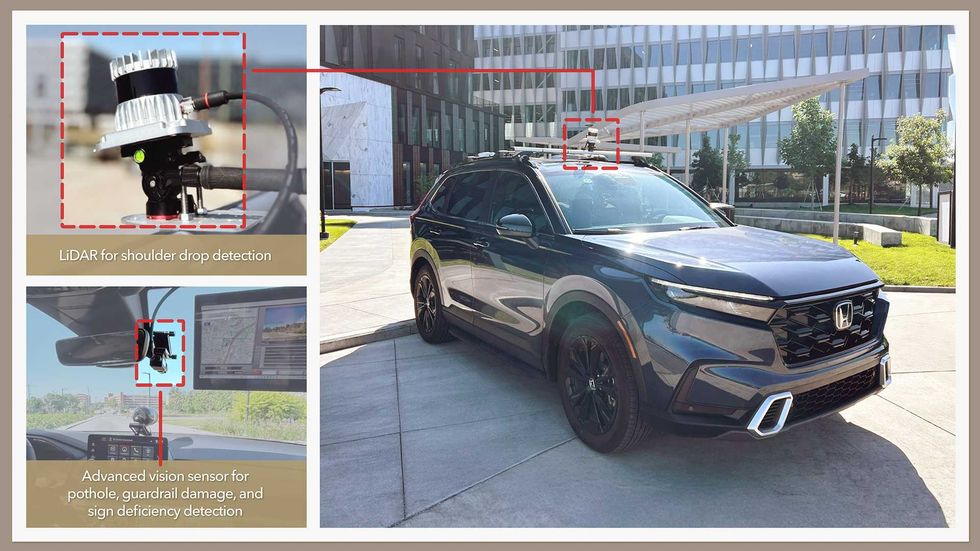Parigi e Berlino si rifanno la Difesa con i soldi di tutti (e senza Roma)

L'Italia ha chiesto di partecipare al progetto francotedesco per la costruzione di un carro armato di nuova generazione e si è sentita rispondere picche: quando avremo definito i requisiti e la spartizione dei lavori tra industrie francesi e tedesche, allora forse vi contatteremo. Il caso specifico pone un problema sistemico.
Nel bilancio Ue sono previsti almeno 13 miliardi per finanziare progetti industriali «europei» per la «Difesa europea» e molti di più per programmi civili che però sono riportabili al settore militare, tutti con anche soldi dell'Italia che è il terzo contributore al budget dell'Ue. Il progetto di carro francotedesco sarà classificato «europeo» e riceverà soldi dall'Ue, anche italiani, pur avendo escluso l'Italia? La risposta potrebbe essere che il budget europeo finanzia progetti collaborativi tra nazioni europee, non necessariamente tutte. Ma non sarebbe rassicurante. La pressione di Parigi per ottenere che il Commissario con delega alla Difesa europea sia francese fa sospettare che la Francia voglia finanziare con soldi degli altri europei progetti a dominio industriale francese, spartiti solo con i tedeschi. Se così, carro armato a parte - comunque meglio farlo con britannici, baltici e americani, anche per il potenziale di esportazione - va segnalato un pericolo maggiore per l'industria spaziale italiana. In parte è già dominata da quella francese, così come la Francia prevale nell'Agenzia spaziale europea, ma in parte maggiore è ancora autonoma e costituisce un pezzo qualificato della ricchezza tecnologica nazionale, sesta potenza spaziale nel mondo. Ci vuole un chiarimento. Francia e Germania potrebbero accusare l'Italia di aver scelto il Regno Unito per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, il Tempest, invece che il loro. In realtà l'Italia non è stata invitata. E non poteva esserlo perché inserita in una logica industriale incompatibile. Germania e Francia non adottano il caccia americano F35 di quinta generazione, mentre Londra sì oltre a condividere con Roma (e Berlino) l'Eurofighter mentre Parigi ha in linea il Raphale che è prodotto solo nazionale. Probabilmente lo F35, a cui Roma e Londra partecipano industrialmente, sarà portato a «generazione 5,5» sul piano della connettività che trasforma in battaglia tra reti informative la classica guerra aerea. L'anglo-italiano Tempest ne sarà probabilmente uno sviluppo predisposto alla piena interoperabilità con le future reti di osservazione e di dominio dell'aerospazio globale statunitensi. Avrà l'industria italiana il diritto di accesso al finanziamento europeo pur ingaggiata con un partner extra Ue?
Se sì, allora la posizione italiana potrebbe essere accomodante: noi con i nostri soldi facciamo le nostre cose, voi francotedeschi fate le vostre, ma solo con i vostri denari. E sarebbe conveniente per l'Italia perché ci sono dubbi sulla capacità tecnologica francese e tedesca in alcuni settori che rendono razionale cercare partner britannici e statunitensi, dove, per altro, con i primi Roma condivide l'interesse ad avere forza negoziale nei confronti del Pentagono e dell'industria militare statunitense.
Se no, se l'intento è quello di privilegiare l'industria francotedesca nonché di costringere la Difesa italiana a comprare i suoi oggetti militari senza partecipazione industriale italiana, allora il chiarimento dovrà essere dissuasivo: veto, motivato dal criterio che i soldi europei debbano finanziare programmi paneuropei e non selettivi per la difesa. Il chiarimento, poi, dovrebbe estendersi alla posizione geopolitica, in particolare, della Francia. L'Italia, citando Sergio Mattarella, ha una posizione di convergenza sia europea sia atlantica. Quindi se la Francia rompe la convergenza euroamericana, l'Italia certamente dovrà opporsi. Prima che si sfaldino le due principali alleanze che sono moltiplicatori di forza per l'Italia, Ue e Nato, è importante che Roma spinga per un chiarimento. Non chiedo iniziativa a questo governo che è troppo confuso, ma al Quirinale.