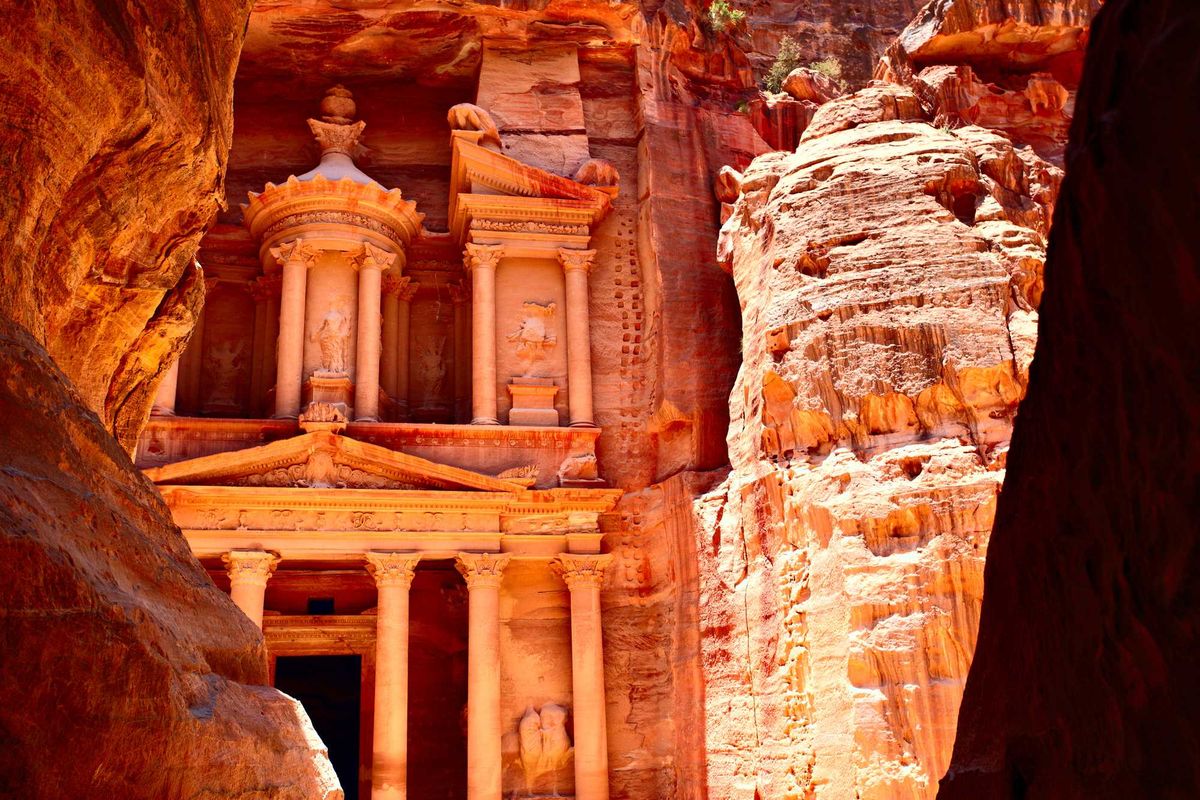La caduta silenziosa del nuovo Muro di Berlino rischia di essere gravida di conseguenze tanto quanto la prima. La crisi della Turingia, scatenatasi con il «nein» di Angela Merkel all'alleanza strategica tra Cdu e Afd nella elezione del nuovo governatore Thomas Kemmerich, rischia di essere già - priva ancora che si dispieghino tutti i suoi sviluppi - il fatto politico più rilevante sia per la Germania sia per l'Europa.
Arrivano, con la clamorosa evaporazione della leadership di Annegret Kramp-Karrenbauer (durata praticamente un anno, in un partito abituato alla lunga durata degli Adenauer, dei Kohl e ovviamente delle Merkel), al pettine tutti i nodi di un sistema costruito su un estremismo conservativo, più che conservatore. Pochi libri, anche al netto di un indubbio livore personale, descrivono questo assetto più di Il sistema Merkel, di Gertrud Höhler, tradotto in Italia da Il Saggiatore ormai sette anni fa ma clamorosamente attuale per leggere anche ciò che può accadere di qui in avanti nel cuore dell'Europa.
Definita (da Limes) con efficacia chirurgica «egemone riluttante», la leadership della Cdu ha incarnato per un ventennio un cauto e lento trasformismo teso a ridefinire un generico afflato liberale, in fondo privo di una sostanza ideale che non fosse la difesa strenua delle coordinate economiche su cui è stata costruita l'unione monetaria. Il resto è pragmatismo assoluto, come ampiamente dimostrato sulla crisi ucraina, sui rapporti con Cina e Russia, e nella gestione cocciuta dello scontro economico di lungo periodo con gli Stati Uniti. Un cozzo acuito dalla muscolarità incontrollabile di Donald Trump, ma che sarebbe proseguito (ed eventualmente proseguirà) con qualunque presidenza.
«Se non si trova una strategia accettabile per il superamento della crisi, anche l'attuale potere economico tedesco potrebbe trasformarsi presto in un'illusione. Per i mercati, infatti, è breve la distanza che separa l'idea che l'egemonia tedesca costituisca una garanzia di sopravvivenza per l'euro e l'opinione che la Germania sia essa stessa concausa del problema. In questo senso, o Berlino riesce a salvare l'eurozona oppure verrà risucchiata e travolta dai suoi guai», scriveva lo studioso Hanns Maull, autore di un saggio chiarificatore sulle coordinate della politica estera di Berlino.
La dissoluzione di Akk, tramonto matrioska dentro il lunghissimo declino della Merkel, mostra che siamo a questo bivio. Ma, appunto, non è una faccenda soltanto tedesca. Per almeno tre motivi.
Il primo è tedesco: la crisi si è aperta sull'atteggiamento da tenere nei confronti di Afd, specchio perfetto della stantia dicotomia populisti/antipopulisti, e del quesito irrisolto su che fare con i primi. L'accoppiata Cdu-Spd, simbolo dell'offerta politica «di sistema», sta subendo, proprio grazie alle grandi coalizioni, la stessa gelata che interessa tutta l'Europa: osservare il tracollo della somma di voti di Pdl e Pd in Italia, Ppe e Psoe in Spagna, socialisti e gollisti in Francia negli ultimi 10 anni, non può non far sorgere il leggero sospetto che siamo di fronte a un tratto comune, e non deve sorprendere neppure l'interrogativo sui rapporti da tenere con le varie Lega, M5s, Podemos, Marine Le Pen in tutta Europa. Fingendo di essere all'oscuro dell'accordo in Turingia, i vertici della Cdu hanno sacrificato - per mano della Merkel, unico esemplare politico vivente reo sia di parricidio sia di infanticidio politico - una leader in provetta, ma la questione si riproporrà da qui a giugno, mese della selezione del successore di Akk: gli elettori di Afd, in massima parte espressione del disagio economico e sociale dei Länder dell'Est, sono fuori dall'arco costituzionale, un accidente della storia che occorre sanificare, o un fatto con cui fare i conti, così come l'ascesa dei Verdi?
Il secondo motivo si profila guardando l'Europarlamento. La Cdu è il perno, numerico e geopolitico, del Ppe con i suoi 29 deputati. La già irrisolta tensione manifestatasi sul caso Orbán («populista» ma indispensabile) arriverà ai massimi proprio su questo frangente. La crisi del liberalismo come assetto neutro di valori, diritti e procedure sufficienti a garantire benessere, sicurezza e «posto nel mondo» per milioni di persone di fatto coincide con la crisi della Cdu, per il peso che la prassi politica di questo partito ha determinato nel definirne le coordinate.
Il terzo è, se possibile, ancora più rilevante, e riguarda il futuro dell'euro e dell'Unione europea. Al momento sono quattro i nomi che potrebbero contendersi il primo partito d'Europa: il «continuista» Armin Laschet, governatore del Nordreno Westfalia, il rivale più estremo della Merkel, Friedrich Merz (che potrebbe «coprire» il partito a destra: voleva la Grecia fuori dall'euro), il ministro della Salute, l'omosessuale Jens Spahn, alle prese con il coronavirus. Quarto, l'outsider alleato: Markus Söder, presidente della Csu che reclama il proprio turno alla guida dell'alleanza.
Le prospettive terree aperte sull'economia mondiale dall'emergenza del morbo cinese, che arrivano sull'onda di una possibile nuova crisi migratoria, sono l'ennesimo appuntamento cui la storia chiama l'egemone riluttante. Ci sono decisioni radicali, per il futuro di un continente (geopolitica, unione monetaria, banche), da anni all'affannosa caccia di decisori all'altezza. Che la Cdu ne sappia esprimere è una faccenda che riguarda tutti noi.