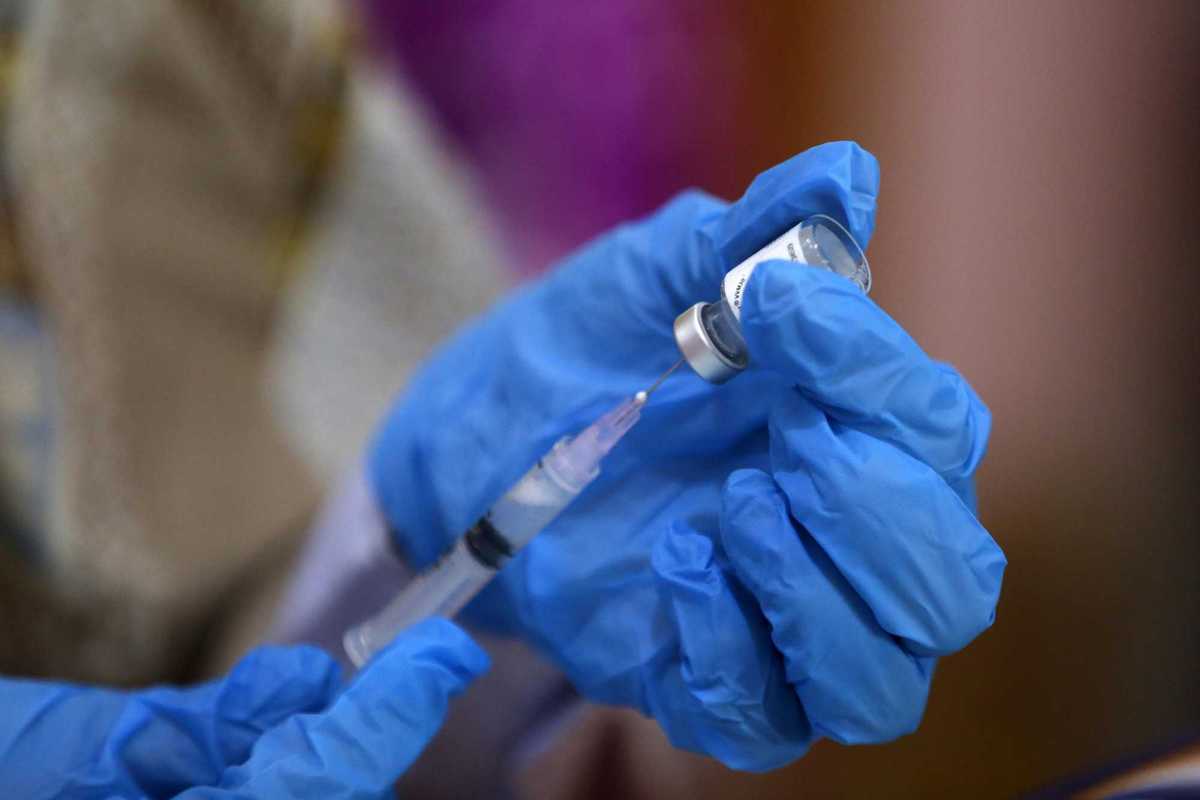Il governo italiano è pro nucleare, ma ancora non si sa quando farà un passo in direzione dell’atomo. L’altro ieri la Francia ha lanciato una iniziativa a Stoccolma per coinvolgere Romania, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Croazia, Paesi Bassi e Finlandia in una filiera di sviluppo del nucleare di ultima generazione.
La rappresentanza italiana non ha partecipato. Il titolare del dicastero della Transizione ecologica, ora Mase, Gilberto Pichetto Fratin, ha detto che sarebbe bene esserci ma prima bisogna sentire la posizione del Parlamento. È scoppiata la tempesta. Reazioni anche in casa Lega e titoloni sui giornali. Trascorse 24 ore, colei che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia, il vice ministro Vannia Gava, ha una posizione molto diversa. «Sugli sviluppi del nucleare di nuova generazione ho avuto, a margine del Consiglio europeo Energia di Stoccolma, un positivo confronto con la collega francese Agnes Pannier-Runacher», ha detto anche alla Verità. «L’idea di un’alleanza dei Paesi che già usano il nucleare come fonte di energia decarbonizzante è interessante. Ho confermato che l’Italia guarda con grande attenzione a questa scelta strategica, parte integrante peraltro del nostro programma elettorale. Purtroppo scellerate scelte del passato ci mettono in condizione di rincorrere il futuro, ma ce la faremo», ha aggiunto il viceministro del Carroccio.
Che è successo? Da quanto risulta alla Verità, Gava aveva altri impegni d’agenda e non poteva fermarsi a Stoccolma. Il che aprirebbe un secondo tema. Perché si è permesso che si sviluppasse una tempesta in un bicchiere d’acqua? La comunicazione inerente l’atomo è da tempo un argomento bollente per il ministero. Già ai tempi di Roberto Cingolani i passi falsi e la gaffe hanno costituito una piccola collezione. L’esempio più interessante è quello dello scorso settembre, quando il manager di Leonardo scelto da Mario Draghi per il Mite se ne uscì con una forte e legittima critica agli ambientalisti radical chic. Di fatto Cingolani spiegò che l’atomo non può più essere un tabù. Perfetto, finalmente una posizione innovativa. Peccato che sia durata meno di tre giorni. Il 4 settembre, infatti, sterzò dicendo di non avere «nessuna proposta da fare». «Ho parlato agli studenti degli studi che si stanno conducendo, ma ad oggi», aggiunse, «non c’è una tecnologia». Il chiarimento del ministro, se così si può definire, arrivò dal forum Ambrosetti dopo la netta bocciatura anche da parte di Enel. Su questo tema «non è realistico pensare a una riconsiderazione», aveva affermato appunto l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace. Il timore è che la situazione ancora non sia cambiata rispetto allo scorso anno. Tanto più che Cingolani - è bene ricordarlo - è rimasto su volere del premier Meloni e su suggerimento di Draghi al ministero, in qualità di consulente. Speriamo che la linea Gava prosegua e si cerchi di prendere atto di quanto sta accadendo anche nel mondo delle aziende private.
Da un report firmato Mckinsey, infatti, si vede che nel 2011-2015 gli investimenti sulla fusione nucleare di aziende private sono stati nel complesso 420 milioni di dollari a livello globale. Nel quinquennio successivo la cifra è salita a un miliardo e mezzo. Soltanto nel 2021 il pacchetto di fondi destinati a progetti di start up nucleare ammontava a 4,4 miliardi e il 2022 è a sua volta in leggera crescita. A fronte di tali importanti numeri non c’è stata dispersione. Tra il 2015 e il 2020 le aziende impegnate sono state 25. Stesso numero nel 2021, a fronte di quasi tre volte il valore degli investimenti messi a terra. Da quando gli scienziati negli Stati Uniti hanno portato a una svolta storica nella fusione, a metà dicembre dello scorso anno - in quell’occasione, è stata per la prima volta prodotta più energia di quanta se ne sia consumata fondendo isotopi di idrogeno - la fusione si è spostata al centro dell’attenzione politica come fonte di energia pulita e sicura. Ieri Gauss Fusion ha annunciato la chiusura del primo round di finanziamenti. Si tratta del primo vero progetto tra privati mirato a realizzare entro il 2045 una centrale a fusione (elettrica) da un gigawatt. Al consorzio greentech partecipano una azienda francese, una spagnola, le tedesche Bruker e Ri reserach. >Per l’Italia c’è Asg Superconductor, della famiglia Malacalza, che ha dalla sua l’esperienza della partecipazione in Iter. È chiaro che si tratta di una start up, ma è anche il segno che il mercato è pronto alla svolta: la collaborazione con le università non è più soltanto un tema di pura ricerca.
Anche il governo dovrà prenderne atto: certo, dovrà interrogare il Parlamento ma anche avviare una campagna di sensibilizzazione e di chiarimento. Eni è impegnata in interessanti progetti americani assieme al Mit di Boston: iniziative in grado di portare effetti significativi. Il nucleare di nuova generazione è, al di là delle vecchie fonti, la sola in grado di far muovere un Paese industrializzato e garantirgli la permanenza nel G7. Altrimenti avremo una transizione ecologica capace di abbinare soltanto due parole: ambiente e povertà.