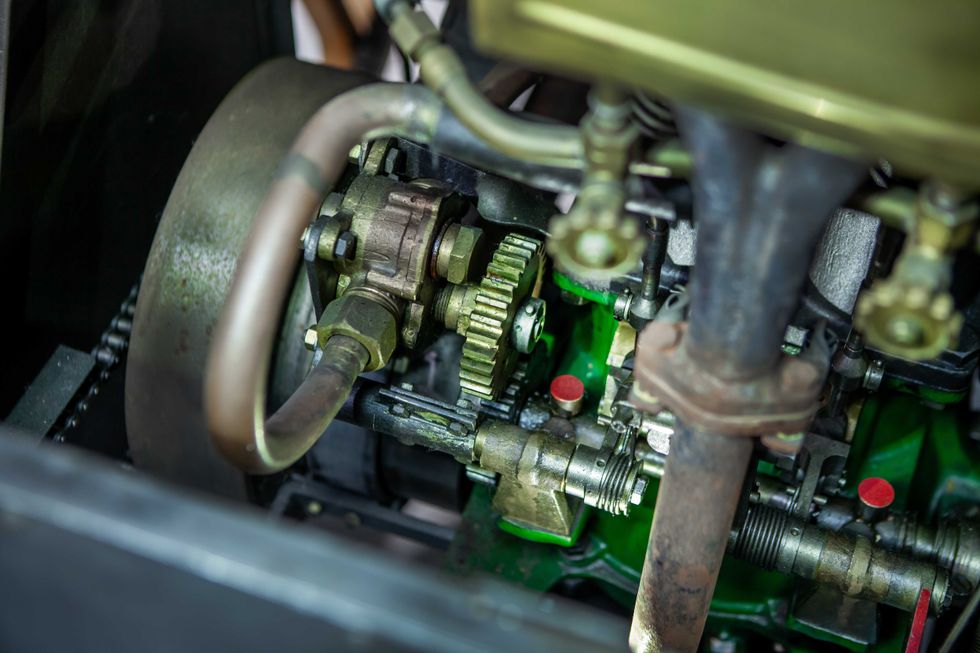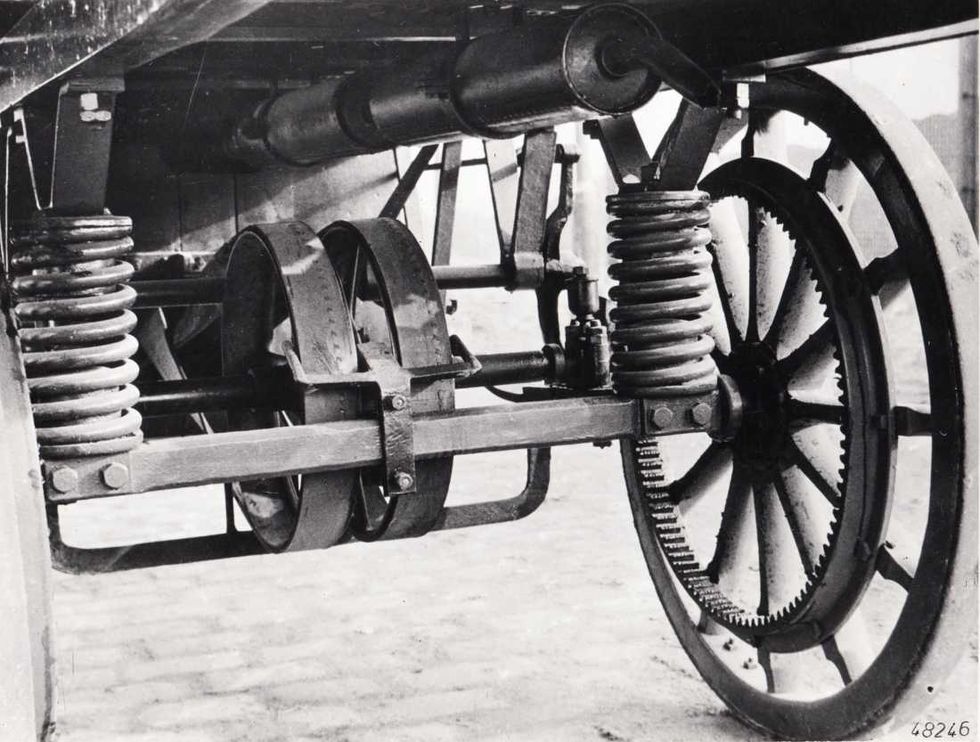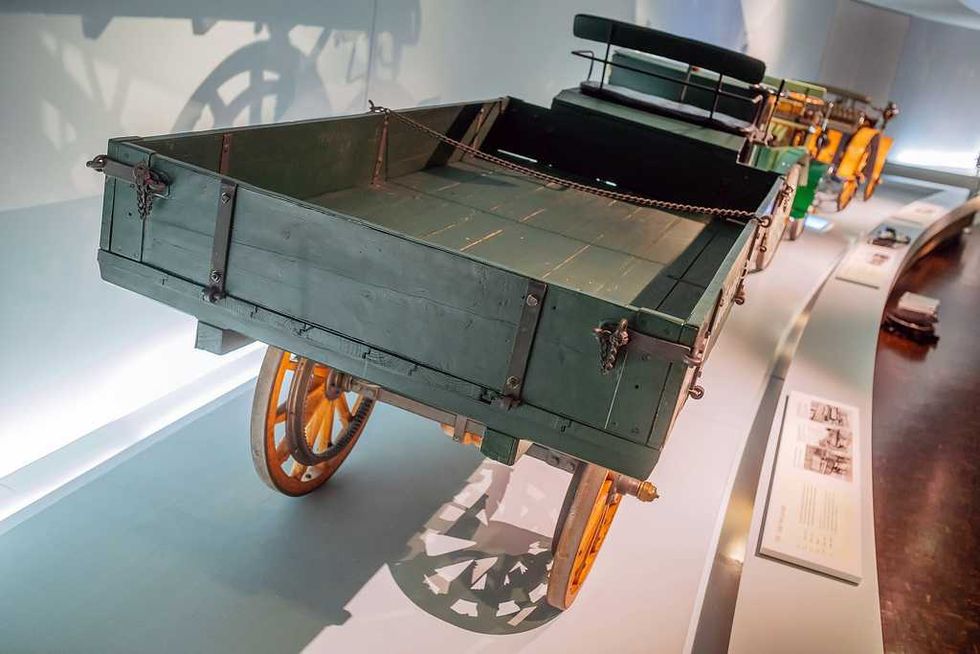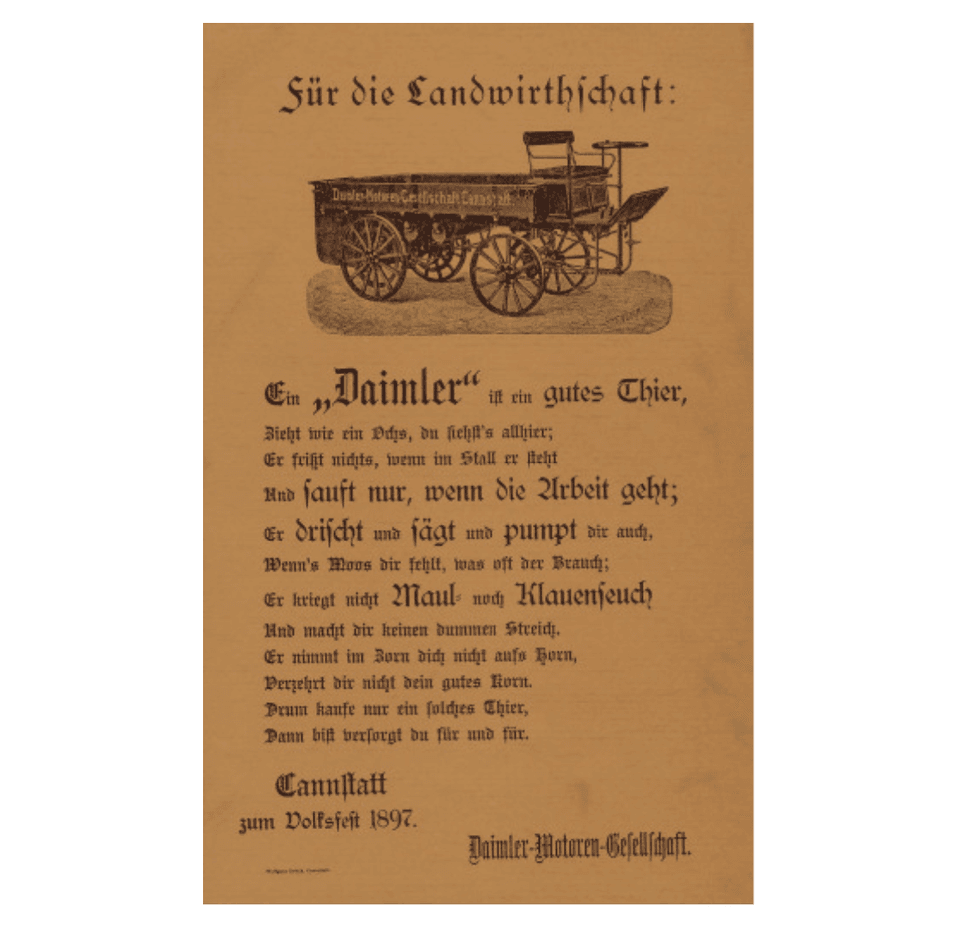Il no del Cio ai controlli sul sesso è una novità introdotta solo nel 2021

Quattro miliardi di buoni motivi per far prendere a pugni le ragazze. È il contributo che il governo francese dà alle Olimpiadi di Parigi (budget totale 8,8, in crescita); è il prezzo che il Cio paga alla svolta inclusiva e resiliente; è il costo del cinismo per accontentare Emmanuel Macron, primo sponsor dei Giochi arcobaleno mondiali. Gli alti papaveri dello sport guidati dal presidente Thomas Bach hanno colto il vento progressista, hanno accettato il compromesso e hanno deciso di cambiare le regole d’ingaggio per partecipare alle competizioni.
Ora nelle conferenze stampa di Parigi viene ripetuto il mantra: «Il sesso e l’età degli atleti si basano sul loro passaporto». Andare oltre sarebbe violazione della privacy. Ma non è sempre stato così. Né riguardo alle atlete transgender (ancora oggi non ammesse alle gare femminili dalle federazioni internazionali, come nel caso della nuotatrice Lia Thomas), e neppure riguardo alle atlete «intersessuali» come la pugile algerina Imane Khelif e la sua collega taiwanese Lin Yu Ting che rispettivamente oggi e domani disputano le finali da favorite. Nel 2019 la Corte di arbitrato dello sport (Cas) sostenne che le persone con condizioni Dsd (differenze di sviluppo sessuale con testosterone superiore alla tipica gamma femminile) erano «biologicamente maschi».
Così recita la sentenza del caso Caster Semenya, mezzofondista sudafricana. Allora la Cas riconobbe che «la discriminazione contro alcune donne è un mezzo necessario, ragionevole e proporzionato per preservare l’equità delle gare». Proprio per evitare pasticci, l’anno scorso la federazione mondiale di atletica (Athletics world) ha rafforzato le regole di ammissibilità per atlete Dsd chiedendo loro di abbattere i livelli di testosterone sotto il 2,5 (nanomoli per litro di sangue) per sei mesi, con trattamento di soppressione degli ormoni. Identica mossa ha compiuto la federazione mondiale del nuoto, evidentemente consapevole del palese vantaggio.
Sulla boxe il Cio ha tirato dritto, defenestrando l’Iba (International boxing association) che aveva squalificato Khelif e Lin Yu Ting ai Mondiali e lanciando la sua nuova Agenda olimpica. I cui dieci principi sono: inclusione, prevenzione dei danni, non discriminazione, equità, nessuna presunzione di vantaggio, approccio basato sull’evidenza, primato della salute, approccio centrato sugli stakeholder (quelli che pagano), diritto alla privacy, revisioni periodiche. È evidente che per salvaguardarne alcuni «politici» sono stati calpestati quelli più «sportivi» come l’equità e i vantaggi indebiti. Tutto ciò senza alcuna intenzione di approfondire i controlli. Al punto 7.2 del capitolo riservato alla salute si legge: «I criteri per determinare il genere non includono il test sessuale o simili esami invasivi, atti a stabilire il sesso di un atleta e la variazione di genere».
Tutto questo era immaginabile. Bastava leggere le «Linee guida sulla rappresentazione dello sport», vademecum che somiglia a un saggio di Laura Boldrini, affidato al «Gender equality review project» del Cio medesimo, nel quale non si parla mai di competizioni ma si discetta con sussiego di «modalità di rappresentazioni di genere», di «responsabilità collettive», di «atlete e atleti con variazioni delle caratteristiche del sesso». Dove il gender è diventato centrale anche in pista, in pedana, sul tartan. Nello scritto (che varrà anche per le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina) si legge che «il Cio è consapevole che i Giochi costituiscono un’incredibile vetrina per mostrare l’universalità e la diversità dello sport alle persone di tutto il mondo, in particolare alle donne in ogni loro diversità e alle altre persone che appartengono a minoranze».
Il contesto ha indotto il Cio a «ridefinire gli standard» e ad andare oltre il genere. «Perché le donne non sono un gruppo omogeneo, né sono definite esclusivamente dalla loro identità di genere». Il paragrafo a pagina 5 è chiarissimo, sottolinea che «la diversità e l’intersezionalità fra diversi gruppi sono considerate e rispettate». Nel memorandum sono contenute anche le buone pratiche inclusive alle quali giornalisti e fotografi accreditati sono consigliati di attenersi (non si sa con quali conseguenze in caso di disubbidienza). Un paio sono da Oscar del surrealismo: evitare immagini passive e sexy per non rafforzare gli stereotipi; non scrivere di una nuotatrice «è la futura Michael Phelps» ma «è un’atleta straordinaria».
In avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi, il Comitato arcobaleno ha tenuto anche un forum permanente per sostenere gli atleti transgender e intersex, per far sì che potessero «competere affermando la loro identità e il loro benessere». Business is business. Com’è facile passare dai Mondiali di calcio in Qatar, dove parlare di semplice parità di genere era una bestemmia, ai match di boxe fra donne a Parigi, dove avanzare perplessità sugli uppercut molto maschili di due pugilatrici viene ritenuto un violento esercizio di sessismo. «Hanno l’allungo di Carlos Monzon», la considerazione meriterebbe subito una reprimenda dal Cio. Ma non dai bookmaker, che danno alla pari Khelif e a 5 la sua avversaria taiwanese, manco fosse Cenerentola. Maschilisti.